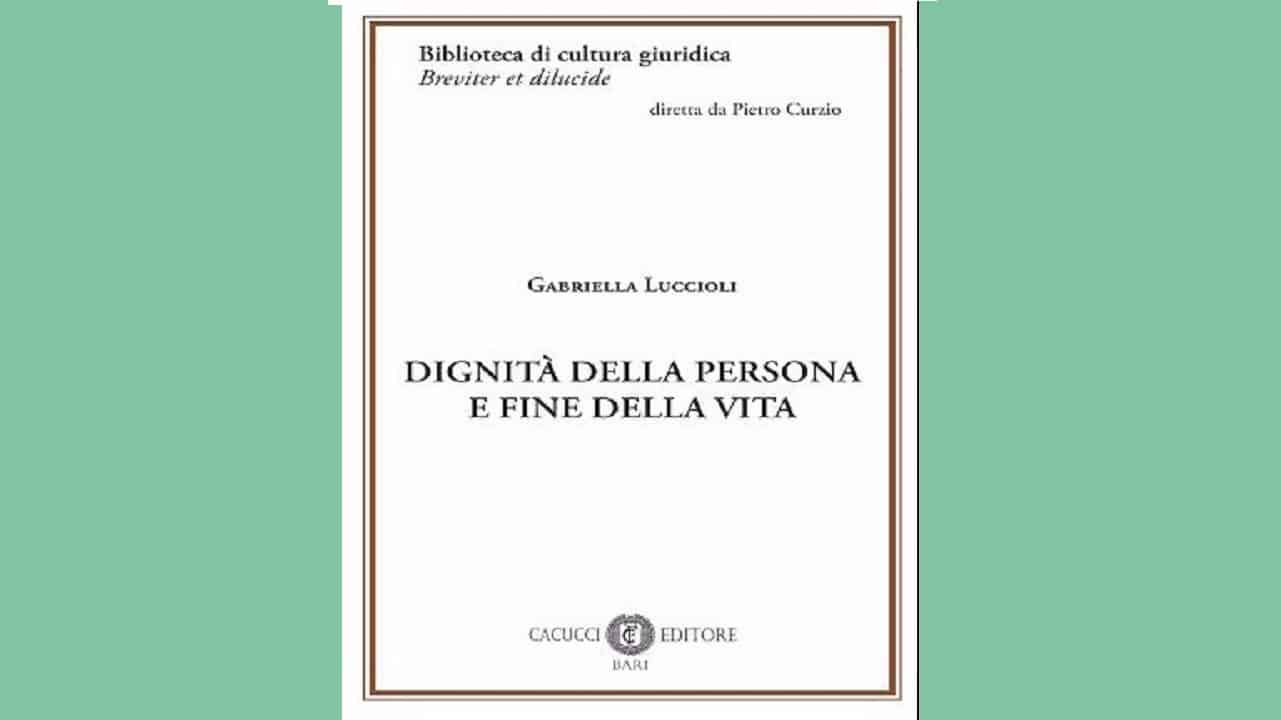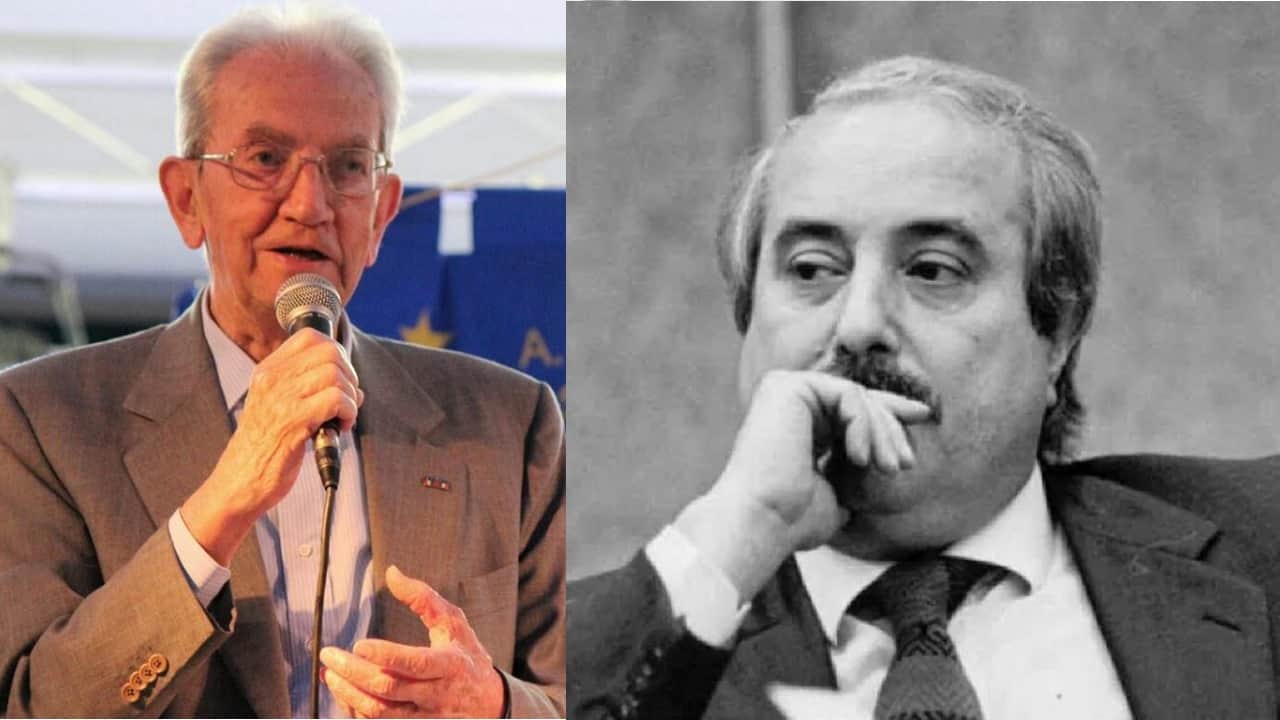Sulla strada di “Diritto verità giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia", Cacucci, 2021- a cura di L. Cavallaro e R.G. Conti*
di Roberto Conti
Nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù dice di essere venuto al mondo per rendere
testimonianza alla verità, Pilato domanda: «Che cosa è la verità?»
È l’eterna domanda che può trovare risposta soltanto nella verità, non in una
spiegazione o definizione della verità? La verità è. «Io sono colui che sono». E
così la verità è colei che è. Il potere ne vuole spiegazione allo stesso modo che
della menzogna in cui si inscrive può darne.
[L. Sciascia, Nero su nero, Torino, 1979, 216]
…ci sono delle verità – frantumi, come di specchio, di una ignota verità – che, una volta scoperte o incautamente confessate, possono avere echi imprevedibili o molteplici, effetti liberatori o micidiali: e sono le verità che rovesciano o disgregano le apparenze, le «menzogne convenzionali»
[L. Sciascia, Alfabeto pirandelliano, in Opere, a cura di P. Squillacioti, Milano, 2019, Vol. II, Tomo II, 972]
A mio Padre
Sommario:1. Alle origini di una curatela a quattro mani in nome di Leonardo Sciascia - 2. L’alfabeto sciasciano: legge, giustizia, udienza (e verità) - 3. Sciascia alla ricerca del ruolo della verità - 4. Una, nessuna, centomila verità - 5. La dimensione individuale e quella collettiva del diritto di – e del dovere alla – verità - 6. Verità e complessità del diritto - 7. Scienza, diritto e letteratura a confronto con la verità e con il giudicare - 8. Il potere della magistratura - Sciascia, Livatino e la sicilitudine - 9. Il giudice Sciascia - 10. Il non giudice Sciascia - 11. La giustizia ed il sentimento ambivalente di Sciascia - 12. La vicenda del mostro di Marsala e la metafora delle veritù.Nessuna certezza sul pensiero sciasciano e tanti dubbi.
1. Alle origini di una curatela a quattro mani in nome di Leonardo Sciascia
Tre ragioni mi hanno spinto a condividere con Luigi Cavallaro la curatela di un volume dedicato a Leonardo Sciascia.
La prima è essenzialmente di natura familiare.
Vuole infatti, essere un modo per ricordare la memoria di mio padre, avvocato civilista e amante delle buone letture. E proprio in quella che fu la sua libreria, nell’abitazione in cui crebbi, in un pomeriggio domenicale di circa tre anni fa, in visita a mia madre, quasi nascosti fra Silone, Pratolini, Hemingway, Fallaci, Gramsci, Fenoglio, Garcia Lorca, Pavese, Montale, Calvino e Moravia, intravidi i piccoli volumetti di Sciascia.
Prelevai, tra Porte aperte, Todo modo e Il giorno della civetta, il più nascosto e meno visibile, Il contesto.
Mi colpì, immagino per evidente deformazione professionale, l'immagine di copertina che riproduceva uno schizzo di Giudice seduto sullo scranno.
Mi immersi così nella lettura e rimasi calamitato dai luoghi, dalle persone, dalle descrizioni, dal detto e il non detto. Un centinaio di pagine, un intrigo poliziesco, con al centro l'uccisione di una decina di giudici che l’Ispettore Rogas ricollegò subito ad un caso di possibile errore giudiziario a carico di Cres – personaggio descritto meticolosamente ma mai apparso –. Approfittando dunque del riposino di mamma e del viaggio di ritorno in treno, quell’11 febbraio 2018 – come riporta il biglietto ferroviario ritrovato nel libro – proseguii la lettura del piccolo libretto che si fece sempre più incalzante.
Mi passarono davanti figure descritte in modo straordinario, le mani del giudice Azar, '...mani scarne, incordate di arterie, maculate come pietre di lichene...', la personalità di accusati di delitti mai commessi e alla fine assolti, di giudici, di alti magistrati, gli accenni immediati e diretti all’ineluttabilità del “problema della giustizia e dell’ingiustizia che tante inquietudini aveva creato a Sciascia, fin da ragazzo[1] tanto da fargli dire, nella iconica intervista rilasciata al Prof. Claude Ambroise[2], che
“Tutto è legato, per me, al problema della giustizia: in cui si involge quello della libertà, della dignità umana, del rispetto tra uomo e uomo. Un problema che si assomma nella scrittura, che nella scrittura trova strazio o riscatto…”[3]
Ma in quella lettura, allora, colsi solo in parte la profondità, complessità e centralità dell’opera di Sciascia, sulla quale si sono giustamente concentrati anche altri autorevoli giuristi[4].
Mi colpì moltissimo un aggettivo a me fino a quel momento sconosciuto nel significato che Sciascia gli aveva attribuito, parlando delle mani del giudice Azar incordate di arterie. Mi sembrò allora che quel personaggio fosse letteralmente uscito dal libro e si fosse materializzato innanzi a me con le sue mani. Pensai, forse banalmente, che quell’aggettivazione racchiudeva non solo una straordinaria conoscenza del lessico italiano ed una cura del linguaggio – che mi apparve, a posteriori, manifesta in Occhi di capra – ma prim’ancora un’esperienza di vita legata ai luoghi natii di Sciascia, alla lontananza dal continente, al radicamento indissolubile della gente isolana con il territorio e la sua crudezza.
Più di recente trovai conferma di quella ricercatezza dell’Autore nella scelta delle parole allorché, intervistato da Ambroise, Sciascia dichiarava:
“Sì, la parola: la singola parola che suggerisce, suggestiona, si apre come un ventaglio, dispiega immagini”.
Fu dunque l’inizio di una scoperta più matura – ma sempre in punta di piedi – di uno scrittore siciliano che in una famiglia di gens de Justice ben radicata in Sicilia alla quale appartengo non poteva, fin dall’adolescenza, che continuamente comparire e scomparire, essere apprezzato e criticato, anche aspramente quando mio padre parlava di attualità e di politica. Lui che da Presidente dell’ordine degli avvocati di Agrigento per quasi un decennio aveva infiammato i colleghi con la sua potente oratoria.
Apparizioni comunque emotivamente diverse da quelle dell’altro scrittore e drammaturgo agrigentino, Pirandello, per me più direttamente collegate al periodo liceale, alle rappresentazioni teatrali ricorrenti al Supercinema, alle giornate di studio organizzate in città per commemorarlo dal Professore Enzo Lauretta, alla riflessione sulla ricerca dell’essere alle quali noi studenti del corso A eravamo instradati dall’indimenticato Professore d’italiano del Liceo Classico Empedocle Nino Picone Chiodo, anche lui, forse non casualmente, racalmutese come Leonardo Sciascia, anche lui Maestro per noi studenti liceali, condotti per mano sul terreno del ragionare, a volte anche ironico, del riflettere sul senso della letteratura.
Approccio dunque diverso rispetto a quello riservato al più contemporaneo – ed allora vivente – Sciascia, scrittore-intellettuale-politico, pure lui come il primo tessitore di grovigli esistenziali[5] ma più del primo – e forse non casualmente – fonte di ispirazione per rappresentazioni cinematografiche ed anche protagonista di veementi campagne politiche e di stampa, mediaticamente collegate a fatti spesso clamorosi ed intrighi irrisolti della storia italiana.
Non sarà dunque un caso che le sue opere abbiamo dato linfa vitale al c.d. cinema civile – basti pensare a film come A ciascuno il suo di Elio Petri (1967), Il giorno della civetta di Damiano Damiani (1968), Una vita venduta – ispirato a L’antimonio (1976) di Aldo Florio – fino a Cadaveri eccellenti di Francesco Rosi (1976) – tratto da Il contesto – Porte aperte (1990) di Gianni Amelio, Una storia semplice (1991), L’uomo che ho ucciso – liberamente tratto da 1912 +1 di Giorgio Ferrara (1995) – e Consiglio d’Egitto (2002), entrambi di Emidio Greco.
Né sembra essere senza significato il fatto che Sciascia, pur ombroso, schivo e di poche parole, sordomuto[6] probabilmente amasse – “per il loro valore mediale”[7] – essere intervistato con la sigaretta eternamene accesa, fornire senza mai risparmiarsi le sue risposte – recte, le sue verità – alle domande dei suoi interlocutori, tutte orientate a spiegare le sue opere, i contesti, i sensi, i riferimenti, quasi a volere mostrare, attraverso plurime interpretazioni autentiche, chiarezza e trasparenza rispetto agli itinerari complessi ed inesplicabili che, fra il detto ed il non detto, rendono le letture di Sciascia tanto impegnative quanto metaforiche.
Il caso volle che dopo due giorni da quella lettura, mentre camminavo in uno dei lunghi ed austeri corridoi della Corte di Cassazione incontrassi Pietro Curzio, allora presidente della sesta sezione civile e nello scambiare due parole non riuscii a frenare l’istinto di condividere l’esperienza recente che avevo fatto riavvicinandomi a Leonardo Sciascia.
Mai avrei immaginato che qualche anno dopo il mio interlocutore sarebbe diventato Primo Presidente della Corte di Cassazione, incarnando uno dei ruoli che Sciascia aveva così plasticamente tratteggiato. E mai sarebbe in me balenata l’idea di potere contribuire ad una riflessione così importante come quella che gli autori del volume hanno creato.
La seconda ragione che mi conduce a Sciascia è essenzialmente legata ad una forte vocazione alla curiosità che crebbe quando Luigi Cavallaro mi propose di condividere quel progetto editoriale.
Mi chiesi e richiesi più volte il perché di quell’invito, proveniente da un profondo conoscitore di Sciascia e prim’ancora della sua terra natia. E pur non avendola ancora oggi pienamente trovata, ma comunque provenendo anch’io dalla natia Agrigento, ancorché meno legato alla sicilianità, non foss’altro che per le mie origini meticce – in parte bergamasche ex latere matris – decisi di accettare, incuriosito dall’idea di mettere davanti a Sciascia l’esperienza professionale di alcuni fra i giuristi più insigni del panorama contemporaneo.
Mi domandai, immediatamente e ancora di più dopo i primi concistori con Luigi, divisi fra Roma e Racalmuto, cosa sarebbe potuto uscire fuori da quella che a me apparve essere davvero una ricerca sistematica mai compiuta prima, un itinerario a più corsie che stavamo tentando di tracciare perché fosse percorso parallelamente, ma separatamente, da quegli autorevoli “lettori” delle diverse opere di Sciascia che alla giustizia avevano contribuito parecchio, ciascuno in prospettive ed ambiti particolari e non sovrapponibili.
La matrice comune di questa grande strada era dunque quella della giustizia o per meglio dire, prendendo a prestito un’espressione usata dallo stesso Sciascia, della nevrosi della giustizia[8].
In effetti, proprio quell’approccio originario a Il contesto mi aveva fatto balenare il convincimento che Sciascia avesse una grande fame di giustizia, per le menzogne che alimentano a volte una verità giudiziaria falsa, ma comunque verosimile – icasticamente dimostrate ne La strega e il capitano[9] –per le ingiustizie, alcune reali, alcune immaginate, altre spinte volutamente fino all’eccesso, al paradosso, alla parodia o anche solo alla rievocazione storica di processi a dire di Sciascia ingiusti, nei quali non si distinguono “…l’uccisore dall’ucciso, il boia dalla vittima, il torturatore dal torturato, la gioia dal dolore[10].
Quanto quella nevrosi fosse derivata da ingiustizie subite in prima persona o da persone a lui care – come ipotizza Collura – non è dato sapere, pur tornando alla mente il pensiero del Cardinal Martini che individua il seme del senso di ingiustizia nell’ingiustizia subita “o da noi o da chi ci è caro e che consideriamo parte di noi”[11].
E proprio lo spaccato non proprio edificante del pianeta giustizia che dal primo all’ultimo elemento veniva fuori dal Contesto, pittato – per dirla con un’espressione del dialetto siciliano al quale Sciascia prestò particolare attenzione – come inadatto ad offrire risposte di giustizia che un’umanità spesso dolente attendeva, pur consapevole della loro fallacità e delle a volte intrinseche, pervicaci e ostinate illogicità, giustificava davvero, ai miei occhi, l’esigenza di farsi promotori di un’iniziativa che arricchisse il già importante osservatorio di saggi monografici per il tramite di un volume capace di offrire, per l’autorevolezza degli Autori coinvolti e per le opere individuate come oggetto delle riflessioni stesse, un valore aggiunto.
Ecco dunque uno dei possibili “sensi” della ricerca volta ad approfondire il pensiero di Sciascia con il coinvolgimento, oltre che di Paolo Squillacioti che di Sciascia è uno dei più raffinati conoscitori, di autorevoli giuristi – Irti, Luccioli, Donini, Galliani, Serio, Lupo, Mammone – che pure con il linguaggio hanno dimestichezza al di fuori del genere letterario usandolo però, al pari del nostro, quotidianamente per esprimere opinioni, giudizi, riflessioni sulle “cose di diritto”.
I frutti di questa ricerca appaiono per più versi potenzialmente fecondi proprio perché chiamano a rivisitare Sciascia che a più riprese espresse forti riserve sul ruolo della giustizia e dei suoi attori. Una ricerca, dunque, riservata ai protagonisti, diversi ovviamente per ruolo e funzioni, di un settore al quale Sciascia sembra anelare al punto di affermare che non vi è mondo senza giustizia, ma al contempo guardare nella sua dimensione concreta con aspro disincanto.
Ma accanto a questa e prima di questa esigenza proiettata verso una dimensione a me esterna, ero andato maturando un bisogno, tutto personale, cresciuto nel foro interno, di saperne di più, di approfondire la conoscenza, di farmi un’idea su Sciascia che mi avrebbe in definitiva riavvicinato a mio padre, alle sue letture, alla sua passione per la giustizia. Una passione, la sua, diversa da quella da ma vissuta in trent’anni di magistratura che tuttavia sentivo e sento importante ricordando il “modo” con il quale mio padre esercitava la professione.
Ed in questa ricerca il confronto con Luigi è stato stimolante ed arricchente, poiché come spesso accade l’ignorante che sta accanto all’erudito alza la cresta e dapprima timidamente, poi a volte quasi altezzosamente prospetta, contesta, distingue, a volte addirittura tende a dileggiare il suo più dotto interlocutore, approfittando dell’amicizia e della stima che affonda in un sentimento lontano nel tempo, che non si stenta a poter definire, questo sì, frutto di una sicilitudine [12] a volte, complicata da intendere per chi non proviene dalla Sicilia[13] e dunque ruvida e scorbutica, ma sinceramente sana, autentica, vera e, direi, vitale.
2. L’alfabeto sciasciano: legge, giustizia, udienza (e verità)
Il giudice davanti al quale venne portato Candido, ricorda Romano Belfiore, “restò assorto davanti alla bellezza di quelle due parole, di quelle due idee: la legge, la giustizia[14]”.
In svariate opere si è studiato, volta a volta, il rapporto fra Sciascia e la giustizia, fra la giustizia come ideale potenziale ed il diritto e fra la giustizia ed il potere. Studi approfonditi tesi a cogliere quanto in Sciascia fosse marcata la divergenza e la divaricazione fra i termini delle coppie qui riproposte, ma anche quanto quelle parole – giustizia, diritto, udienza, giudice – insieme a verità (del quale si dirà diffusamente in seguito) e potere fossero nella cassetta degli attrezzi di Sciascia onnipresenti, ambivalenti, capaci di attrarsi come di divaricarsi.
Leonardo Sciascia, nella sua Racalmuto, il 27 aprile 1986 partecipò ad un convegno intitolato “Il problema della giustizia”, dichiarando di sentirsi ossessionato da quella questione. Quando Sciascia descrive la mala giustizia lo fa, per l’un verso, convinto che di fronte ai diritti umani non si può mai indietreggiare, anche a pena di essere indicati come collusi, conniventi, contigui al crimine di matrice mafiosa, terroristica o comune che sia.
Lo strumento per combattere le ingiustizie umane è la legge che non può essere violata per debellare l’ingiustizia, senza diventare essa stessa ingiusta.
Ecco la bellezza dei due valori, delle due “idee”, senza le quali il mondo sarebbe immondo, privo di quel controllo che invece è proprio delle democrazie moderne. Il controllo di garanzia e dei poteri.
Non basta, dunque affidarsi al comodo broccardo che il Procuratore di Porte aperte resuscita nascondendosi dietro il “La legge è legge, non possiamo che applicarla”. Il mondo attende figure professionali attive, proattive, capaci anche, quando occorre, di ribellarsi e disobbedire alla legge attraverso la legge stessa, pur rimanendo nel circuito della legalità[15].
Moderno, Sciascia nel battersi per le regole dello Stato di diritto.
E ci si potrebbe fermare qui, non occorrendo nemmeno ricordare al lettore i fronti sui quali oggi si avverte, forte, che il canone appena richiamato venga protetto, ricercato ed affermato in modo effettivo, tanto a livello nazionale che, soprattutto, nella “nostra Europa” assalita da pericoli e derive sovraniste che vanno via via emergendo soprattutto nell’est europeo, senza ovviamente dimenticare la frattura prodotta nell’UE dalla Brexit.
Il bisogno di giustizia, la sete di giustizia si manifesta rispetto al dominio del potere, sicché per esercitarla al meglio non bisogna essere potere, ma contropotere al servizio di un’idea, di un bisogno insopprimibile. Il problema è che alla giustizia dovrebbe provvedere il giudice che tende, a volte, a diventare esso stesso potere e non servizio, fallendo così miseramente la sua mission[16].
Alla parola Udienza Sciascia dedica, nel suo Alfabeto pirandelliano[17], espressioni memorabili, non esclusivamente riservate all’ambito proprio del processo, se è vero che il “chiedere udienza” è non solo l’ascoltare del giudice, ma anche “istanza di giudizio, a chi sta in alto, sui propri bisogni: per vivere, per sopravvivere”. Dunque, “dall’udienza, dall’ascoltare, dal capire – dal sapere ascoltare, dal sapere capire – il sentimento popolare aspetta giustizia o misericordia, giustizia e misericordia insieme”.
Nel leggere questa rappresentazione dell’udienza dedicata da Sciascia a Pirandello si rimane davvero colpiti, soprattutto nel vedere accostate e fuse le istanze di giustizia e di misericordia, se si pensa che a scriverle era un laico non credente.
Forse esse aiutano davvero il lettore e lo guidano sul concetto di giustizia.
Dico forse perché la spiegazione è assolutamente personale. Sembra infatti che la giustizia non guardi affatto all’amministrazione della giustizia terrena, al dare ciò che è giusto a chi lo reclama, a colpire il colpevole, ma ricerchi qualcosa di superiore e, appunto di misericordioso, affidato alla conoscenza, alla capacità di ascolto e di comprensione, alla condivisione di ciò che è giusto.
Straordinario, a me è parso, l’accostamento di un ragionamento complesso fatto dal laico Sciascia a quello molto più recente di un cattolico “praticante”… Papa Francesco, nel suo Misericordia e Giustizia[18], quando afferma che la misericordia “evita il ricorso al tribunale e prevede che la vittima si rivolga direttamente al colpevole per invitarlo alla conversione, aiutandolo a capire che sta facendo il male, appellandosi alla sua coscienza”.
Sciascia non pensava certo in questi stessi termini ma, forse, l’istanza sottintesa al suo pensiero – che pure si coglie nelle espressioni successive sempre dedicate nell’Alfabeto pirandelliano al termine udienza: ci sono le udienze dei tribunali e ci sono le udienze dalla Madonna dell’Udienza, la sentenze giuste dei tribunali e quelle misericordiose della Madonna – è proprio quella di una convergenza fra la giustizia umana e l’esigenza, non meno umana e terrena, della conoscenza misericordiosa, destinata a ridare dignità all’uomo, colpevole o innocente che sia, ad alimentarne la speranza, a proteggere la memoria.
Dunque, proprio quell’idea universale per cui la misericordia non è la sospensione della giustizia, ma il suo compimento, secondo le parole che sempre Papa Francesco pronunziò il 15 febbraio 2020 in occasione del 91° anno giudiziario vaticano.
Evidente, dunque il filo che lega due personalità, non accomunate nella fede ma sulla via di un umanesimo intriso di valori comuni ed universali.
Da qui, forse, quel ruolo illuministico che Italo Calvino, come ricorda Carlo Vecce[19] gli riconoscerà in una lettera del 1964:
“Tu sei ben più rigorosamente ‘illuminista’ di me, le tue opere hanno un carattere di battaglia civile che le mie non hanno mai avuto”[20].
Ruolo che Giovanni Fiandaca definirà poi come illuministico-pessimista nel suo saggio già ricordato che, in ogni caso, conferma la straordinaria modernità di Sciascia, in definitiva, e si coglie nel pretendere che il giurista sia in perenne contrasto contro l’arbitrio dei poteri e, dunque, alfiere di quel rule of law di cui si diceva poc’anzi, che può tradursi come preminenza del diritto[21].
La legge, in definitiva, serve secondo Sciascia purché chi la applica riesca a scovare i furbi e tutti coloro che, facendosi scudo della legge, ritengono di poterne prescindere.
Una lezione che impone al giudice di dismettere l’abito del detentore del potere proprio per garantire che il potere non sia considerato estraneo alla legge.
Ma tornando all’Alfabeto pirandelliano, vi trova posto anche la parola verità.
Nel ricordare la vicenda dell’assassino della moglie fedifraga da parte di Tararà - per cui v., anche, L. Pirandello, La verità, in Contro gli Avvocati, Palermo, 2019, 97 ss. - e di quello che sarebbe poi diventato in Pirandello Il berretto a sonagli, Sciascia si concentra sugli effetti che può produrre l’ansia di verità, in quel caso cagionando l’inflizione di una pena al reo che non aveva ritenuto di poter nascondere al Presidente della Corte la piena conoscenza del tradimento da parte della moglie al punto da determinare una pena ben superiore a quella che sarebbe derivata per un delitto di onore senza premeditazione. La “rivolta” del reo ad una non verità è il pretesto per far dire a Sciascia che “ci sono delle verità – frantumi, come di specchio di una ignorata verità – che una volta scoperte o incautamente confessate, possono avere echi imprevedibili e molteplici, effetti liberatori o micidiali: e sono le verità che rovesciano o disgregano le apparenze, le «menzogne convenzionali»”[22].
3. Sciascia alla ricerca del ruolo della verità
Va così progressivamente emergendo lo spirito del volume, nel quale la giustizia costituisce soltanto un terzo del titolo che insieme a Luigi abbiamo pensato. Appunto Diritto verità e giustizia.
In questa triade, in cui l’assenza della virgola non è frutto di disattenzione ma, al contrario, ricerca di un’unità di senso tra i valori che tali espressioni incarnano, ciò che più mi ha interessato ed incuriosito, da qualche anno a questa parte, è sicuramente il secondo, ponendo il concetto di verità interrogativi che il giurista ha serie difficoltà a dipanare.
La personale sensazione che ne ho tratto, accostandomi un po’ più da vicino ai racconti – come spesso li definiva Sciascia stesso – ed agli articoli dell’intellettuale, sia pur in punta di piedi e da lettore non erudito e colto, è che in lui serpeggi una radicata prospettiva dicotomica fra giustizia e verità[23].
Dove c’è l’una spesso non c’è l’altra. Il che può sembrare paradossale, a ragionare con la lente tradizionale e comunemente accettata dall’uomo comune che intravede, al contrario, il giudice artefice della verità, almeno di quella processuale, in ciò peraltro accompagnato da ben più articolate posizioni dottrinali
Ma appunto il paradosso è tale nella misura in cui Sciascia intende contestare recisamente il giudizio, il luogo in cui si svolge, il modo con il quale è condotto, i suoi protagonisti – giudici, avvocati, procuratori, investigatori – incapaci (salvo qualche rara eccezione) di essere illuminati e, cioè, di ragionare, come nota ne Una storia semplice il Professor Franzò al suo allievo, diventato Procuratore della Repubblica, ancorché debole in italiano: “L’italiano non è l’italiano: è il ragionare”, “Con meno italiano, lei sarebbe forse ancora più in alto”[24]. Immagine impietosa in sé, quella del Procuratore, ma ancora più grave se essa dovesse costituire, come spesso accade in Sciascia, metafora di un sistema più che rappresentazione del singolo protagonista del racconto.
Insomma, per Sciascia gli attori della giustizia sembrano tutti impegnati, più o meno in buona fede, a raggiungere una verità che possa acquietare le domande dei tanti che aspettano, appunto, una verità, poco o per nulla interessati a che quella verità sia quella “giusta”. Al punto che per nascondere la verità i solerti inquirenti sono pronti a creare una falsa verità capace di appagare l’ansia di verità, come accade in La storia semplice, quando la morte del Commissario causata dal brigadiere viene affermata come accidentale per nascondere le trame dell’uccisione del diplomatico.
Per questo il ragionare si pone agli antipodi del formalismo – da qui la vicinanza di Sciascia a Salvatore Satta evidenziata dagli studiosi e che si materializza nelle riflessioni sul formalismo interpretativo che il grande processualista, ricordando Capograssi, dedica ne Il mistero del processo[25] – della strenua e bieca ricerca del dato letterale di una norma, assurgendo a prospettiva di tutta’altra fattura, di tutt’altro spessore, di tutt’altra “verità”.
4. Una, nessuna, centomila verità
Esiste, dunque, la verità sciasciana o sono tante le verità di Sciascia?
Già un lettore distratto e disinvolto di Sciascia, come si considera chi scrive, riesce a percepire il peso e la critica di fondo del pensiero sciasciano, a tratti non arrivando a comprenderla fino in fondo perché consapevole di quanto la massimizzazione dei giudizi su “quello che diceva Sciascia” rischia di perdersi per strada – o imboccare strade impervie – e lasciare sullo sfondo un altro mondo pulsante che pure sembra vivere nel pianeta giustizia e che è portatore proprio di quel patrimonio che Sciascia vede ripetutamente (e forse inesorabilmente) perduto.
5. La dimensione individuale e quella collettiva del diritto di – e del dovere alla – verità
Sul tema della verità, sviscerato in ambito giuridico con finissimi studi che muovono dal ragionamento che sorregge la decisione giudiziaria[26], Sciascia sembra dunque gravitare in una dimensione ben diversa da quella del “processo” ove questo non sia – o non sia stato – adeguato alla complessità del caso e offra risposte burocratiche, tese ad affermare una verità qualunque essa sia. Al punto che per questa prospettiva non esiste l’errore giudiziario, come ripete il Primo Presidente della Cassazione Riches ne Il contesto.
La sensazione che si ha accostandosi a Sciascia è dunque quella che la verità mai ritrovata nelle vicende umane non potrebbe comunque essere solo quella affidata al giudice.
Una verità, quella di Sciascia che si alimenta della non verità, dell’impostura – solo a volte smascherata, seppur vanamente, come ne Il Consiglio d’Egitto, per bocca dell’Avvocato Di Blasi che pure riconosce che la menzogna “assume le apparenze della verità” (117) – della doppia verità – come quella rivendicata nel Teatro della memoria dalle famiglie Cannella e Bruneri rispetto allo smemorato di Collegno – o confusione fra verità e sanzione della verosimiglianza – che ne La strega e il capitano vede “la verità dei giudici e la menzogna di Caterina”[27] e, dunque, i giudici nutrirsi delle falsità esternate dalla strega Caterina de’ Medici[28].
Ora, la straordinaria modernità di Sciascia ed il suo essere precursore di esigenze, prospettive ed orizzonti che oggi, a distanza di molti lustri dalla sua scomparsa emerge, così, a tutta prima dal particolare significato che egli attribuisce all’endiadi “verità e giustizia” e che va prepotentemente emergendo nell’attuale fase storica in una dimensione propria dei diritti umani, appunto sganciata dal concetto di nazioni e territorio ed invece collegata al carattere sovranazionale dei diritti umani.
Il farsi coscienza critica della società in nome della verità e della sua ricerca e lo spiccato civismo di Sciascia preconizzano tematiche che assumono crescente valore anche nel nostro Paese a distanza di tanti lustri dalla morte dello scrittore girgintano.
Il diritto alla verità[29] rivolto a disvelare il mai conosciuto rispetto ad eventi tragici che hanno segnato la storia individuale (delle persone) e collettiva del Paese si riempie, infatti, di contenuti e dimensioni plurali, pur ancora da compiutamente definire nei quali si fondono, fino a modificarsi geneticamente quando entrano in contatto la prospettiva individuale – della o delle vittime – e quella collettiva, che vede in gioco lo Stato-persona – tenuto a indagare, condurre i processi, adottare misure ripristinatorie e repressive nei confronti dei responsabili –, ma anche lo Stato-collettività, al cui interno si collocano la polis[30], gli studiosi, i letterati, appunto presso i quali dovrebbe emergere, secondo Sciascia, un’esigenza diffusa alla conoscenza di fatti che costituiscono parte delle ragioni di identità dello Stato stesso. Dunque, un “dovere di verità”.
Quella che Stefano Rodotà, nel suo saggio dedicato al diritto alla verità, descrive osservando che «È l’umanità intera, senza confini spaziali e temporali, che compare sulla scena, ed è proprio essa a dover essere traghettata verso tempi illuminati e redenti dalla forza della verità»[31].
Un diritto alla verità che sembra pendere decisamente verso la dimensione collettiva, nella quale la verità diventa “dovere” per la società, da imporre anche a chi si acconcia alla falsa verità, si acquieta sulla portata assorbente e totalizzante della verità processuale e ne rivendica la infallibilità.
Un “dovere di verità e giustizia” che riecheggia ancora nelle parole del Presidente Mattarella di fronte ai familiari delle vittime della strage di Bologna, quando nelle celebrazioni per il quarantennale[32] ritorna ad affermare con forza non solo “il dovere della memoria, l’esigenza di piena verità e giustizia e la necessità di una instancabile opera di difesa dei principi di libertà e democrazia”, ma anche “l’esigenza di piena verità, l’esigenza di giustizia, di verità completa che è stata perseguita con determinata e meritoria ostinazione dall’azione giudiziaria, dalla sollecitazione dei cittadini, dei familiari delle vittime contro ogni tentativo di depistaggio e di occultamento”.
Sembra davvero di risentire in quelle parole del Presidente il fiato di Sciascia – che affiderà alla raccolta intitolata “A futura memoria” una parte importante dei suoi articoli – la sua cadenza dialettale, il suo sguardo intenso nel pensare appunto alle vittime, ma anche alla società intera ed al dovere di verità.
Ora, tutto questo si ritrova in modo adamantino nella produzione letteraria e giornalistica di Sciascia, nel suo anelito a quella “verità pubblica” di cui parla S. Battaglia[33] che va ricercata nel fondo delle coscienze frustrate e che è, essenzialmente, ragione, ragione di una riscossa comunitaria e collettiva.
Qui, forse, sta il senso del pensiero sciasciano che non può essere soddisfatto se non in parte dalla sentenza resa da un giudice sol perché essa costituisce espressione dell’ordine giudiziario e solo in quanto “cosa giudicata”.
La verità sarà tale solo se trae alimento da quel “pezzo di carta” purché esso sia ispirato da quel desiderio, da quella “ossessione” rispetto alla quale Sciascia non sembra mai pago. La decisione del giudice, dunque, come frammento di una verità che può anche giungere a mostrarsi diversa e contraria a quella espressa “in nome del popolo italiano”.
Insomma, quello che Sciascia vagheggia sembra essere il punto di incontro fra verità processuale che pretendono le vittime e verità storica che reclamano, certo, le vittime, ma anche la società – recte, la parte migliore della società –.
A volte l’assenza di giustizia e verità pare infatti essere in Sciascia critica feroce e impietosa rivolta a quella parte di società che non sembra affatto preoccupata della verità. Quindi, sì critica agli attori della giustizia, ma prim’ancora censura profonda dell’umanità e dell’assenza di valori che non sembrano, per Sciascia, trovare adeguato posto e tutela al suo interno, tanto da suscitare l’intervento del letterato che rilegge o a volte riscrive la storia.
In definitiva, la crisi della giustizia nasconde la crisi dell’uomo, del suo sfuggire ai grandi temi che lo circondano, del suo appiattirsi ed acconciarsi a false verità di comodo, del suo fermarsi sulla soglia della verità, del disinteresse per il senso ultimo che il tema giustizia evoca, quello della dignità e del rispetto dell’uomo[34].
Una crisi che Sciascia tenta di sovvertire, facendosi dunque coscienza critica degli stessi vizi della società. Quella passione civica e civile di Sciascia che proprio un suo amico e collega di pari valore, Vitaliano Brancati, non mancava di attribuirgli con grande onestà intellettuale
“Io invidio la tua forza civile, il tuo impegno sociale, la tua capacità di servirti della parola scritta per persuadere o dissuadere”[35].
Il carattere poliedrico della verità ha, in apparenza, centri di imputazione diversi ma che appaiono alimentarsi vicendevolmente e in modo inesauribile, al punto che risulta difficile individuare il confine fra le une e le altre.
La sfera intimista della vittima – primaria e secondaria – in altri termini, si offre alla collettività perché a essa pure pertiene la sofferenza, il dolore, lo strazio, ma anche il diritto alla conoscenza (art. 21 Cost.), così del resto attuandosi concretamente quella precondizione di solidarietà che pure campeggia nella Costituzione (art. 2).
Un’appartenenza della verità alla parte civile della collettività che Sciascia tenta di individualizzare e personificare – e così fa nella figura dell’Ispettore Rogas, in cui emerge una vera e propria ansia di verità, almeno finché egli non incontrerà il Presidente della Corte suprema o in quella del brigadiere de Una storia semplice – per farla uscire da uno stato etereo, incorporeo e diffuso attraverso l’emersione della rilevanza superindividuale della vicenda – attenendo a un’esigenza di verità appunto collegata alla giustizia rispetto a condotte che hanno violentato barbaramente la persona umana, attorno alla quale ruota lo Stato-persona, secundum Constitutionem.
Ecco che l’identità, imputabile in via esclusiva ed individuale alla persona, diventa patrimonio comune quando essa è violata; diventa bene comune da salvaguardare, proteggere anche oltre l’esistenza ed esperienza terrena di colui che è stato vittima, al punto di terminare la propria esistenza lasciando altre vittime a subire il lutto dell’assenza definitiva ed irrisarcibile.
Una verità che, guardata con la lente del Primo Presidente della Corte di Cassazione de Il contesto assomiglia davvero alla non verità. L’affermazione che il risultato finale del processo non può che essere naturalisticamente l’affermazione del vero è per davvero la negazione della funzione giudiziaria. Ed è ancora di recente Luigi Ferrajoli a ricordarcelo quando mette in evidenza, fra le virtù del giudicare, appunto quella del dubbio[36].
Una verità su fatti del passato che, se non ancora raggiunta o se mistificata per effetto di eventi che orientano verso una prospettiva di non verità di ciò che ufficialmente viene espresso come verità, va comunque ricercata, accertata, compresa – come si sforza di fare, vanamente, il Brigadiere Lagandara ne Una storia semplice – per dare sollievo, come si diceva, alla ragione.
Prospettiva che rimane un obiettivo ineludibile anche quando non si riesce a raggiungerla.
Ed in questo Sciascia è sicuramente un precursore dei nostri tempi, avendo colto prima di tanti altri studiosi sfumature ed esigenze allo stato liquido e scomposto che trovano nella sua personale ricerca della verità una forma precisa, un contorno definito, una matura concretizzazione.
Sciascia aiuta a comprendere quanto il diritto alla verità su episodi che hanno caratterizzato particolari momenti storici di una nazione diventi centrale per le democrazie moderne e non sia possibile eliderlo, dimenticarlo, nasconderlo magari affidandosi all’oblio che si va formando quasi naturalmente per il solo trascorrere del tempo. O, peggio, ancora, appiattendosi rispetto alla Ragion di Stato evocata proprio per impedire che la verità venga accertata.
Ed in questo la vicenda delle torture inflitte dalle forze di polizia in occasione del G8, stigmatizzate dalla Corte edu nelle sue sentenze – sulle quali ci siamo soffermati in passato[37] – dimostra la lungimiranza straordinaria di Sciascia[38] nel farsi artefice e portatore di valori universali in un tempo nel quale in pochi avevano compreso l’importanza. La sua tensione - avversione per la ragion di Stato quando è agitata per favorire la non verità sarà quella che spinse i giudici della Corte di Strasburgo ad esecrare i risultati della giustizia nazionale sulle vicende della sparizione di Abu Omar Quando, nella sentenza della Corte edu resa nel caso Nasr e Ghali c. Italia, la Corte di Strasburgo riconobbe che “...malgrado il lavoro degli inquirenti e dei magistrati italiani, che ha permesso di identificare i responsabili e di pronunciare delle condanne nei loro confronti, le condanne in questione sono rimaste prive di effetto, a causa dell’atteggiamento dell’esecutivo, che ha esercitato il suo potere di opporre il segreto di Stato, e del Presidente della Repubblica” riconoscendo che “il principio legittimo del «segreto di Stato», evidentemente, è stato applicato allo scopo di impedire che i responsabili dovessero rispondere delle loro azioni.” Non si può non cogliere un filo rosso con il pensiero sciasciano già espresso ne Il contesto, quando per spiegare l’uccisione di Rogas il Vice segretario del partito rivoluzionario evoca, appunto, la ragion di Stato[39].
In questa prospettiva vanno probabilmente iscritte le sue “ricerche”, alcune davvero risalenti nel tempo, sia da scrittore e poi da deputato, della verità su alcuni dei più gravi fatti della storia politico-giudiziaria dei nostri tempi, andando agevolmente il pensiero alle vicende Majorana, Moro e Tortora.
Verità, come si accennava prima, spesso richiamate come metafora del presente e che “una volta scoperte o incautamente confessate, possono avere echi imprevedibili o molteplici, effetti liberatori o micidiali: e sono le verità che rovesciano o disgregano le apparenze, le «menzogne convenzionali»”.
Verità che, secondo una prospettiva quasi ontologicamente bifronte sembra per l’un verso indirizzarsi quasi inconsapevolmente verso la dimensione primaria della persona, che è per l’appunto rappresentata dalla sua dignità e, per altro verso, si eleva a metro universale della democrazia dei paesi e dei loro processi, infondendo un’ansia di effettività dell’ordinamento giuridico destinata a non cessare[40].
Sciascia sembra volersi ribellare alla deriva di un mondo occidentale che tende a volere cancellare la memoria collettiva ricercando la verità, alla quale sente di affidarsi proprio perché, prendendo a prestito le parole di Michele Taruffo, essa “assicura la libertà dei cittadini contro il potere tirannico”[41].
Ed allora, cos’è questa ansia di verità se non la “colla” che tiene unita la generazione presente a quella che non c’è più o non c’è ancora[42]?
Una colla costituita dai diritti umani in una proiezione che tende a divenire sempre più universale, nella quale il genere femminile del termine verità colora in modo ancora più profondo l’aspirazione a vederla realizzata in tutte le sue declinazioni ed in tutti i suoi possibili sensi, soprattutto quando essa coinvolge i più deboli, i più vulnerabili, facendo di Sciascia un autentico Maestro di verità, consapevole di quella stessa ansia di verità alla quale Moro si riferiva già negli appunti alla sua lezione di filosofia del diritto nel 1944[43] e in alcune lettere dalla prigione delle Brigate Rosse come incommensurabilmente più importante di milioni di voti, come ricordato più volte da Damilano[44].
6. Verità e complessità del diritto
Il percorso che sembra tracciare Sciascia è dunque irrorato dal tema della complessità assai caro a Italo Calvino che di Sciascia fu uno dei primo estimatori, e da quelli ad esso succedanei dalla difficoltà e dalla onerosità.
Il suo radicato europeismo che fece di Sciascia esponente della cultura mitteleuropea e spesso stanziale a Parigi, del resto, sembra essere precursore dell’attuale contesto della giustizia, tutto aggrovigliato attorno a chi si accapiglia sul rapporto fra giudice e legge con prese di posizione che odorano, a volte, di scontri epici fra guelfi e ghibellini ed altre assumono il sapore di vere e proprie crociate, recando con sé il tanfo ideologico che poco si addice all’attuale fase storica in cui la scommessa sta, forse, più che nella ricerca del tarlo dell’una o dell’altra posizione nell’aprirsi alla ricerca di un equo contemperamento fra l’avanzare di un costituzionalismo globale, nel quale assumono crescente peso e significato i principi fondamentali della persona e la necessità di realizzare una giusta convivenza con altri principi ed interessi di rango costituzionale, nessuno dei quali può assumere una posizione tirannica se non quello della dignità. Il che sembra essere, in definitiva, l’anelito di Sciascia, il rispetto della persona, della sua dignità, dei valori che ad essa appartengono e che lo Stato non può né deve mai annichilire, ma al contrario attivamente proteggere.
La tendenza allo scontro che, a volte, prevale invece sul tema del rapporto fra legge e giudice non pare adeguatamente considerare che è proprio la complessità[45] – di Sciascia, della società, del suo dinamismo – a non potere essere imbrigliata in formule astratte e/o all’interno delle categorie che non possono certo in alcun modo essere elise o eliminate, ma che devono continuamente essere riponderate, attualizzate rispetto al contesto, rinvigorite, riempite dal nuovo rappresentato dall’attualità in cui i confini crollano progressivamente a favore di una sempre più avvertita esigenza di protezione e salvaguardia della persona.
Il tutto al fine di raggiungere la giustizia che si compone continuamente attraverso nuovi tasselli che legislatore, giudici, comunità interpretativa – per dirla con Lipari – e società devono sapere maneggiare e, in una parola, conoscere.
Il rigoroso e rigido riferimento alla legge che sembra animare il capitano Bellodi e che – pur ricostruendo la verità[46] - non approda, tuttavia, alla affermazione di giustizia merita, forse, una apertura maggiore all’applicazione ragionata, intelligente, razionale del comando legislativo che trova, dunque, nell’interpretazione del comando normativo – e per lo scrittore nell’interpretazione e combinazione dei fatti in una particolare struttura d'intreccio[47] - e nella coscienza di chi quel dato è chiamato a vivificare nel caso concreto la sua anima, senza la quale la legge rimane astratta declamazione, incapace di raggiungere il suo vero obiettivo, appunto, la giustizia.
Conoscenza, ancora, che è alla base di quel “diritto alla verità” al quale qui si è provato ad accennare e che per questo motivo si lega, quasi inscindibilmente, al tema della giustizia e del diritto.
Sarebbe errato, peraltro, quanto al tema della verità, pensare che la prospettiva giudiziaria possa perseguire percorsi disgiunti, disallineati o anche solo indipendenti da quelli che la società, la cultura, il dibattito civile possono, a loro volta, realizzare.
Anzi, Sciascia convince ancora di più di quanto ci era parso emergere in una recente riflessione sul diritto alla verità[48], quando sottolineavamo la necessità di un collegamento osmotico fra società e giustizia, chiamate necessariamente a interagire secondo un meccanismo che impone alla società e ai suoi individui di chiedere al giudice giustizia e impone al giudice di rispondere a quelle istanze, non ammettendosi il non liquet. Una sinergia composta da diversi tasselli, i quali rendono necessari il dialogo, il confronto, la pluralità di domande, la diversità dei casi, per consentire il raggiungimento di un obiettivo condiviso: appunto, la verità!
Obiettivo che, dunque, non può rimanere riservato alle aule giudiziarie, troppo anguste per esaurire un anelito che aspira, forse, a obiettivi ancora più alti rispetto a quelli della giustizia dispensata nelle e dalle Corti.
Un diritto, quello alla verità, che va per l’un verso rispettato e, per altro verso, adempiuto – per dirla con Rodotà – da parte di chi governa, essendo questi tenuto a realizzare un “regime della verità, nel senso della piena possibilità della conoscenza dei fatti da parte di tutti”[49].
Sciascia, forse, è lì a ricordarlo a tutti quelli che gravitano attorno al mondo della giustizia, mischiando e confondendo il piano del diritto e quello del dovere alla verità, forse inconsapevolmente prefigurando scenari che gli studi filosofici (Bobbio, per tutti) e quelli dichiaratamente giuridici avevano già da tempo precorso cercando di tracciare il contenuto dei diritti fondamentali e la loro radice rispetto alla persona.
Ma, è questo il punto, parafrasando le parole di Sciascia in un suo articolo pubblicato sul Corriere della sera del 26 gennaio 1987, chi ha il coraggio di bussare alle porte della verità? Quanti sono disposti realmente ad incanalarsi in quel percorso aspro? Quanto l’ansia della verità viene insegnata, condivisa, compresa, studiata? Quanto il mondo “non giudiziario”, la scuola, la politica, le istituzioni culturali si impegnano, oggi, per ricercare la verità riconoscendone il valore? Quanto va approfondito il tema del “dovere” di dire la verità, di ricercarla attraverso la storia che nutre la giustizia?
E ancora: quanto la magistratura è pronta a mettere in gioco il comando di una legge se questo dovesse mostrarsi in contrasto con i valori cardine della persona incarnati dalle Carte dei diritti fondamentali quando in gioco c’è la verità?
Quanto essa magistratura è pronta a riscattarsi anche agli occhi della società in nome della quale amministra la giustizia? Quanto essa intende mettersi al servizio della verità e mai del potere e ad essere, in definitiva, disobbediente[50] fino al punto da incarnare un atto di opposizione civile[51],
come lo fu il piccolo giudice[52], pronto a confessare di avere escluso la pena di morte attraverso un’operazione di sussunzione dei fatti all’interno di un unico disegno criminoso -…l’argomento principe sarebbe stato quello dell’infermità mentale; mancandomi, l’ho surrogato assumendo i tre omicidi nella continuità di un unico disegno criminale-?
Interrogativi, questi ultimi, che a ben considerare non riguardano solo e tanto la magistratura, ma appunto la polis che i giudici in parte rappresentano.
7. La prescrizione del diritto alla verità e la lunghezza dei processi come diniego di verità
Forse un aspetto non coerente con la stessa ricerca della verità di Sciascia si intravede quando lo scrittore parrebbe attribuire alla irragionevole durata dei processi la negazione tout court della giustizia[53].
Il che rende ancora di più di straordinaria attualità il suo pensiero, proprio in un periodo nel quale le riforme in discussione in Parlamento anche in materia penale, intendono introdurre dei limiti alla durata del processo penale, giungendo alla conclusione che superato un certo limite temporale, non vi è solo un’esigenza di limitare la durata del processo ed eventualmente di sanzionare la durata che supera quel certo limite, ma ricorre anche la necessità che il processo si concluda senza giungere al suo sbocco naturale, costituto dall’affermazione di colpevolezza o di innocenza.
Sia chiaro, non che questa prospettiva possa essere considerata in sé falsa, al contrario.
Ma la verità di questo postulato deve tuttavia fare i conti con altre verità, alcune delle quali non disponibili da chi è chiamato a partecipare al sistema giustizia che, appunto, vanno comunque tenute in considerazione se si vuole giungere ad un verdetto finale appagante, ragionato[54], e in definitiva giusto.
Chi partecipa a questo sistema – sia esso decisore politico o giudice o procuratore – è infatti chiamato, per funzione, a bilanciare valori, interessi, situazioni, contingenze che rendono indispensabile il sacrificio di taluni dei valori che ruotano sempre attorno al pianeta persona, purché tale sacrificio intenda perseguire l’obiettivo del massimo della tutela della persona e della sua dignità, autentico valore non disponibile, non negoziabile, non bilanciabile, secondo quanto non si stanca di ripetere una sensibile dottrina (per tutti, A. Ruggeri, in numerosi suoi scritti).
In definitiva, proprio la ricerca della verità nel senso anelato da Sciascia non può essere sacrificata sull’altare della celerità del processo, soprattutto quando il processo è lento non sempre e solo per le colpe degli uomini, ma di chi fissa le regole dei processi, pensando anche alle garanzie delle parti che hanno un costo, in termini di tempo.
Sicché si potrebbe arrivare al paradosso che un processo lampo, pur soddisfacendo l’esigenza di verità, sia esattamente ciò che Sciascia non vuole mai sia un processo, assomigliando ad una farsa!
Viene allora da chiedersi se per Sciascia – e non soltanto per lui, a ben considerare – l’opera di bilanciamento fra valori alla quale è spesso chiamato il decisore – giudiziario e non – possa suonare come sinonimo di compromesso al ribasso, di opacità, di ambiguità o piuttosto come massima espressione di quel “ragionare” che Sciascia impone a qualunque decisore purché esso appaia lindo e degno di rispetto.
Il tema si lega a stretto giro a quello della prescrizione dei reati che ha anch’esso agitato la scena politica e che già avevamo provato a collegare all’esigenza di disvelare, nella già ricordata riflessione sul tema, la verità su vicende dolorose del nostro paese.
Quanto e per quanto tempo, in altri termini, l’esigenza di fare memoria e chiarezza su quelle vicende può essere salvaguardata?
Su questo tema la vicenda del caso Davide Cervia, della sentenza resa dal Tribunale di Roma sulla morte del militare nella quale venne affermato, forse per la prima volta in un atto giudiziario, la consistenza del diritto alla verità[55] è di straordinaria importanza, soprattutto rispetto alla condotta dell’Avvocatura dello Stato che, nel giudizio risarcitorio proposto dai familiari del militare scomparso, a dire del legale dei medesimi, imposero come “condizioni” per non eccepire la prescrizione del diritto al risarcimento del danno reclamato la rinunzia alla condanna risarcitoria e la limitazione dell’azione alla verifica circa l’esistenza del diritto alla verità. Posizione che non va qui in alcun modo valutata se non per sottolineare che l’affermazione operata in sentenza dal giudice circa la violazione del diritto alla verità ha collocato tale posizione giuridica nell’orbita di quei valori imprescrittibili che non possono tollerare alcuna barriera procedurale che si frapponga alla verità.
Certo, a questo punto risorgono i mai sopiti dubbi su cosa sia la verità e su chi sia il soggetto legittimato a ricercarla ed a fissarla – il giudice, le Commissioni per verità che hanno già prodotto frutti nelle esperienze sudamericane[56], gli intellettuali, le associazioni no profit–.
Ma ancora una volta, proprio la recente riforma che sta per essere varata in sede parlamentare dimostra la centralità del pensiero di Sciascia e quanto egli sia stato precursore di un tema dai mille risvolti e sfaccettature che ne dimostra comunque la limpidezza del pensiero e la lungimiranza proprie di alcune delle personalità dello scorso secolo.
8. Scienza, diritto e letteratura a confronto con la verità e con il giudicare
Tornando alla verità, viene da chiedersi chi sia realmente legittimato a ricercarla ed affermarla: lo storico, il letterato, il giudice o chi altro?
Per Sciascia
“Lo scrittore svela la verità decifrando la realtà e sollevandola alla superficie, in un certo senso semplificandola, anche rendendola più oscura, per come la realtà è.”[57]
La letteratura sembra dunque la forma suprema di verità[58].
In Nero su nero Sciascia scriverà, infatti, che la “letteratura (che per me, e ne ho avuto piena coscienza da quando ho finito di scrivere sulla scomparsa di Majorana, è la più assoluta forma che la verità possa assumere)”, mira dunque ad individuare di volta in volta “l’ordine delle somiglianze”, restituire un senso alle coincidenze.
Nell’Affaire Moro lo stesso Sciascia dirà che “Lasciata, insomma, alla letteratura la verità, la verità – quanto dura e tragica apparve nello spazio quotidiano e non fu più possibile ignorarla o travisarla – sembrò generare dalla letteratura”.
“Soltanto la verità del letterato può dare pace alla ragione e dare soddisfazione alle istanze di verità della parte migliore della società”, se è lo stesso Sciascia a precisare, nello stesso contesto da ultimo ricordato, che “da parte mia, ritengo che lo scrittore sia un uomo che vive e fa vivere la verità, che estrae dal complesso il semplice, che sdoppia e raddoppia – per sé e per gli altri – il piacere di vivere. Anche quando rappresenta terribili cose”.
Concetto sul quale Sciascia ancora una volta tornerà nel 1977, dalle colonne de La stampa quando, come ricorda D. Perrone[59] in margine alle polemiche suscitate dal suo scritto su Moro, dirà: “L’intellettuale è uno che esercita nella società civile – almeno dall’affare Dreyfus in poi – la funzione di capire i fatti, di interpretarli, di coglierne le implicazioni anche remote e di scorgerne le conseguenze possibili. La funzione insomma, che l’intelligenza, unita a una somma di conoscenze e mossa – principalmente e insopprimibilmente – dall’amore alla verità, gli consentono di svolgere”.
La ricerca della verità nascosta diversa da quella consacrata in un processo – che è dunque spesso ingiusto – serve a Sciascia per legittimare l’esistenza dell’altra verità alla quale si indirizza lo scrittore[60] in un processo di invenzione[61] e di ricerca intensa e sposmodica, al punto che lui stesso ritiene che il suo impegno trentennale su questioni estremamente complesse del nostro Paese avesse consentito di raggiungere qualche inoppugnabile verità[62].
La verità o le verità di Sciascia che traggono alimento dalla storia – e qui la almeno parziale assonanza di pensiero fra Sciascia e Aldo Moro, per il quale “la verità vive essenzialmente nella storia” (per cui v., infra) – hanno sicuramente maggiore respiro rispetto alla verità processuale[63]. Ambito, quello processuale sul quale non si incentra direttamente l’analisi dello scrittore.
Altra è la prospettiva che lo stesso Sciascia rende manifesta quando dichiara in un’intervista a margine della presentazione del film tratto da Il contesto che quel libro era stato scritto “in omaggio alla verità” che non viene necessariamente agganciata al tema processuale, anzi nettamente diversificandosi da questa per un senso di strisciante sfiducia nei confronti di chi si fa artefice della verità.
Insomma, il diritto, la giustizia e la verità sono per Sciascia parificabili alla scienza?
E che ruolo gioca per uno scienziato l’interpretazione del diritto e dunque il ragionamento sulla portata di senso di una disposizione e quanto quel ragionamento la trasforma in norma?
E quanto i valori dell’uomo – primo fra tutti quello della dignità – sono capaci di squadernare l’astratta formula legislativa per riportarla al caso concreto ed alle necessità di tutela che essa reclama?
Sciascia sembra avere paura della giustizia, dei processi e dei giudici che tendono a creare una verità che fa scudo alla verità reale e lascia spazio all’impostura, di quelli che si ritraggono rispetto alla complessità della ricerca delle fonti, all’analisi del loro significato, alla verifica certosina dei fatti di come gli stessi si sono svolti. Auspica invece un recupero attraverso il diritto ed al suo massimo interprete un pieno recupero della dignità e della centralità della persona.
Il che ancora una volta dimostra al contempo la modernità dell’uomo Sciascia, egli volgendosi sempre e comunque verso la persona e dunque verso l’impronta personalistica che invera la nostra Costituzione, non potendo comunque Sciascia e la polis fare a meno di chi applica la legge e la interpreta, in definitiva ponendosi in linea con chi – P- Grossi – ancora di recente ha affermato che “la giurisprudenza si impone attualmente come presenza di straordinario rilievo”, e dunque esaltando, oggettivamente, il ruolo ed il “mestiere del giudice” [64].
Quando Sciascia si lascia andare al pessimismo – di cui si diceva in precedenza – fino al punto da gridare che “la Costituzione è morta” sembra che il vero chiamato in causa sia l’uomo e chi non si spende per proteggerne la dignità, intravedendo in tutto questo una dimensione minima del processo che lo rende “degno”, altrimenti risultando indegno, immorale e ingiusto. E poco importa che l’indegno possa risultare il giudice di turno – l’Inquisitore – contro il quale l’innocente Diego La Matina si scaglia, uccidendolo, per riscattare “la dignità e l’onore dell’uomo, la forza del pensiero, la tenacia della volontà, la vittoria della libertà”.
Dunque il pensiero che la giustizia e chi la amministra possano essere meri ingranaggi di e del potere, destinati a schiacciare una parte o un imputato o ad insabbiare la verità sembra ossessionare Sciascia che sa quanto centrale sia, appunto, la giustizia per l’uomo.
Nitide testimonianze di quanto detto si scorgono, per l’un verso, nel modo in cui Sciascia incastona la figura del Procuratore ne Una storia semplice – lo stesso che copiava i temi a scuola – che indaga sui tre omicidi, consapevole artefice di una ricostruzione che è agli antipodi della verità, offerta al pubblico per chiudere il caso.
Analogamente, ne Atti relativi alla morte di Raymond Roussel[65] la chiusura immediata del caso, archiviato come suicidio, veniva stigmatizzata per la rapidità impressionante dell’inchiesta da parte della magistratura “il cui passo è nella totalità dei casi di impressionante lentezza e di atroce peso per coloro che si trovano implicati”[66] – mostrando il suo pessimismo di fondo sulla idoneità della giustizia a rendere realmente giustizia.
Ma quel che qui si è descritto è soltanto una delle facce della giustizia e del giudice sulle quali Sciascia si diffonde.
Vi è, infatti, l’altra, forse la più nota che emerge nella vicenda Tortora di cui si dirà appresso.
Sciascia non manca di tratteggiare il suo modello di giudice in un articolo del 14 ottobre 1983 apparso sul Corriere della Sera[67] – e riportato in A futura memoria (se la memoria ha un futuro).
Articolo sul quale già si sono soffermati autorevoli giuristi[68] e che qui merita di essere ricordato, ancora una volta, per l’estrema attualità del pensiero sciasciano in tema di giustizia e di giudici, oggi più che mai dopo che le vicende successive alle indagini di Perugia hanno prodotto una consistente perdita di credibilità dell’ordine giudiziario.
E ciò non tanto per la pur considerevole attenzione che Sciascia rivolge al modo di atteggiarsi del “giudicare”, incline quasi naturalmente a condotte di autoprotezione che lo condurrebbero a “credere impossibile l’errore”.
Del resto, la figura e le idee del Primo Presidente della Cassazione disegnate ne Il contesto costituiva già uno dei punti più elevati di questa prospettiva.
Ma sono, piuttosto, le accuse che Sciascia indirizza alla giurisdizione per ritenersi totalmente estranea ad ogni forma di controllo ad essa esterno al punto da farle assumere una dimensione museale, icasticamente descritta come “altare”:
“un che di ieratico, di religioso, di imperscrutabile e con conseguenti punte di fanatismo”.
Questo stato di cose, secondo Sciascia, avrebbe dunque prodotto una mutazione genetica dell’indipendenza del giudice in origine giustamente riconosciuta, trasformandola in patologica dipendenza partitocratica, alla quale avrebbe poi fatto seguito l’invasione della giurisdizione negli spazi vuoti lasciati dal potere esecutivo e la confusione fra giurisdizione e legislazione.
Ora, al di là della condivisibilità o meno del ragionamento che conduce qui Sciascia, esce forte, e davvero con una portata universale, l’invito a considerare la giurisdizione come servizio, come elemento portante della società al quale il tanto potere conferito le impone di essere quanto più casa di vetro, trasparente e dialogante.
Invito che la magistratura ha il dovere di raccogliere oggi più che mai, mettendosi più che mai nuda al cospetto di quella società (sana), in nome della quale amministrare la giustizia, senza nemmeno tentennare di fronte a chi la accusa di essere, indebitamente, creativa ma tralascia di considerare il suo ruolo, i meccanismi che il sistema prevede a presidio della funzione del giudice[69].
Vi è, anche ed accanto a questa prospettiva, la convinzione che il ruolo del giudice nell’accertamento della verità processuale debba in qualche modo nutrirsi delle modalità di ricerca della verità che non sono proprie della giurisdizione, così attingendo alle figure del letterato e dello scienziato.
Ma qui, evidentemente, il discorso si complica, se appunto si considera la diversità di approccio del giudice alla verità, correlata alla non libertà nella sua ricerca (posto che il giudice non inizia il processo per sua scelta, ma lo conduce al termine perché esso è iniziato per volontà altrui) e, ancora, perché il giudice non è sommamente libero nella ricerca delle prove, ma si inserisce in un circuito processuale e “legale” nel quale la ricerca di ciò che è vero processualmente dipende, in larga misura, da ciò che le parti processuali introducono nel processo e dal “contraddittorio” che nella ricerca storica è assente, nonché dal “tempo” nel quale si ricercano e vengono raccolte le prove[70]. Al netto della questione dei poteri che possono riconoscersi al giudice per integrare l’attività delle parti.
In verità, su questi ultimi aspetti – attorno ai quali si tornerà a riflettere infra – Sciascia non sembra approfondire in termini sistematici il problema, ancorché lo avverta come rilevante, decisivo e forse vitale per la riconduzione del diritto alla giustizia.
8. Il potere della magistratura. Sciascia, Livatino e la sicilitudine
Si diceva, nei paragrafi precedenti, del problema della giustizia che ossessionava Sciascia.
E la denunzia di Sciascia contro la giustizia finisce con l’investire la sua Sicilia e la contaminazione che avvertiva essersi verificata per quella che lui stesso in un’intervista alla televisione svizzera di Lugano definì la sicilizzazione dell’Europa.
Ma in effetti Sciascia conosce nel profondo le contraddizioni della sua Sicilia, metafora del mondo. Sa quanto la realtà isolana sia “lontana dalla libertà e dalla giustizia, cioè dalla ragione”, come scrive aprendo Le parrocchie di Regalpetra.
Ma sa anche che in quella Sicilia – ma si potrebbe dire, ovunque nel mondo – convivono mentalità, prospettive, ideali diversi[71]. E si contrappongono continuamente le due concezioni della giustizia, delle quali parla lo stesso Sciascia ne Il calzolaio di Messina[72].
Ora, sembra utile ricostruire in parallelo due frammenti di vita che coinvolsero, a distanza di pochi anni, Rosario Livatino, magistrato originario di Canicattì e lo stesso Sciascia.
Il nesso di collegamento fra queste due figure lo si trova in due momenti estremamente importanti per ciascuno dei due personaggi che qui si intendono rievocare.
Rosario Livatino, nel suo ormai celebre saggio Il ruolo del giudice nella società che cambia, destinato alla conferenza tenutasi a Canicattì il 7 aprile 1984, dedica alcune delle sue riflessioni al potere del magistrato ed all’introduzione di forme di responsabilità civile del magistrato per danni arrecati a terzi dalla sua attività.
Tema in quel particolare frangente storico assai dibattuto ed al quale Sciascia, come noto, dedicò parte delle sue energie, spedendosi per l’approvazione del referendum proposto dal Partito radicale e a distanza di appena due anni, come si diceva nel giugno del 1986, presiedendo quel convegno nella sua Racalmuto intitolato Il Problema della giustizia oggi, di cui si è già detto all’inizio, i cui resoconti risultano disponibili grazie a Radio Radicale e che appaino sintetizzati nello scritto La dolorosa necessità del giudicare, edito alla fine del 1986 ne Il Giudice.
Livatino, nel tratteggiare il ruolo del giudice, si chiede come la società possa accettare che il giudice abbia un “potere così grande come quello che ha”, trovando risposta nell’immagine che egli deve offrire del suo agire – di persona responsabile, comprensiva ed umana, capace di condannare, ma anche di capire – e nel modo in cui egli deve esercitare le funzioni
“Chi domanda giustizia deve poter credere che le sue ragioni saranno ascoltate con attenzione e serietà; che il giudice potrà ricevere ed assumere come se fossero sue e difendere davanti a chiunque”.
Solo così, prosegue Livatino, il cittadino
“potrà cioè fidarsi del giudice e della giustizia dello Stato, accettando anche il rischio di una risposta sfavorevole”.
Nella stessa occasione Livatino affrontava lo spinoso tema della responsabilità civile del magistrato, offrendo un numero considerevole di argomenti che a suo dire sconsigliavano l’azione di responsabilità nei confronti dei magistrati, tutti raccolti nell’idea che tale strumento avrebbe intimidito il giudice, vulnerandone l’indipendenza.
L’analisi che Sciascia svolge al convegno appena ricordato muove da premesse assolutamente sovrapponibili a quelle indicate da Livatino quando avverte che il giudice è titolare di un potere che nessun altro cittadino ha un potere enorme.
Questo potere si giustifica, agli occhi di Sciascia, in funzione dell’esigenza di perseguire la giustizia contro “i poteri”. Ciò che non sarà possibile se il giudice diventa egli stesso “potere”
“Ne viene il problema che un tale potere – il potere di giudicare i propri simili – non può e non deve essere vissuto come potere. Per quanto possa apparire paradossale, la scelta della professione di giudicare dovrebbe avere radice nella repugnanza a giudicare, nel precetto di non giudicare; dovrebbe cioè consistere nell’accedere al giudicare come ad una dolorosa necessità, nell’assumere il giudicare come un continuo sacrificarsi all’inquietudine, al dubbio.”
Come ha osservato Perrone[73], dire ogni volta interamente la verità, quella che è la verità per lo scrittore, significa per Sciascia
“non avere preoccupazione alcuna nel muovere severe critiche al potere, alla classe dominante e alle stesse mode intellettuali ad essi legate”.
Ma questa grande apertura di credito verso il giudiziario si riduce quando Sciascia guarda agli effetti distorsivi prodotti dalla mala giustizia.
E poiché per esercitare quel “potere” ci vuole scienza e coscienza, dice Sciascia, andava trovato un rimedio non contro i buoni magistrati, ma contro i cattivi magistrati. Rimedio che lui stesso individuerà nella responsabilità civile proprio a causa di un esercizio del potere che non è stato rivolto al fine per il quale è stato riconosciuto
“Quando i giudici godono il proprio potere invece di soffrirlo, la società che a quel potere li ha delegati, inevitabilmente è costretta a giudicarli”[74]
Ora il tratto comune che anima la sicilitudine di Sciascia e Livatino sembra dunque ruotare attorno alla consapevolezza della centralità del ruolo del giudice, all’enormità del suo potere, alla indispensabilità del suo ruolo nella società.
Le soluzioni che propongono per rendere accettabile dalla società il ruolo del giudice sono distoniche, ma entrambe intrise di valori comuni che mettono al centro la dignità della funzione giudiziaria, posizionandola su binari paralleli che, tuttavia, si divaricano rispetto all’ottimismo – anche se attentissimo all’etica professionale – di Livatino e al pessimismo di Sciascia sull’amministrazione della giustizia “in concreto”.
9. Il giudice Sciascia
Torniamo ora a ragionare sulla figura del giudice seguendo Sciascia.
Una sola volta Sciascia sembra indossare, forse inconsapevolmente, l’abito del giudice alla ricerca della verità, quando il 7 agosto 1983, a pochi mesi dall’arresto di Enzo Tortora, sulle colonne del Corriere della sera – riprodotto in A futura memoria – assolveva con formula piena il noto giornalista usando un’espressione –
Non mi chiedo: ‘ e se Tortora fosse innocente?’ : sono certo che lo è”.
In quella occasione Sciascia affermava senza tentennamento alcuno
“ho soltanto tenuto conto degli elementi di colpevolezza che i giornali venivano rilevando. Non ne ho trovato uno solo che insinuasse dubbio sulla sua innocenza”
per poi concludere che il metodo utilizzato dai camorristi per accusare Tortora andava accostato ad una autentica follia di criminali, non priva di metodo, consistito nel
“confondere, nell’intorbidire, nel seminare sospetti e accuse, nel coinvolgere quante più persone possibile. Un costruire, insomma, uno di quei castelli di carte che basta poi toglierne una, alla base, perché tutta la costruzione crolli”
E non può non lasciare senza fiato la lettura della sentenza della Corte di Cassazione che quattro anni dopo sembra riprodurre quasi identicamente quel giudizio assolutorio nei confronti di Tortora a proposito della follia del suo principale accusatore e dell’assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia[75]; giudizio senza appello che, pronunziato anni prima, anche a proposito dei 200 casi di persone arrestate per omonimia[76] avevano stupito per la sua radicalità gli stessi ex compagni del partito radicale35.
Un uso della toga che lascerebbe senza parole visto con gli occhi di chi quella toga indossa, proprio per l’attenzione che lo scrittore e storico Sciascia riserva ai fatti, alla loro concatenazione logica, alla loro rappresentazione da parte dei chiamanti in correità e reità.
Un essere giudice di un non giudice che supera idealmente la prova d’esame di concorso in magistratura ma che, al contempo, non ha l’obiettivo di assolvere Tortora quanto di ricercare, ancora una volta, la verità nel rispetto dei diritti della persona. E ciò fa allineando i fatti, le condotte, i personaggi identificandoli, collegandoli con indiscusso rigore logico. Salvo a rammaricarsi, dopo l’assoluzione di Tortora, del fatto che i magistrati impegnati in quel processo non avevano saputo far altro che dileggiare lui e gli intellettuali che avevano espresso opinioni sulla non colpevolezza del giornalista.
Quando Sciascia suggerisce provocatoriamente di far fare ad ogni magistrato, una volta superate le prove d’esame e vinto il concorso, almeno tre giorni di carcere fra i comuni detenuti, e preferibilmente in carceri famigerate come l’Ucciardone o Poggioreale36 non sembra, in definitiva cavalcare una prospettiva di insofferenza e sfiducia verso il corpo magistratuale ma, tutto al contrario, esprimere il desiderio che la visita al carcere possa essere foriera di un più avvertito senso del ruolo del magistrato rispetto al carcere, che si può cogliere solo dopo avere visto il carcere37 e le verità che esso cela. E proprio Calamandrei, anni prima, non aveva mancato di sottolineare che per parlare di carcere bisogna avere subito il dolore che esso provoca[77].
10. Il non giudice Sciascia
Ma quel che dobbiamo chiederci è se davvero a Sciascia interessasse vestire l’abito del giudice o se la sua ricerca della verità fosse semplicemente il frutto di sue personali intuizioni che riteneva di dovere esternare ai suoi lettori e più in generale alla società.
In questa prospettiva, forse, la coincidenza delle sue verità con la verità processuale o con quella più sublime, coincidente con la giustizia perde di rilevanza. A rievocare a ritroso alcune sue prese di posizione su vicende centrali per il nostro Paese – teorema Buscetta[78], omicidio del commissario Calabresi[79] – le opinioni di Sciascia sono esattamente opposte alle verità “processuali” fissate con sentenze passate in giudicato. Mentre la posizione assunta nei confronti di Tortora ha trovato, come si diceva, piena conferma nella sentenza assolutoria definitiva.
Sciascia non voleva, dunque, in alcun modo usurpare la funzione giudiziaria, ma forse rappresentarne la coscienza critica e civile quando come scrittore va alla ricerca della verità:
“Lo scrittore rappresenta la verità, la vera letteratura distinguendosi dalla falsa solo per l’ineffabile senso della verità. Va tuttavia precisato che lo scrittore non è per questo né un filosofo né uno storico, ma solo qualcuno che coglie intuitivamente la verità. Per quanto mi riguarda io scopro nella letteratura quel che non riesco a scoprire negli analisti più elucubranti, i quali vorrebbero fornire spiegazioni esaurienti e soluzioni a tutti i problemi. Sì la storia mente e le sue menzogne avvolgono di una stessa polvere tutte le teorie che dalla storia nascono”[80].
11. La giustizia ed il sentimento ambivalente di Sciascia
Forse è venuto il momento di chiedersi cosa c’è e cosa dovrebbe esserci nella valigetta del giurista secondo Sciascia, visto che è ricorrente la figura dell’avvocato, del giudice, dell’investigatore.
Questo è uno dei punti di analisi che le voci coinvolte nel libro in uscita sapranno indagare.
Cosa c’è e cosa dovrebbe esserci per realizzare o avvicinarsi a quell’anelito di verità e giustizia che Sciascia individua solo per dimostrare che gli uomini hanno fallito, talvolta per incuria, talaltra per malanimo, talaltra ancora per terribile ponderazione e macchinazione di un ordito deliberatamente negazionista della verità giusta e quindi dei valori dell’uomo?
E dunque cosa occorre(rebbe) di più fare per soddisfare e saziare il palato fine di Sciascia? Quanto la ricerca della verità può essere realizzata con gli strumenti a disposizione del giurista di oggi, senza pregiudicare i valori fondamentali dell’uomo? Quanto la complessità che affatica oggi più che mai le giornate del giurista è dominata o quanto è invece vissuta con disappunto, con fastidio, con leggerezza? E quanto la società è oggi disposta a cogliere le intime contraddizioni fra la complessità della società, delle regole, della proteiforme varietà delle fonti normative e giurisprudenziali, e la ricerca spasmodica di una verità, qualunque essa sia, purché espressa nell’atto conclusivo del processo, dell’indagine, della ricostruzione anche solo storica di un fatto?
Proviamo ad andare con ordine.
Quando Sciascia insiste sul ragionamento che dovrebbe star dietro alla giustizia a quale diritto vivente egli pensa, a quello burocraticamente rassicurante e certo, geometrico, meccanico che dunque si aggancia alla regola – recte, alla disposizione – figlio di quel giuridicismo di cui parla, sapientamente, Giovanni Fiandaca nella sua indagine a proposito di Sciascia e la giustizia[81], ovvero pensa ad un diritto ragionato, pensato, complesso, variegato, capace di superare le derive formalistiche, la carta bollata e se vogliamo il testo normativo in nome della ricerca del contesto, per cogliere il quale è necessario attingere alla complessità delle fonti e degli orizzonti che l’interprete avrà il compito di unificare? Pensa al terribile Inquisitore di Diego La Matina, al Primo Presidente della Corte di Cassazione Riches de Il contesto – per il quale “che un imputato l’abbia commessa o no, per i giudici non ha mai avuto importanza”–, al Senato-persecutore della povera Caterina ne La strega e il capitano – al procuratore Giacosa o al giudice istruttore Mari de I pugnalatori ed all’acume, coraggio e pazienza che agli stessi era stato loro attribuito nel costruire l’accusa nei confronti del “notabile” Sant’Elia[82], al giudice Coras de La sentenza memorabile[83], al giudice a latere o ancora al Procuratore generale – attento alla salvaguardia della carriera – o al Presidente della Corte di assise, rigoroso, imperscrutabile e pronto a scaricare silenziosamente il peso e la responsabilità della decisione sul suo a latere, il piccolo giudice di Porte aperte?
Viene agevole pensare che l’ideale di giudice al quale Sciascia sembra ispirarsi sia proprio quello che, pur nel rigoroso rispetto della legge cerca di ritrovare, di scoprire, di “inventare” il comando della legge che possa evitare l’irreparabile, l’ingiustizia, la violazione dei diritti dell’uomo. Solo in questo modo chi pratica la giustizia può dire di esercitare degnamente il “mestiere del giudice”.
Quel mestiere di giudice che, appunto, il protagonista di Porte aperte dichiara di non avere più interesse alcuno a svolgere dopo il suo trasferimento in una piccola pretura di provincia all’indomani del verdetto che aveva escluso la condanna a morte dell’imputato.
Cosa c’è dietro questa ricerca di disvelare la verità non di comodo se non l’attenzione, che pure il giurista dovrebbe coltivare, ad inventare, a scoprire, a scavare nel fondo delle vicende poste al suo vaglio per opporsi all’ingiustizia e, anzi, per estirparla, in modo da dare e ridare all’uomo la sua dignità? E quanto questo non rende ancora più attuale Sciascia in un mondo del diritto sempre più votato e indirizzato verso la postmodernità, per dirla ancora con Grossi, proprio per il caos normativo che costituisce la regola dell’essere giuristi del nostro tempo?
Quando il piccolo giudice a latere di Porte aperte studia l’articolo di dottrina sulla pena di morte reintrodotta dal codice Rocco, non ne condivide le ragioni e si sforza di trovare nella legge il rimedio all’ingiusta pena capitale, quel giudice cosa fa se non esercitare il suo ruolo di interprete del diritto, di vivificatore del comando legislativo, di lettore della legge alla ricerca del suo senso conforme ai diritti fondamentali.
E questo vuol forse suggerire un ossequio formale e cieco alla legge – quello al quale avrebbe aspirato il Presidente della Corte di assise descritto sempre in Porte aperte, in soggezione rispetto al suo giudice a latere sul quale poi pavidamente scarica la responsabilità collegialmente assunta – o, piuttosto evocare nel giudice il dovere di coscienza critica, l’anima della legge, il cuore pulsante della disposizione che diventa norma nell’esercizio della sua concreta applicazione?
Non è, forse, che il giudice, a seguire i lfilo del pensiero sciasciano, potesse ritenersi degno della funzione solo se attinga in profondità il senso della legge aattraverso i plurimi canoni dell’interpretazione, proprio attraverso quell’attività di invenzione del diritto rispetto al fatto, nel senso “buono” che Paolo Grossi echeggia a più riprese nelle sue riflessioni?[84]
E non sarà forse un caso che sia stato proprio Sciascia a dare come titolo ad un’opera dedicata alla “scoperta delle decorazioni di un pittore -Cambellotti- inserita in un edificio commissionato dal regime fascista, quello di “Invenzione di una prefettura. Le tempere di Duilio Cambellotti nel Palazzo del Governo di Ragusa”.
Titolo che disvela certamente il contenuto figurativo del volume, ma nel quale sembra emergere l’idea del complesso ricercare dell’uomo verso ciò che non appare direttamente ma va, appunto, ricercato, trovato, compreso, contestualizzato.
Proprio tutto questo in realtà sembra fare il piccolo giudice quando candidamente dichiara, ripercorrendo i passaggi della decisione:
“Sono convinto di aver fatto il mio dovere di uomo e di giudice; sono convinto di aver lavorato, tecnicamente, con gli argomenti giuridici, come meglio non si poteva”.
Qui viene fuori il mestiere del giudice. Un mestiere duro, difficile, oneroso e per il quale la riconosciuta indipendenza – anche economica – della funzione da ogni altro potere reclama livelli di professionalità e accortezza assai elevati, ai quali Sciascia sembra tenere in modo particolare.
Un giudice che Sciascia avrebbe voluto
“schivo e silenzioso com’era”
amando
“la giustizia schiva e silenziosa, non petulante, la giustizia che non fa spettacolo, la giustizia piena di pudore, la giustizia che alberga nell’animo di tanti anonimi giudici, tanti «piccoli giudici» che ogni giorno, nella sofferenza e nell’angoscia, soli con la propria coscienza, decidono della sorte dei loro simili” [85]
Una qualità probabilmente il giudice deve avere:
“il candore: mettersi di fronte ad un caso candidamente, senza prevenzioni, senza riserve”. Con queste parole Sciascia tratteggiava la figura di Cesare Terranova, ricordando che “aveva lo sguardo di un bambino”[86]
Ma quel magistrato dovrebbe essere, anche d’eccezionale intelligenza, dottrina e sagacia non solo ma anche – e soprattutto – di eccezionale sensibilità e di netta e intemerata coscienza…[87] capace di esercitare quella funzione tenendo conto dell’opinione pubblica, ma nemmeno non tenendo conto.
12. La vicenda del mostro di Marsala e la metafora delle veritù.Nessuna certezza sul pensiero sciasciano e tanti dubbi.
Un dubbio peraltro mi assale quando sono quasi al termine di questa riflessione ed è quello che sia davvero improbo cercare la verità di Sciascia sulla giustizia, la sua verità e rappresentarla come tale, al punto che quanto fin qui rappresentato possa essere esso stesso frutto di una indebita trasfigurazione del pensiero sciasciano.
Questo dubbio si è andato insinuando progressivamente ricostruendo diacronicamente la vicenda del c.d. mostro di Marsala alla quale si è già fatto cenno in precedenza.
Ma questa possibile “verità” sul ruolo della giustizia non è l’unica, per Sciascia.
Un passaggio di Sciascia sulla vicenda del mostro di Marsala contenuto in Nero su nero è forse dimostrativo dell’ambivalenza del pensiero di Sciascia sulla giustizia e sulla verità.
Da un lato Sciascia loda l’operato del Procuratore che ha individuato il colpevole dell’uccisione delle tre vittime riconoscendo che il magistrato non si era lasciato fuorviare dalle apparenze e maldicenze, cercando la verità “finì col trovarla”.
Per altro verso Sciascia dimostra quanto la ricerca della verità affidata ad un giudice potrebbe essere e rimanere fallace, ancorché nel caso di Marsala, a suo dire, i dubbi sull’operato del Procuratore espressi dal giudice istruttore (Libertino Russo) sulla complicità di un ipotetico mandante erano dei falsi dubbi nati dall’applicazione del metodo mafioso – quello della chiamata in correità che lo stesso Vinci avrebbe fatto nel corso del processo circa un ipotetico mandante “ricco” degli omicidi.
Da qui la conclusione di Sciascia che il processo contro il mandante non andava celebrato, non potendosi auspicare che ai ricchi
“ne faccia vendetta la “giustizia”. “Non mandare mai a chiedere per chi suona”: se la campana della “giustizia” suona a morto”24.
Il richiamo ad Hemingway e ad uno dei suoi più celebri romanzi – che pure campeggiava nella libreria di mio padre – sembra avere un che di funesto quasi, forse, a volere dimostrare che quella della giustizia suona sempre – o quasi sempre – “a morto”.
E proprio questo viaggio nella ricerca della verità che Sciascia compie a proposito della vicenda del mostro di Marsala (Vinci) sembra essere esemplare per i protagonisti, tre magistrati, Ciaccio Montalto, Terranova e Borsellino che hanno avuto nella vicenda un ruolo particolare, intrecciandosi a loro volta con la figura di Sciascia.
Dunque, Sciascia sembra, come si diceva, per un verso lodare l’attività inquirente di Terranova, rivolta a non incolpare sulla base di dicerie o elementi deboli e per altro verso guardare non di buon occhio il giudice istruttore (del quale il Pubblico Ministero Giangiacomo Ciaccio Montalto avrebbe condiviso l’impostazione, dichiarandosi dubbioso circa la responsabilità esclusiva del Vinci) che voleva instillare il dubbio che l’attività inquirente non fosse stata completa sulla base di uno strumento tipico dei processi di mafia, la chiamata in correità.
Sciascia sembra avere trovato la verità che sembra coincidere con quella della giustizia umana.
Va però rimarcato che sarebbe stato proprio Ciaccio Montalto a ribellarsi alla verità creduta anche di Sciascia con una requisitoria che sembrava essere ispirata da quella verità che Sciascia invocava a gran voce:
“Non può ritenersi che l’ordinamento giuridico quale categoria ed entità morale possa riconoscersi in una sentenza la quale abbia realmente mutato il bianco in nero ed alla menzogna abbia conferito l’autorità e la forza della verità. E sento il dovere (o, forse, meglio, il diritto) di ricordare che la verità, anzi l’ansia di verità, non può subire coartazioni per ragioni di opportunità o per qualsivoglia altra ragione da chiunque provenga perché si dicano determinate cose o se ne tacciano altre”[88] . Quello stesso Ciaccio Montalto che sarebbe stato, invece, individuato come colui che era andato alla ricerca della verità nel processo “Vinci” da Vincenzo Consolo una verità diversa da quella processualmente accertata.
E non può a questo punto non stupire che a molti anni di distanza, di fronte alla verità processuale conclamata da una sentenza di condanna divenuta definitiva a carico del Vinci per la vicenda qui ricordata sarebbe stato proprio Paolo Borsellino a riaprire il caso per cercare una nuova verità sulla base delle accuse del condannato Vinci. Procedimento poi peraltro archiviato.
Dunque, a riaprire il caso ed a porre in discussione la verità processuale che Sciascia aveva ritenuto giusta sarebbe stato proprio, sulle orme dei dubbi che Ciaccio Montalto aveva espresso nel corso del dibattimento di primo grado, quel Paolo Borsellino identificato, almeno dalle cronache, come essemplo[89] di professionista dell’antimafia dallo stesso Sciascia e, in definitiva, come nume tutelare di un modo di combattere la mafia “ingiusto”, tutto fondato sull’ingiusto sistema delle chiamate in reità e correità.
E sempre il caso volle che i tre magistrati che si occuparono della vicenda del mostro di Marsala – Terranova, Ciaccio Montalto e Borsellino – siano stati assassinati dalla mafia.
Tutti accomunati da un tremendo destino che li ha consacrati come autentici servitori dello Stato, morti per cercare in modo vibrante la verità.
E non è un caso, allora, che la figlia del giudice Borsellino, Fiammetta, insieme agli altri familiari, a quasi trent’anni dalla morte di suo padre, reclami in modo tambureggiante il diritto alla verità sull’uccisione del magistrato, implicitamente evocando la lezione sciasciana su quell’esigenza di verità, individuale e collettiva, imprescrittibile.
E non è un caso, ancora, che Sciascia venga spesso ricordato visivamente in una fotografia con lo stesso Borsellino mentre, entrambi seduti a tavola, sembrano sereni, portatori di espressioni del volto “vere” ed autentiche, ancorché il primo sia stato individuato dallo stesso Borsellino come l’autore di quell’articolo sui professionisti dell’antimafia che cominciò a fare morire Giovanni Falcone, in quell’ormai storico discorso pronunziato a Casa Professa il 25 giugno 1992.
Quanto di sciasciano e di tragicamente pirandelliano nelle vicende appena rammentate e nei protagonisti, forse a conferma di quello che avrebbe dovuto essere l’epitaffio che lo stesso Sciascia aveva scelto per sé, come lo aveva espresso il La Sicilia come metafora:
“Ha contraddetto e si è contraddetto’, come a dire che sono stato vivo in mezzo a tante ‘anime morte’, a tanti che non contraddicevano e non si contraddicevano”.
Una ricerca di verità che vibra nelle corde dei diversi protagonisti e che evidenzia quanto l’ansia estrema di verità di Sciascia – come la definisce il diplomatico Roccella poco prima di essere ucciso ne Una storia semplice[90] – sia davvero il sentimento che anima le persone per bene, non destinato ad acquietarsi[91], ma sempre di più in bilico, in un equilibrio instabile e complesso, al punto che peccherebbe davvero di falsità ed impostura chi intendesse rappresentare in modo inoppugnabile la verità di Sciascia.
Chi si ponesse come interprete fedele e autentico di Sciascia finirebbe, in definitiva, per tradirlo, mistificandone le ricerche e dimenticandone il pensiero, e soprattutto il senso finale della sua ricerca della e delle verità.
Quando Sciascia afferma di avere detto “qualche inoppugnabile verità”, ma al contempo di avere in altre occasioni fallito, ma mai in malafede[92], sembra voler dire che per rispondere al quesito finale - Chi può mai trovare la verità? - è il procedere per approssimazioni, per dati esperienziali, a dare alimento alle passioni, senza le quali una moderna democrazia non può vivere, pur con le contraddizioni ed i nodi problematici che non sempre potranno sciogliersi.
Tutti siamo fallibili, ma almeno proviamo ad esserlo vivendo fino in fondo e con coscienza il nostro tempo, rifiutandoci di scendere a compromessi. Poi sbaglieremo, inciamperemo, cadremo, ma almeno, con la coscienza a posto.
Bene ha fatto, dunque Domenico Cacopardo nel chiudere le sue riflessioni su Sciascia e la giustizia con questo “monito”:
“E il senso di giustizia di Leonardo Sciascia si esercita e si afferma proprio nel non dichiarare chiusa la sua personale istruttoria nei confronti della Sicilia e dell’Italia: nessuno ha l’ultima parola, nessuno chiude alcunché. Tutto scorre in un limaccioso alveo di fiume, nel quale l’acqua pulita, quando c’è, è una effimera chiazza che si dissolve in breve tempo”[93].
Ed è stato bello, qui, provare ad indossare, forse indegnamente, i panni del piccolo giudice di Porte aperte, pur consapevole di non esserne all’altezza, ma semmai di renderne testimonianza attiva.
I molti “sembra” ed i molti interrogativi che hanno preceduto ed accompagnato queste riflessioni troveranno sicuramente conferme o smentite ben più consistenti nelle riflessioni, avvertite e articolate, che animano il volume “Diritto verità giustizia” e potranno finalmente tornare in soffitta, avendo esaurito il compito, invero assai stimolante, di mero co-istigatore di questa splendida scommessa-ricerca che “Diritto verità e giustizia” secondo Sciascia ha per chi scrive rappresentato.
*Sono grato a Tecla Mazzarese e ad Antonio Ruggeri per la lettura dello scritto, del quale nondimeno solo io porto la responsabilità.
[1] M. Collura, Il maestro di Regalpetra, Milano, 2019, 117.
[2] C. Ambroise, 14 domande a Leonardo Sciascia, in Leonardo Sciascia, Opere, 1956-1971, a cura di C. Ambroise, Milano, 1987, XIII.
[3] C. Ambroise, 14 domande a Leonardo Sciascia, in Leonardo Sciascia, Opere, cit., XIV.
[4] M.Ferro, La collusione dei poteri nel Contesto di Leonardo Sciascia, in Quotidiano giuridico, gennaio 2020; A. Centonze, La giustizia e la ricerca della verità giudiziaria secondo Leonardo Sciascia, in questa Rivista, 29 febbraio 2020 e, ibidem, A. Apollonio, Il magistrato di Sciascia: eroe e anti-eroe tra "verità" e "giustizia".
[5] M. Collura, Il maestro di Regalpetra, 272.
[6] M. Collura, L’isola senza ponte. Uomini e storie di Sicilia, Milano, 2007, 195.
[7] J. Francese, Leonardo Sciascia e la funzione sociale degli intellettuali, Firenze University Presse, 2012, 24.
[8] M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., 159.
[9] L. Sciascia, La strega e il capitano, Milano, 1999, 65. V., sul punto N. Panichi, Verità della menzogna, menzogna della verità. Sciascia legge Montaigne, in Todo modo, 2015, 47
[10] L. Sciascia, Opere, a cura di P. Squillacioti, Milano, 2014, v.II, Tomo I, 1912+1, 884.
[11] C. M. Martini - G. Zagrebelsky, La domanda di giustizia, Torino, 2003,54.
[12] L. Sciascia, Sicilia e sicilitudine, in La corta pazza. Saggi letterari, storici e civili, ora in Opere, a cura di P. Squillacioti, Milano, 2019, Vol. II, Tomo II, cit., 233.
[13] L. Sciascia, Fatti diversi di storia letteraria, in L. Sciascia, Opere, cit., vol II, Tomo II, 989: “I siciliani, dirà parlandoci di Verga, Pirandello 'quasi tutti hanno un'istintiva paura della vita, per cui si chiudono in sé, appartati, contenti del poco, purché dia loro sicurezza. Avvertono con diffidenza il contrasto tra il loro animo chiuso e la natura intorno aperta, chiara di sole, e più si chiudono in sé, perché di questo aperto, che da ogni parte è il mare che li isola, cioè che li taglia fuori e li fa da soli, diffida o, e ognuno è e si fa isola da sé, e da sé si gode – ma appena, se l'ha – la sua poca gioia; da sé, taciturno, senza cercare conforti, si soffre il suo dolore, spesso disperato. Ma ci sono quelli che evadono”. Ed ancora L. Sciascia, Emilio Greco, in L. Sciascia, La corda pazza. Scrittori e cose della Sicilia, in Opere, cit., Vol.II, Tomo II, 452.
[14] E. Romano Belfiore, La mafia si combatte con le leggi, diritto e potere, verità e giustizia nel pensiero di Leonardo Sciascia, in Criminalia, 2010, 600.
[15] V. le considerazioni sul punto già espresse in Il giudice disobbediente del terzo millennio, Intervista di R. Conti a V. Militello, D. Galliani e G. Silvestri, in questa Rivista, 5 giugno 2019.
[16] R. Scarpinato, « L’egida impenetrabile»: mafia e potere nell’opera di Leonardo Sciascia, in Giustizia e letteratura, a cura di G. Forti, C. Mazzucato, A. Visconti, Milano, 2014, 224: “occorre che i magistrati non si lascino corrompere o non siano omologati al potere.”
[17] L. Sciascia, Alfabeto pirandelliano, in L. Sciascia, Opere, Vol. II, Tomo II, cit., 969.
[18] Papa Francesco, Misericordia e Giustizia, 3 febbraio 2016, in www.vatican.va
[19] V.AA.VV., L’eredità di Leonardo Sciascia, a cura di C. De Caprio e C. Vecce, Napoli, 2012, Introduzione, 8.
[20] Sullo stesso punto si sofferma L. Bianchi, “Il secolo educatore”: Leonardo Sciascia e l’Illuminismo, in L’eredità di Leonardo Sciascia, cit., 49.
[21] V, di recente, sul tema R. Spano, Rule of Law: la Lodestar della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte di Strasburgo e l'indipendenza della Magistratura, in questa Rivista, marzo 2021.
[22] V.L. Sciascia, Alfabeto pirandelliano,, cit.,971. Sul tema v., anche L. Sciascia, Pirandello e il pirandellismo, in Opere, cit., Vol. II, Tomo II, 95 ss, in cui Sciascia ricorda, altresì, la novella “La verità” scritta da Pirandello nel 1912, nella quale si realizza “ il paradigma del mondo pirandelliano: dalla verità di Tararà alla consapevole lucida acuta sofisticazione di Ciampa”.
[23] Quanto questo atteggiamento, culminato negli insuccessi della giustizia che vengono scolpiti ne Una storia semplice – malgrado l’arguzia del brigadiere Lagardana – e in Il Giorno della civetta – ove pure il capitano Bellodi sembra approdare alla verità pur non giungendo ad alcun risultato di “giustizia, sia stato influenzato, in tutto o alche solo in parte, da alcuni episodi che videro lo stesso Sciascia a contatto diretto con la giustizia, in occasione della triste vicenda giudiziaria nella quale rimase coinvolto il padre o dell’altra, che lo vide aspramente contrapposto a Berlinguer, non è dato sapere da chi qui scrive – sul punto v. M. Collura, Il maestro di Regalpetra, cit., pagg.159 e 300 –.
[24] V. ancora, sulla centralità della figura del Prof.Franzò, J. Francese, Leonardo Sciascia e la funzione sociale degli intellettuali, cot.,133.
[25] S. Borzì, Vita e diritto: da Il mistero del processo di Satta a Porte aperte di Sciascia, in L. Pogliaghi (a cura di), Giustizia come ossessione. Forme della giustizia nella pagina di Leonardo Sciascia, Milano, La Vita Felice, 2005, 78: “Dal rifiuto del formalismo deriva la continua insistenza sullo stretto rapporto tra la vita dell'uomo e la legge. Quest'ultima, per assolvere alla funzione che le è propria, deve innanzi tutto garantire il rispetto della dignità dell'uomo, evitando di tradursi, come nel formalismo, in fredda e inumana attuazione di una norma. Del resto, se la norma meccanicamente applicata garantisse, essa sola, la giustizia, non si spiegherebbe come alcune situazioni, che nascono dall' attuazione di quelle norme, possano essere palesemente ingiuste”.
[26] M. Taruffo, Processo e verità nella transizione, in M. Taruffo, Verso la decisione giusta, 133.
[27] N. Panichi, Verità della menzogna, menzogna della verità. Sciascia legge Montaigne cit., 52.
[28] N. Pachini, Verità della menzogna, menzogna della verità. Sciascia legge Montaigne, in Todo modo, 2015,V, 52.
[29] Al tema della verità e di quanto essa abbia condizionato l’opera letteraria di Sciascia dedica particolare attenzione il volume di recente edito, a cura di A. Apollonio, Verità impossibili. Voci dalla magistratura siciliana sull’opera di Leonardo Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2020 e, in particolare, la prefazione del curatore, della quale si riporta il passo, denso di significato della pag.11: “la verità esiste ma – essendo le cose del mondo ordinate sulla base di decisioni prese d’imperio e calate dall’alto, conformi alla legge e all’opportunità del momento – la verità non è possibile raggiungere: la si può solo prospettare, teorizzare e persino narrare (è questo lo spirito con cui vengono costruiti La scomparsa di Majorana e l’j). Il mondo sarebbe dunque una fittissima trama di verità impossibili, puntualmente soffocate dalle verità costituite. Quando Sciascia, in una delle sue frasi più celebri e ripetute (tratta appunto dall’Affaire), afferma: «Bisogna rifondare la verità se si vuole rifondare lo Stato» vuol dire esattamente questo: è lo stesso concetto di verità che deve essere rimodulato: deve essere anzitutto liberato dal giogo del potere, dalla sua manipolazione”.
[30] R. Scarpinato, «L’egida impenetrabile»: mafia e potere nell’opera di Leonardo Sciascia, cit., 224:“perché la verità si manifesti al livello istituzionale, perché assuma una forma legale occorre la volontà e la collaborazione di tutta la polis.”
[31] S. Rodotà, Il diritto alla verità, in G. Resta e V. Zeno-Zencovich (a cura di), Riparare, risarcire, ricordare: un dialogo tra storici e giuristi, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, p. 498; id., Il diritto alla verità, in Id., Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari, 2012, pp. 211 ss.
[32] Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della commemorazione delle vittime della strage di Bologna, in www.quirinale.it.
[33] S. Battaglia, La verità pubblica di Leonardo Sciascia, «Il Dramma», 5, maggio 1970, 218.
[34] Bellissimo il saggio dedicato a Sciascia da G. Tranchina, Leonardo Sciascia: e quanto parleremo di giustizia «ce ne ricorderemo, di questo pianeta»?, Relazione svolta, il 17 novembre 1994, nell’Aula magna della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania, in occasione del Convegno su «La giustizia nella letteratura e nello spettacolo siciliani tra ‘800 e ‘900, da Verga a Sciascia, in Quando parleremo di giustizia, Palermo, 2010, 19.
[35] M. Collura, L’isola senza ponte, cit., 197.
[36] L. Ferrajoli, Magistratura e democrazia, 28 luglio 2021, in Questione giustizia.
[37] R. G. Conti, Il diritto alla verità, fra amnistia, prescrizione e giurisprudenza nazionale della Corte edu e della Corte interamericana dei diritti umani, in Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte interamericana dei diritti umani: modelli ed esperienze a confronto, a cura di R. Romboli e A. Ruggeri, Torino, 2019, 237.
[38] Cfr. Interpellanza n.2-00243 dell’On. L. Sciascia, riportata da A. Camilleri, Un onorevole siciliano, Le interpellanze parlamentari di Leonardo Sciascia, Milano, 2009, 43: “Noi non vogliamo che le forze dell’ordine – che veramente desideriamo siano tali senza dimostrare gratuitamente la forza, e portatrici di un ordine che nulla abbia a che fare con la violenza – vengano quotidianamente mandate allo sbaraglio…e personalmente ritengo che debbano essere messi a loro disposizione strumenti legislativi più adeguati al corso delle cose, ma senza mai venir meno ai principi costituzionali”.
[39] L. Sciascia, Il contesto, cit., 116: “La ragion di Stato: c’è ancora, come ai tempi di Richelieu. E in questo caso è coincisa con la ragion di Partito... L’agente ha preso la più saggia decisione: uccidere anche Rogas ... Non potevamo correre il rischio che scoppiasse una rivolu- zione ... Non in questo momento”.
[40] M. Taruffo, Verità e giustizia di transizione, in Criminalia, 2015, 23: “Prendendo ora in considerazione una dimensione per certi versi più specifica, ma di valenza non meno generale, va sottolineato che il principio di verità si configura come condizione essenziale per l’effettività dell’ordinamento giuridico. Se è vero, come pare indubbio, che le norme giuridiche, singolarmente e nel loro insieme, sono destinate a regolare i comportamenti dei consociati, pare altrettanto evidente che questa finalità verrebbe completamente frustrata qualora i cittadini pensassero che la violazione delle norme non comporterebbe alcuna conseguenza o provocherebbe conseguenze del tutto casuali, e qualora non vi fosse nessuna ipotesi credibile circa le conseguenze delle condotte dei singoli, siano esse conformi o contrarie a quanto prevedono le norme giuridiche. In altri termini, l’effettività dell’ordinamento giuridico si fonda sull’ipotesi che il sistema sia in grado di stabilire la verità rispetto a tali condotte, dato che solo in questo caso le relative conseguenze sarebbero conformi a ciò che l’ordinamento prevede”
[41] M. Taruffo, Verità e giustizia di transizione, cit., 22.
[42] A. Ruggeri, La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi), in Consulta online, n. II/2018 (3 giugno, http://www.giurcost.org/studi/ruggeri76.pdf).
[43] M. Damilano, Un atomo di libertà, Aldo Moro e la fine della politica in Italia, Milano, 2018, ricorda testualmente il passo di Moro: “La verità più profonda delle cose è nella ideale sintesi di valore e fatto, per cui la verità vive essenzialmente nella storia… Per ciò è bello vivere”.
[44] M. Damilano, Un atomo di libertà, Aldo Moro e la fine della politica in Italia, cit.: “C’è un’altra verità da cercare, quella di cui scrisse Moro in una delle sue ultime lettere disperate e mai consegnate a Riccardo Misasi…” “Quello che io chiedo al partito è uno sforzo di riflessione in uno spirito di verità” aveva scritto il Presidente, ora prigioniero, a rischio della vita. “Perché la verità, cari amici, è più grande di qualsiasi tornaconto. Datemi da una parte milioni di voti e toglietemi dall’altra parte un atomo di verità, ed io sarò comunque perdente. Lo so che le elezioni pesano in relazione alla limpidità ed obiettività dei giudizi che il politico è chiamato a formulare. Ma la verità è verità”…Ma negli ultimi giorni della sua vita, in maniche di camicia, con un foglio di carta a quadretti e una penna da cartoleria come sola arma a disposizione per farsi sentire, con la coscienza come unica voce da ascoltare, Aldo Moro aveva concluso che tutto si racchiudeva in questo, un atomo di verità, più resistente di milioni di voti. Un atomo di verità, un granello di verità…” Più di recente v. l’assai interessante webinar dedicato al tema Il diritto alla verità https://www.facebook.com/MEMOMediatecaMontanari/videos/591814995097707/ con M. Damilano e F. Messina.
[45] F. Messina, Il diritto alla verità. Presentazione dell’incontro con Marco Damilano – 3 giugno ore 18.00 – diretta su “zoom” e bacheca Facebook “Memoteca Montanari”, in questa Rivista, 1 giugno 2020.
[46] A. Gelmi, Sollevare la verità alla superficie, un itinerario sciasciano, in Todomodo, II, 2012, 168.
[47] A. Piras, Oltre la cronaca «l'affaire Moro» tra storia e letteratura, in Todomodo, Il, 2012, 224.
[48] R. G. Conti, Il diritto alla verità, fra amnistia, prescrizione e giurisprudenza nazionale della Corte edu e della Corte interamericana dei diritti umani, in Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte interamericana dei diritti umani: modelli ed esperienze a confronto, cit.
[49] S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, op. cit., 224.
[50] V. Il giudice disobbediente nel terzo millennio. Intervista d. R.G. Conti a G. Silvestri, V. Militello e D. Galliani, cit.
[51] R. Scarpinato, « L’egida impenetrabile»: mafia e potere nell’opera di Leonardo Sciascia, in Giustizia e letteratura, cit., 221: “Dunque far emergere la verità, raccontare la realtà quale essa è e quale non trova spazio in quella ufficialità che è occupata dal potere, costituisce un importante atto di opposizione civile.”
[52] G. Tranchina, Leonardo Sciascia, cit., 28, nel descrivere la figura ideale di giudice: “E la sola via che gli è aperta a tal fine – avverte ancora Carnelutti – è quella di sentire la sua miseria: bisogna sentirsi piccoli per essere grandi»
[53] V. Intervento On. L. Sciacia, Camera dei deputati del 23 gennaio 1980, in A. Camilleri, Un onorevole siciliano, Milano, 2009, 53: “Già la giustizia in Italia non è mai stata celere e si sa che uno degli elementi costitutivi e primari della giustizia è la prontezza con cui viene amministrata, ma affermare che arrivando dopo una dozzina di anni può significare ancora giustizia, vuol dire appunto avere smarrito il senso della realtà.”
[54] Non è, allora, un caso, che la giurisprudenza della Corte edu abbia escluso che la lunghezza del processo non è ex se dimostrativa della violazione dell’art.6 CEDU- cfr. Corte edu, Pirozzi c. Belgio (n. 21055/11), 17 aprile 2018, ove la Corte ha osservato che “delay in prosecuting a crime does not, necessarily and in and of itself, render criminal proceedings unfair under Article 6” - par.26-.
[55] V. Maimone, Il caso Davide Cervia, Torino, 2020, 159, in ci si ricorda la vicenda del sequestro di persona del militare, le vicende dei familiari e la sentenza del Tribunale di Roma il 23 gennaio 2018, nella quale il diritto alla verità venne configurato, come espressione degli artt.2 e 21 Cost., come “diritto ad acquisire, senza ostacoli illegittimamente posti, informazioni e conoscenze ritenute utili o necessarie, sia in sé, sia quali precondizione per l’esercizio di altri diritti fondamentali. Ogni attività, fatto o comportamento che impedisca, limiti o condizioni l’acquisizione di informazioni lede conseguentemente quel diritto”.
[56] Sul ruolo di tali Commissioni v. M. Taruffo, Verità e giustizia di transizione, cit., 21 ss. Quanto all’esperienza brasiliana, in particolare U. Celli, Il diritto alla verità nell’ottica del diritto internazionale: il caso brasiliano, in Annali della facoltà giuridica dell’Università di Camerino, n. 6/2017, 212 (https://afg.unicam.it/sites/d7.unicam.it.afg/files/CELLI_DirittoVerit%C3%A0.pdf).
[57] L. Sciascia, La Sicilia come metafora. Intervista di Marcelle Padovani, Milano, 1987, 87.
[58] M. Di Lello Finuoli, L'intreccio tra 'Verità' e 'Giustizia' nelle opere di Leonardo Sciascia, in Giustizia e letteratura, a cura di G. Forti, C. Mazzucato, A. Visconti, cit., 257 ss.
[59] D. Perrone, Scrittura e verità nell’opera di Leonardo Sciascia, L’eredità di Leonardo Sciascia, Atti dell’incontro di studi Napoli 6 - 7 maggio 2010 - Palazzo Du Mesnil, a cura di C. De Caprio e C. Vecce, Napoli, 2012, 31.
[60] C. Ambroise, Verità e scrittura, in L. Sciascia, Opere, 1956-1971, a cura di C. Ambrosie, Bompiani, Milano 1987, pp. XLIV-XLV.
[61] L. Bossi, La verità storica nel Consiglio d'Egitto di Leonardo Sciascia, tra finzione politica e impostura letteraria, in Todomodo, VIII, 2018, 129.
[62] L. Sciascia, Tradimenti e fedeltà, La Stampa, 6 agosto 1988 e in, A futura memoria (se la memoria ha un futuro), Firenze, 1989, 154- pure in L. Sciascia, Opere, cit., 1310.
[63] Anche se va detto che non sono mancati nella dottrina processualistica esempi virtuosi rivolti a ricercare nella conclusione del processo “la verità” anche per effetto dell’opera proattiva del giudice. Per tutti, v. il terzo capitolo di M. Taruffo, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Laterza, Roma-Bari, 2009; M. Taruffo, Tre divagazioni intorno alla verità, in M. Taruffo, Verso la decisione giusta, Torino, 2020, spec.128 ss. Ma v., in diversa prospettiva, anche B. Cavallone, In critica alle posizioni di Taruffo, In difesa della veriphobia (considerazioni amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo), in Riv.dir.proc., 2010, 1.
[64] P. Grossi, Il diritto civile in Italia tra moderno e posmoderno-dal monismo legalistico al pluralismo giuridico, Milano, 2021, sul quale v. M. Serio, Riflessioni su “Il diritto civile in Italia tra moderno e posmoderno-dal monismo legalistico al pluralismo giuridico” di Paolo Grossi, in questa Rivista, 24 giugno 2021.
[65] L. Sciascia, Atti relativi alla morte di Raymond Roussel, in Opere, Tomo I, Vol. II, cit., 255.
[66] L. Sciascia, Atti relativi alla morte di Raymond Roussel, cit., 270.
[67] L. Sciascia, Semplice discorso sul caso Tortora, sul caso giustizia e sui casi nostri, riportato in A futura memoria, (se la memoria ha un futuro), in Opere, cit., Vol.II, Tomo II, 1248.
[68] Per tutti, G. Fiandaca, La giustizia secondo Leonardo Sciascia, in Todo Modo, 2019, 157.
[69] G. Zagrebelsky, La giustizia come professione, Torino, 2021, 144.
[70] M. Taruffo, Verità e giustizia di transizione, cit., 38: “Se un’indagine viene svolta – magari senza particolare energia – a venti o trent’anni di distanza, può essere difficile scoprire le prove di quanto è accaduto, soprattutto quando – come spesso accade – esse sono nelle mani degli stessi organi (Stato, esercito, polizia, paramilitari) di cui hanno fatto parte i responsabili. In questi casi, che rappresentano la quasi normalità, è evidente che le prove sono sparite, sono state nascoste o sono state distrutte.”
[71] Ed infatti, in Il quarantotto, in Gli zii di Sicilia, Milano, 1992, 174 ss., premiato con l’assegnazione del premio “Libera Stampa” a Lugano – su cui v. Il Quarantotto da Gli zii di Sicilia di Sciascia. Recensione di Rosalia Centinaro, 11 gennaio 2016, in www.gaspareagnello.it – Sciascia così si esprimeva, dando voce al capitano Ippolito Nievo: “io credo nei siciliani che parlano poco, nei siciliani che non si agitano, nei siciliani che si rodono dentro e soffrono: i poveri che ci salutano con un gesto stanco, come da una lontananza di secoli; e il colonnello Carini sempre così silenzioso e lontano, impastato di malinconia e di noia ma ad ogni momento pronto all'azione: un uomo che pare non abbia molte speranze, eppure è il cuore stesso della speranza, la silenziosa fragile speranza dei siciliani migliori… una speranza, vorrei dire, che teme se stessa, che ha paura delle parole ed ha invece vicina e famigliare la morte… Questo popolo ha bisogno di essere conosciuto ed amato in ciò che tace, nelle parole che nutre nel cuore e non dice…”.
[72] L. Sciascia, Il calzolaio di Messina, in L. Sciascia, Fatti diversi di storia letteraria, in Opere, cit.,Vol. II, Tomo II, 1024, citando Tilgher sul contenuto della tragedia – Il calzolaio di Messina rappresentata al teatro Odelaschi di Roma nell’aprile del 1925 in uno spettacolo allestito da Luigi Pirandello – : “si configurava come un urto tra due opposti atteggiamenti dello spirito, come antinomia di due contrarie concezioni della Giustizia: l’una per la quale la Giustizia è atto essenzialmente sociale, funzione impersonale e anonima dello Stato, l’altra per la quale la Giustizia è idea dell’animo individuale, oggetto di adorazione fanatica”. V., poi, nello stesso racconto, il commento di Sciascia alla stessa vicenda, ricordando la genesi della tragedia ed il racconto di Denis Diderot -Entretien d’un père avec ses enfantes- in cui l’autore individua la storia del calzolaio di Messina “come apologo di una specie di aporia della giustizia, nel conflitto fra il diritto oggettivo e il diritto naturale, tra la giustizia delle leggi e la vera giustizia” (p.1035).
[73] D. Perrone, Scrittura e verità nell’opera di Leonardo Sciascia, cit., 32.
[74] L.Sciascia, La dolorosa necessità del giudicare, Il Giudice, cit.
[75]Cass.pen., 13 giugno 1987, pagg. 223 e 226, in https://www.csm.it//documents/21768/121598/Cassazione+n.+3492+del+13+giugno+1987+parte+terza/a7dbdc0b-3230-431f-8763-03cec1b28024
[76] L. Sciascia, Semplice discorso sul caso Tortora, sul caso giustizia e sui casi nostri, in Corriere della sera, 14 ottobre 1983, e in A futura memoria, cit., 1253.
[77] P. Calamandrei, Bisogna aver visto, Il ponte, 1949.
[78] L. Sciascia, Ma la mafia non ha una sola cupola, Corriere della sera, 27 dicembre 1987, ed in A futura memoria (se la memoria ha un futuro), in Opere, cit., 1305.
[79] L. Sciascia, Scopriamo chi ha ucciso Pinelli, in L’espresso, 28 agosto 1988.
[80] L. Sciascia, La Sicilia come metafora, (Intervista di M. Padovani), 81 ss.
[81] G. Fiandaca, La giustizia secondo Leonardo Sciascia, cit., 160. Indagine di recente ripresa in occasione del webinar organizzato dall’Università di Palermo in memoria di L. Sciascia il 15 aprile 2021 sul tema Leonardo Sciascia tra giustizia sperata e giustizia negata: una ambivalenza irriducibile,
[82] L. Sciascia, I pugnalatori, in L. Sciascia, Opere, cit., 408.
[83] Figura, peraltro, non facilmente decifrabile quella del giudice Coras, come nota J. Francese, Leonardo Sciascia e la funzione sociale degli intellettuali, cit., 120, in qualche modo vittima, forse inconsapevole, dell’ennesima impostura.
[84] V., sul punto, S. Borzì, Vita e diritto: da Il mistero del processo di Satta a Porte aperte di Sciascia, cit., 77.
[85] G. Tranchina, Leonardo Sciascia, cit., 30.
[86] L. Sciascia, L’espresso, 7 ottobre 1979, e poi in A futura memoria (se la memoria ha un futuro), in Opere, cit., 1197.
[87] L. Sciascia, Per la responsabilità dei magistrati, in Corriere della sera, 7 agosto 1983, poi in A futura memoria, (se la memoria ha un futuro), in Opere, cit., 1246.
[88] Cfr. V. Consolo, Esercizi di cronaca, Palermo, 2013, 68.
[89] Sull’uso di questo termine v., ad es, L. Sciascia, La strega e il capitano, Milano, 1999, 75. V. anche J. Francese, Leonardo Sciascia e la funzione sociale degli intellettuali, cit., 123.
[90] R. Romano, Sciascia e la sua «Storia semplice», in Le forme del comico, Atti delle sessioni parallele del XXI Congresso dell’ADI (Associazione degli Italianisti) Firenze, 6-9 settembre 2017, a cura di Francesca Castellano, Irene Gambacorti, Ilaria Macera, Giulia Tellini Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2019, 1378.
[91] Come è lo stesso Sciascia a testimoniare nell’esergo dedicato in Una storia semplice a F. Dürrenmatt ed al saggio da quest'ultimo edito, Giustizia, Milano, 2011. Saggio nel quale l’autore svizzero, tratteggiando a più riprese e con profondo disincanto il mondo della giustizia ed i suoi protagonisti, non manca di ricordare che “non occorre che un giudice sia giusto, così come non occorre che il papa sia credente – Giustizia, cit., 170 –.
[92] L. Sciascia, Tradimenti e fedeltà,in La Stampa, 6 agosto 1988, e in Opere, cit., 1311.
[93] D. Cacopardo, Sciascia 2019: il suo senso della giustizia, quanto mai attuale ..., in TP24, 21 novembre 2019.