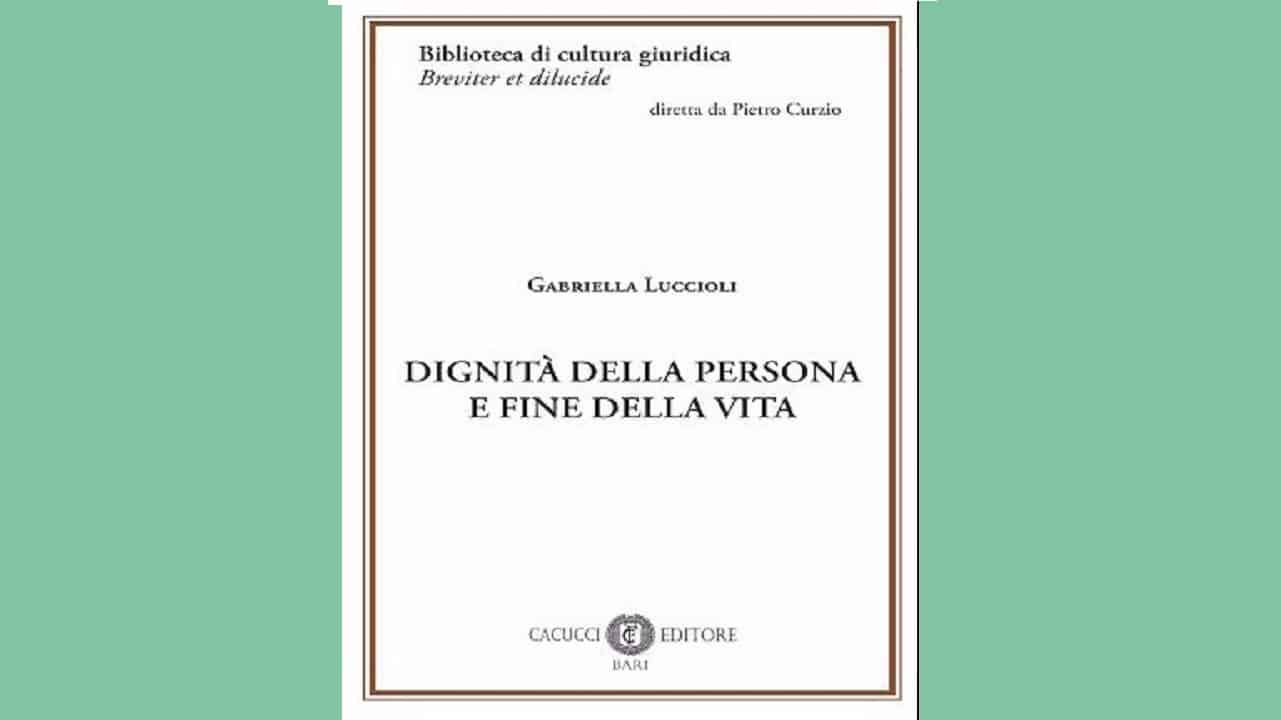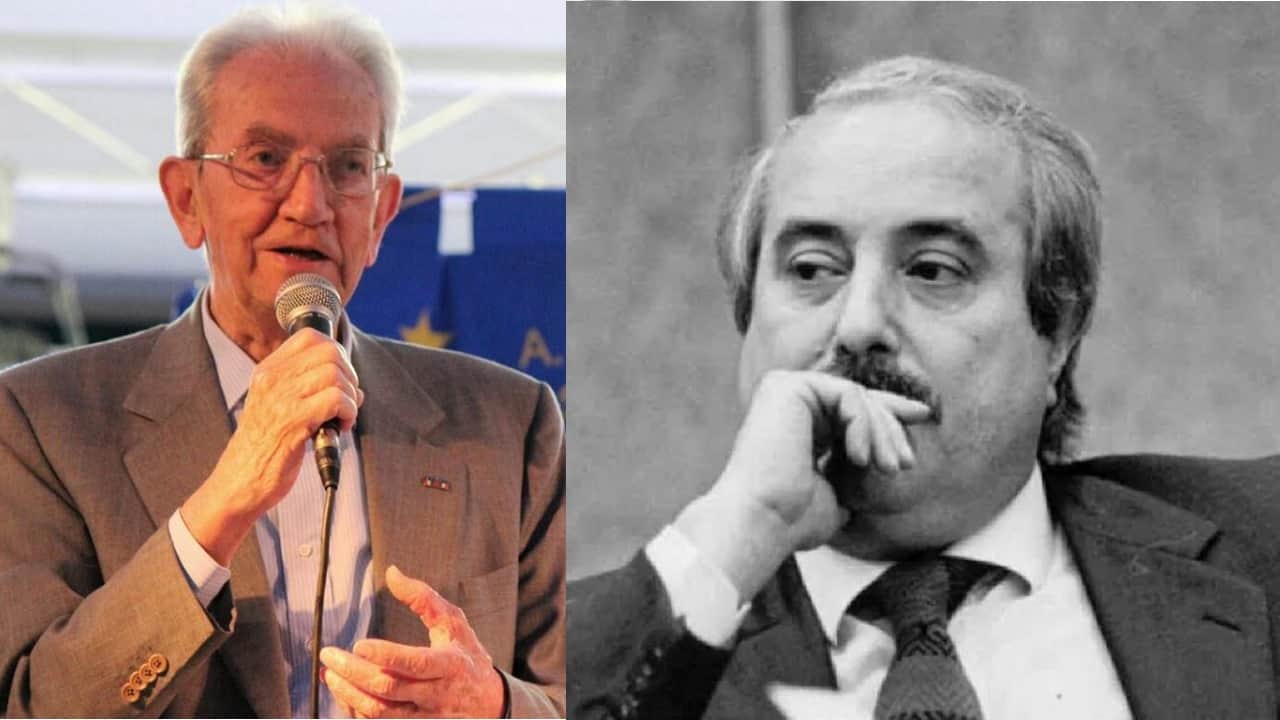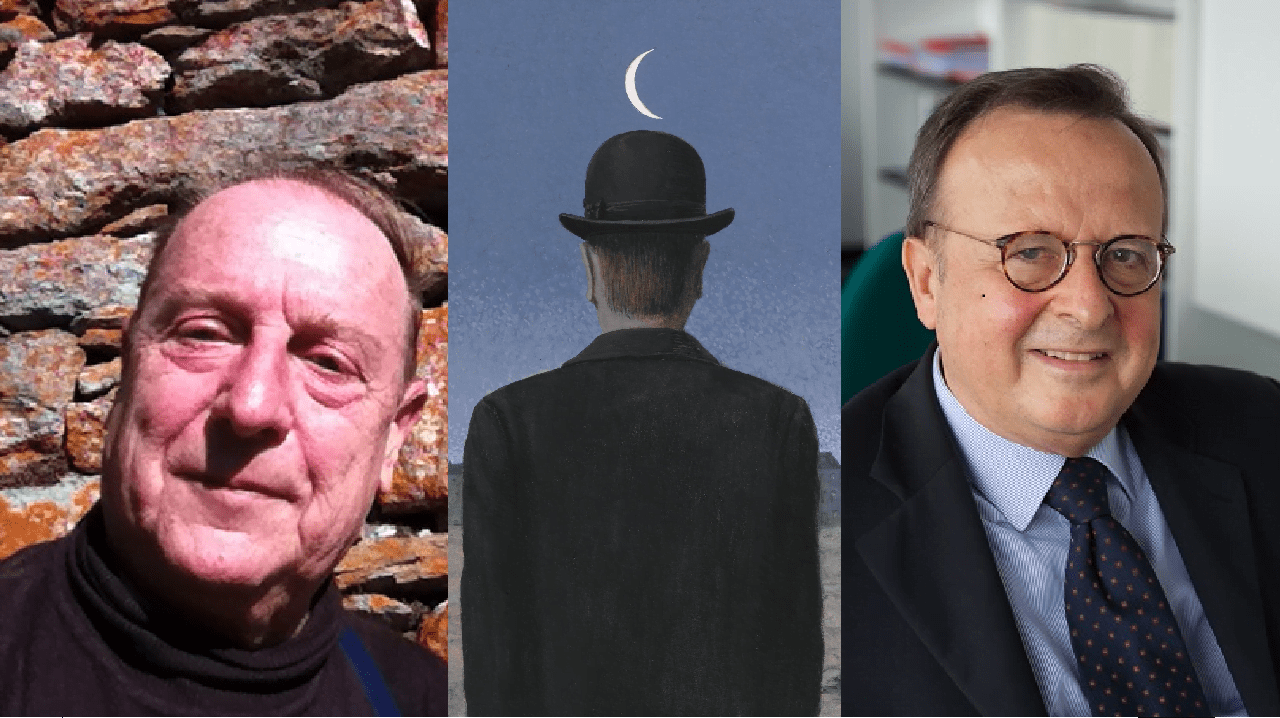
CEDU e cultura giuridica. 4) La Corte edu vista dai suoi giudici
Intervista di Roberto Giovanni Conti a Guido Raimondi e Vladimiro Zagrebelsky
1. Le domande. 2. La scelta del tema. 3. Le risposte. 4. Le conclusioni. 5. L’intervista in pdf.
1.Le domande
1) Qual è, alla luce dell’esperienza da Lei maturata all’interno della Corte edu, il futuro dei rapporti fra giudice nazionale e Corte di Strasburgo?
2) La Sua precedente appartenenza alla giurisdizione nazionale quanto e in che modo ha inciso sul ruolo esercitato all’interno della Corte edu?
3) L’autonomia e indipendenza della giurisdizione nazionale da ogni altro potere dello Stato in che misura è assimilabile a quella dei giudici incardinati nella Corte edu?
4) Quali sono, a Suo giudizio, le sfide che attendono la Corte Edu nel prossimo futuro, con particolare riferimento alla gestione dei ricorsi diretti, ai tempi di definizione dei relativi procedimenti e al ruolo del margine di apprezzamento? E quali quelle che si porranno al giudice nazionale rispetto al suo ruolo di giudice comune della Convenzione dopo l'entrata in vigore del Protocollo n.16 annesso alla CEDU, ma non ancora reso esecutivo in Italia?
2. La scelta del tema
Roberto Giovanni Conti
Un’occasione forse unica quella concessa a Giustizia Insieme di mettere insieme le riflessioni e opinioni di due personalità di spicco del mondo giudiziario italiano accomunate dall’avere trascorso un lasso di tempo significativo presso un’Istituzione giudiziaria – la Corte europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo – diversa e “altra” rispetto a quella nazionale.
Tanto si è detto e scritto sulla Corte edu e sulle questioni che ruotano attorno al suo ruolo nei sistemi nazionali. Poco si è riflettuto sui medesimi temi orientando la lente su chi ha operato in quella Corte in qualità di giudice “nazionale”.
Si è, allora, qui cercato di mettere in evidenza, nella domande proposte, aspetti sui quali l’attenzione è spesso risultata attenuata, orientando le risposte sul cosa significa essere giudice nazionale in un’istituzione giudiziaria sovranazionale, quale apporto viene offerto e richiesto dai giudici che compongono la Corte edu, quanto essi si distaccano dall’ordinamento di provenienza e quanto diverso sia il modo di “essere giudici” e di “fare giustizia” di quella Corte rispetto alle Corti nazionali. Senza ovviamente tralasciare i temi più caldi, rappresentati dal ruolo della Corte edu nell’affermazione e protezione dei diritti umani e delle sfide che si porranno nel prossimo futuro.
Non poteva, peraltro, mancare una sollecitazione rivolta a riflettere sul presente e futuro dei rapporti fra le giurisdizioni nazionali e la Corte edu.
3.Le risposte.
Qual è, alla luce dell’esperienza da Lei maturata all’interno della Corte edu, il futuro dei rapporti fra giudice nazionale e Corte di Strasburgo?
Guido Raimondi
Direi che i rapporti tra il giudice nazionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo sono il futuro del sistema europeo di protezione dei diritti umani.
Solo la comune consapevolezza, dalle due parti, di lavorare per un obiettivo comune, che è quello della piena tutela dei diritti previsti dalla Convenzione europea, in armonia con la protezione assicurata dalle Costituzioni nazionali, può garantire la vitalità futura della Corte europea dei diritti dell’uomo e lo sviluppo ulteriore della sua già ricchissima giurisprudenza, che spetta essenzialmente alle Corti nazionali di far vivere nel quotidiano.
Naturalmente non penso che le Corti nazionali debbano essere confinate in un ruolo di semplici esecutori. Credo che il “dialogo” tra le Corti – pensando all’interazione tra il livello giurisdizionale nazionale e quello europeo – non debba essere a senso unico. È ben possibile che la Corte di Strasburgo sia chiamata a riconsiderare taluni approdi della sua giurisprudenza alla luce di posizioni differenziate assunte dai giudici nazionali.
È celebre il caso della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito del 2011, nel quale la Corte ha modificato l’orientamento espresso a livello di Camera sulle esigenze convenzionali legate alla escussione dei testimoni nel processo penale alla luce della sentenza nel caso Horncastle che era stata adottata nel frattempo dalla Corte suprema britannica.
Credo che oramai si possa parlare di un clima di crescente fiducia tra i giudici europei e quelli nazionali.
Se si pensa, sul versante nazionale, a ciò che è accaduto nel nostro Paese, certamente non un campione di entusiasmo, nei primi anni di applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in Italia, ci sono ragioni che spingono all’ottimismo.
Dopo le chiusure, anche di natura psicologica, del passato, si è affacciata e poi affermata, dapprima timidamente, e al puro livello tecnico dell’attività interpretativa della giurisprudenza, poi finalmente al livello delle coscienze dei giuristi, l’idea di quello che si tende oggi a chiamare ordinamento integrato, l’idea cioè dell’esistenza di un nucleo di valori europei, che, senza negare la diversità e il pluralismo delle culture e dei popoli stanziati sul nostro continente, concorrono a formare il concetto d’identità europea, il quale si traduce in principi e regole giuridiche che i giudici nazionali ed europei insieme, di qui la necessità del dialogo tra di loro, concorrono a far vivere e a tradurre in pratica.
Si parla oggi di tutela multilivello dei diritti fondamentali e, come dicevo, di ordinamento integrato, come se fossero novità, ma in effetti nessuna spettacolare integrazione di ordinamenti si è verificata negli ultimi tempi. Se integrazione vi è, e, in effetti, è così, questa si è prodotta sin dal momento dell’introduzione nell’ordinamento italiano delle pertinenti norme internazionali, e in particolare, per quanto riguarda il c.d. “diritto di Strasburgo”, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, con la legge (4 agosto 1955, No. 848) che ne ha autorizzata la ratifica e ne ha ordinata l’esecuzione nell’ordinamento italiano. Ciò che è mutata, e di molto, negli ultimi decenni, è la sensibilità dell’interprete interno nei confronti di questi valori giuridici. È noto che questo mutamento si è prodotto attraverso un cammino faticoso e accidentato, ma oggi possiamo constatare che vi è una notevole sensibilità dei giudici italiani verso i valori convenzionali. Un percorso analogo si è compiuto negli altri Paesi parti della Convenzione, più rapido in taluni, più lento in altri, ma oggi vi è una generale accettazione, direi anzi condivisione, da parte dei giudici nazionali di tutta Europa di questi valori.
Dal lato della Corte europea dei diritti dell’uomo sono visibili i segnali di attenzione e di richiesta di leale collaborazione rivolti ai giudici nazionali.
In certi casi la giurisprudenza di Strasburgo assume un aspetto “promozionale”. Un esempio è la sentenza nel caso Ndidi c. Regno Unito, del settembre 2017, nella quale – si trattava di verificare la conformità all’art. 8 della Convenzione, che protegge la vita privata e familiare, dell’espulsione di uno straniero – la Corte ha affermato che quando essa sia chiamata a determinare, come era in quel caso, se la misura statale litigiosa abbia assicurato un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, non è necessario rifare ex novo la valutazione di proporzionalità già assunta dal giudice nazionale. Al contrario, quando le Corti nazionali abbiano esaminato i fatti con cura, applicando gli standard in materia di diritti umani in modo coerente con la Convenzione e la giurisprudenza europea, e proceduto ad un adeguato bilanciamento dell’interesse del ricorrente con l’interesse generale, la Corte non deve sostituire la propria valutazione a quella del giudice nazionale.
Personalmente, durante il mio tempo alla presidenza della Corte, ho fatto della cooperazione tra il giudice europeo dei diritti umani e i giudici nazionali l’assoluta priorità del mio mandato.
Ponendo l’accento sulla responsabilità condivisa per la buona applicazione della Convenzione, s’intende condivisa tra il livello europeo e quello europeo, ho cercato di dare impulso alla conclusione di protocolli d’intesa con Corti superiori nazionali, supreme e costituzionali, e alla Rete delle Corti superiori europee.[1]
La Rete è un progetto relativamente modesto dal punto di vista delle risorse che vi sono impiegate, perché consiste essenzialmente di una piattaforma per lo scambio di informazioni sulle giurisprudenze rispettive delle Corti partecipanti, ma ha un grande valore, anche simbolico ed emblematico della volontà dei giudici nazionali e di quello europeo di lavorare insieme.
A partire dal 2016, quando la Rete è uscita dalla fase sperimentale, limitata alle giurisdizioni superiori del Paese ospite, la Francia, ed è entrata nella sua fase multilaterale, essa ha conosciuto un’espansione che ha superato tutte le attese. Costituita da 23 corti superiori di 17 Stati alla fine del 2016, essa ha percorso un cammino impressionante. In effetti, al giorno d’oggi essa conta 82 Corti di 38 Stati parti della Convenzione. Per l’Italia partecipano la Corte costituzionale, la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Tutte queste giurisdizioni hanno concluso con la Corte europea dei protocolli d’intesa, come ha fatto anche il Consiglio superiore della magistratura.
La Corte ha la responsabilità di far evolvere questo progetto in maniera utile, di ascoltare i partecipanti, di riflettere e di individuare delle vie appropriate per il suo sviluppo. Certamente in futuro si dovrà avanzare con prudenza per accompagnare lo sviluppo della Rete verso una piattaforma ancora più compiuta di scambi sulla giurisprudenza della Convenzione e su quelle nazionali. In ogni caso, in circa tre anni di esistenza, la Rete ha ampiamente dimostrato la sua utilità.
Accanto allo sviluppo della Rete spero che si moltiplichino in futuro i contatti diretti, specie quando vi siano problemi specifici, che spesso possono risolversi quando ci si incontra personalmente, e che continui il fondamentale dialogo attraverso la giurisprudenza.
Il ghiaccio è rotto, direi, e questo lascia bene sperare per il futuro.
Vladimiro Zagrebelsky
Vi sono due aspetti del rapporto tra i giudici nazionali e la giurisprudenza della Corte europea. Però il tema riguarda tutte la autorità nazionali e non solo quelle giudiziarie. Si tratta di esaminare la fase in cui il giudice (o il governo o il parlamento) deve assumere decisioni in linea o non in contrasto con gli obblighi che l’Italia ha assunto entrando nel sistema europeo di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare ratificando la Convenzione europea dei diritti umani. Si tratta poi di vedere come le autorità nazionali danno esecuzione a specifiche sentenze (e provvedimenti provvisori urgenti) della Corte europea nei confronti dell’Italia. Non mi soffermerò su quest’ultimo punto se non per segnalare che, diversamente da quanto avviene per altri paesi del Consiglio d’Europa, continua a mancare in Italia una legge generale che disciplini la materia. Di conseguenza gli organi giudiziari si trovano spesso nella necessità di inventare soluzioni volta per volta, utilizzando strumenti che nascono ad altri fini.
Quanto al primo profilo invece la questione investe la natura della giurisprudenza della Corte europea, che esprime la interpretazione e la portata attuale dell’obbligo che gli Stati hanno assunto ratificando la Convenzione. Il contenuto dell’obbligo deriva dalla interpretazione (evolutiva) elaborata dalla Corte (art. 32 Conv.). In tal senso si è espressa più volte anche la Corte costituzionale, a partire dalle due sentenze del 2007, anche se successivamente in vari modi essa ha ridotto la portata della affermazione di principio che quelle due sentenze avevano enunciato. In particolare, con la sentenza n. 49/2015, la Corte ha limitato l’obbligo derivante dall’art. 117 Cost. riconoscendo solo la giurisprudenza “consolidata” della Corte europea. Ho criticato altrove quella sentenza (Corte cost. n. 49 del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, art. 117 Cost., obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione, in «Osservatorio Aic», 2015) e non riprenderò qui i motivi per cui ritengo che essa sia incompatibile con il sistema della Convenzione. Rilevo soltanto che la giurisprudenza della Cassazione si è prontamente allineata. Un esempio recente riguarda la sentenza delle Sezioni Unite sulla estensione ad altri del principio affermato dalla Corte europea nella sentenza Contrada c. Italia (n. 3) del 14 aprile 2015. Osservo da un lato che l’esame delle sentenze della Corte costituzionale, che considerano la giurisprudenza della Corte europea -ai fini dell’art. 117 Cost. o della interpretazione da dare alle norme costituzionali-, mette in luce atteggiamenti non omogenei nella gestione del principio enunciato nella sentenza 49/2015. Sono infatti frequenti le sentenze che contengono approfondito studio della giurisprudenza della Corte europea, senza cercare di distinguere la giurisprudenza consolidata da quella che consolidata non sarebbe. In ogni caso la forte limitazione della rilevanza della giurisprudenza europea ai fini dell’art. 117 Cost. e prima ancora per l’interpretazione orientata alla Convenzione, espone l’Italia a violazione della Convenzione e sollecita la proposizione di ricorsi alla Corte europea. La Corte (in Parrillo c. Italia, 27 agosto 2015, § 100) si è già pronunciata negativamente rispetto a tale orientamento, restrittivo rispetto alla Convenzione “così come interpretata dalla Corte europea”.
Ciò detto, va d’altro lato rilevato che le sentenze della Corte europea e la loro successione pongono talora gravi difficoltà al giudice che voglia dar loro il rilievo che, in linea di principio, meritano. Talora la ratio decidendi è tutt’altro che chiara, poiché la Corte tende ad accumulare argomenti senza che risulti evidente ciò che vale in generale e ciò che è proprio della specificità del caso, ciò che appartiene alla motivazione e ciò che è semplice obiter dictum, ciò che è decisivo e ciò che è enunciato solo ad adiuvandum (come forse al § 196 della già citata Parrillo c. Italia). La Corte europea dovrebbe maggiormente preoccuparsi di come le sue sentenze possano essere tenute in conto (“eseguite”) da parte delle autorità nazionali e dei giudici in particolare (non solo nello Stato parte nel giudizio). Inoltre le oscillazioni giurisprudenziali della Corte europea (recentemente le vicende relative al bis in idem, alla sovrappopolazione carceraria, alla confisca urbanistica), non sempre nel senso della progressiva estensione dei diritti e delle libertà fondamentali, creano un problema serio. La Corte costituzionale, che potrebbe essere indotta a dichiarare una incostituzionalità ex art. 117 Cost., per poi vedere la Corte europea ritornare sui suoi passi. Ciò che -indipendentemente dalla sua incompatibilità con il sistema convenzionale- spiega l’orientamento della Corte costituzionale che si pone alla ricerca di una giurisprudenza europea “consolidata”.
L’opera del giudice nazionale che si impieghi a ricercare il senso della giurisprudenza europea pertinente rispetto al caso che è chiamato a decidere, è spesso difficile. In fondo è la stessa Corte europea che ne dà testimonianza quando le sue sentenze sono rese a maggioranza e le opinioni dissidenti offrono una ricostruzione dei precedenti della Corte difforme rispetto a quella adottata dalla maggioranza. Ciò dimostra che l’insieme dei precedenti spesso consente ricostruzioni diverse. La difficoltà non esime il giudice nazionale dall’impegnarsi nella ricerca della ratio, che regge le sentenze della Corte europea e nell’esporre ampiezza e profondità della ricerca effettuata per giustificare le conclusioni raggiunte in sede nazionale. La Corte europea ha più volte dato dimostrazione della considerazione che essa assegna all’orientamento manifestato in proposito dal giudice nazionale rispetto alla Convenzione (come in Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca, 17 dicembre 2004, §§ 37, 71). Canone generale -e qualche volta contrastante con le leggi “generali e astratte”- è che la Convenzione tende a garantire “diritti concreti ed effettivi e non teorici e illusori”. A tale scopo dovrebbe essere tesa la applicazione delle leggi nazionali.
Se vogliamo impegnarci sul piano del futuro rapporto tra il giudice italiano e la Corte europea con la sua giurisprudenza, forse possiamo dire che la crescente disponibilità dei giudici a dar peso alla giurisprudenza europea metterà sempre più in crisi la nozione di legalità che privilegia disposizioni legislative dettagliate e “astratte”, a favore di leggi aperte alla considerazione del caso concreto (in tal senso va la giurisprudenza della Corte costituzionale, critica rispetto alle norme ad applicazione “automatica”).
La Sua precedente appartenenza alla giurisdizione nazionale quanto e in che modo ha inciso sul ruolo esercitato all’interno della Corte edu?
Guido Raimondi
Le Corti costituzionali e supreme nazionali sono l’interlocutore naturale della Corte di Strasburgo.
Normalmente, per effetto della regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte europea si trova a operare avendo a sua disposizione una decisione della Corte costituzionale o suprema del Paese convenuto. Nella maggior parte dei casi la questione sottoposta alla Corte è stata già esaminata dalla Corte più alta dello Stato interessato, ed è dunque con la soluzione che è stata data dalla Corte nazionale che quella europea si deve confrontare.
Anche se i giudici della Corte di Strasburgo hanno diverse provenienze professionali (oltre all’alta giurisdizione, essenzialmente l’accademia e l’avvocatura) essi hanno evidentemente pari dignità.
Ciò detto, per quanto osservavo prima, la Corte ha un interesse tutto particolare nella stima dell’impatto che le proprie sentenze avranno nel sistema giuridico del Paese interessato. Dunque, poter immaginare quale sarà la reazione ad una sentenza europea della Corte suprema o della Corte costituzionale di un Paese è cosa di grande valore agli occhi dei giudici europei, ciò che crea condizioni favorevoli ad un ascolto particolarmente attento dei colleghi che, per l’appunto, provengono da Corti supreme o costituzionali nazionali.
Posso testimoniare del rispetto che ho potuto constatare per il sistema giuridico italiano, soprattutto per il riconoscimento della reale indipendenza del sistema giudiziario del nostro Paese e della sua eccellenza tecnica. Naturalmente i problemi di efficienza del nostro sistema non solo sono ben conosciuti dalla Corte, ma hanno fornito ad essa molto lavoro, come sappiamo tutti, ma questo non esclude una grande stima per la qualità del nostro “prodotto giuridico”.
Quindi la mia provenienza dalla Corte di cassazione mi ha collocato subito in una posizione di credibilità presso i miei colleghi. Devo aggiungere di aver potuto beneficiare della tradizione, nel senso che tutti i giudici italiani che mi hanno preceduto, Giorgio Balladore Pallieri, Carlo Russo, Benedetto Conforti e Vladimiro Zagrebelsky, erano circondati da grande stima e rispetto.
Personalmente ho sempre sentito come continua, permanente e sempre viva l’appartenenza alla Corte di cassazione, per cui considero tra i momenti più alti del mio mandato di Presidente della CEDU i miei incontri con i vertici della Corte italiana, a Strasburgo e a Roma. Vorrei ricordare in particolare la visita a Strasburgo del compianto Primo Presidente Giorgio Santacroce che, accompagnato da Lei, siglò l’11 dicembre 2015 l’atto preliminare al Protocollo d’intesa tra le due Corti, e quella di una delegazione della Corte di cassazione condotta dal Primo Presidente Aggiunto, Renato Rordorf, in rappresentanza del Primo Presidente Giovanni Canzio, che firmò il Memorandum del 26 maggio 2016. Vorrei rendere omaggio all’impegno per la cooperazione con la Corte di Strasburgo dei due Primi Presidenti che ho nominato, e anche dell’attuale Primo Presidente, Giovanni Mammone, che non ha mai fatto mancare il suo appoggio a questo grande progetto.
Vladimiro Zagrebelsky
La risposta a questa domanda è difficile. In ogni caso posso esprimere una opinione solo legata alla mia esperienza nella Corte nella sua composizione nel periodo 2001-2010. La personalità di ogni singolo giudice della Corte e i rapporti che si instaurano tra i giudici sono determinanti. Ciò premesso direi che l’attitudine dei giudici della Corte che hanno in precedenza esercitato funzioni giudiziarie in sede nazionale si diversifica -in linea molto generale- da quella dei giudici provenienti dall’Università per una maggiore attenzione alle particolarità del caso da decidere, rispetto ai profili di carattere più generale. Ma si tratta di impressione di scarsa importanza, che però consente di segnalare il valore della discussione tra giudici di diversa caratterizzazione professionale (oltre che, e più ancora della diversa origine nazionale).
La mia esperienza giudiziaria, precedente alla elezione alla Corte europea, è stata certo talora utile per la conoscenza che implicava di realtà legali e di prassi proprie del sistema italiano: conoscenza da segnalare ai colleghi nel corso della discussione in camera di consiglio. Ricordo un caso contro l’Italia riguardante un ricorso per indennizzo per ingiusta detenzione. La Sezione della Corte di cassazione aveva cassato senza rinvio una sentenza della Corte d’appello rilevando un difetto nella nomina del difensore del ricorrente e ciò aveva fatto ignorando l’interpretazione della legge già indicata dalle Sezioni Unite. I colleghi giudici a Strasburgo manifestavano stupore, non riuscendo a credere che un simile contrasto di interpretazione potesse manifestarsi nell’ambito dello stesso organo giudiziario. Potei spiegare che ciò derivava dalla interpretazione che i giudici italiani danno della loro indipendenza. Spiegai, senza convincere. Il ricorso fu dichiarato ricevibile e per fortuna intervenne poi un amichevole componimento. A proposito della persistenza in Italia di orientamenti giurisprudenziali contrastanti persino nell’ambito della Corte di cassazione, è strano che ricorsi ex art. 6 Conv. che si ripetono contro altri Paesi (es. Romania) non vengano introdotti contro l’ltalia. Forse non è diffusa la conoscenza della giurisprudenza della Corte europea sul punto.
Straordinaria -e direi brutale per la sua immediatezza- è la rivoluzione culturale imposta a un giudice di civil law (penalista come nel mio caso, in più!), proiettato in un mondo di concetti giuridici e di metodi di decisione delle cause profondamente diverso da quello proprio del sistema giuridico da cui proviene. Si tratta di modificare l’atteggiamento professionale proprio di chi è un “prodotto” della cultura giuridica di un sistema di civil law, verso quello che molto assomiglia al metodo e alla cultura dei giudici di common law. Basti dire che l’interpretazione della Convenzione (e delle sue vaghe formule, cariche di elementi di valutazione) e la risposta ai quesiti posti dai singoli ricorsi passano per il richiamo ai precedenti tratti dalla giurisprudenza della Corte europea: precedenti che sono in linea di fatto vincolanti (salvo mutamento, come esito della eccezionale procedura della Grande Camera) e rispetto ai quali i giudici operano con il metodo del distinguishing, cercando gli elementi del caso che consentano (o invece impediscano) di giungere ad una conclusione diversa da quella indicata dai precedenti relativi a ricorsi analoghi. Il metodo del precedente, nel quadro di una giurisprudenza casistica, è forse la maggior ragione della forte torsione professionale cui è sottoposto un giudice italiano quando inizia il suo lavoro alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
L’essere il «giudice nazionale» italiano non mi pare però che abbia inciso in modo significativo, nel senso di differenziare il mio lavoro da quello degli altri colleghi. Pur con i vincoli derivanti dal valore del precedente nella giurisprudenza della Corte, i margini che rimangono aperti alla valutazione individuale del giudice nella decisione della causa sono ampi. Basti pensare al criterio della «proporzione» dell’interferenza statale nel caso concreto. La proporzione, molto più che la legalità astratta, è il fondamentale carattere della ricerca della Corte ai fini della decisione del caso, insieme al peso dato a ciascun diritto o libertà, quando più di uno entri in concorrenza nel caso concreto. Negli spazi aperti alla valutazione di proporzione e bilanciamento emerge l’inclinazione personale del singolo giudice (come quando si tratti della libertà di espressione in contrasto con la protezione della riservatezza della vita privata). Indipendentemente dalla origine nazionale di ciascuno ed anche dall’orientamento politico dei governi che li hanno inseriti nella lista dei candidati, ho notato manifestarsi delle stabili sintonie tra giudici diversi nelle diverse materie. Esse riflettono le comunanze o le diversità degli orientamenti culturali rilevanti nella decisione di un caso o dell’altro. L’Europa esiste sul terreno dei diritti umani. Essa non è monolitica, ma per fortuna pluralista. Le differenze di orientamento esistono e sono anche profonde, ma di manifestano in modi simili in ciascuno dei paesi europei. In linea di principio e spesso nella realtà, ciascun giudice europeo si orienta senza considerare le frontiere che dividono l’Europa.
L’orientamento di ciascuno produce “appartenenze” di natura culturale, che non hanno carattere nazionale.
Quanto ho ora esposto invita a qualche considerazione sul ruolo del «giudice nazionale» nella discussione e decisione dei casi concernenti lo Stato da cui egli origina. Furono i governi, nel corso dei lavori preparatori della Convenzione, a imporre la composizione della Corte con un giudice per ciascuno Stato parte della Convenzione. La commissione che redasse il progetto aveva indicato invece la soluzione di un numero fisso di giudici (nove), indipendente da quello degli Stati parte. Era evidentemente un modo per sottolineare la differenza che esiste tra un organo giudiziario indipendente, composto da giudici indipendenti, e gli organismi politico-amministrativi internazionali in cui ogni Stato ha un suo rappresentante, voce del governo. I giudici sono indipendenti e partecipano ai lavori della Corte a titolo individuale; non sono rappresentanti del Paese a titolo del quale sono stati eletti. Discende dalla logica che prevalse al momento della redazione della Convenzione, che il giudice “eletto a titolo” dello Stato che è parte nel giudizio, sia obbligatoriamente membro del collegio giudicante. Si ritiene che nella discussione e deliberazione collegiale possa utilmente entrare la voce di chi meglio degli altri conosce il sistema nazionale. Libero naturalmente il giudice di esprimersi e votare come ritiene giusto. Tuttavia, la previsione e l’appellativo stesso di “giudice nazionale” assegnato al giudice nella funzione ora detta, pone qualche problema. Escluso che il giudice sia rappresentante, è egli almeno in qualche misura «rappresentativo» del paese di provenienza? Ma in quale modo o misura può esserlo? L’orientamento culturale prevalente nell’ambito di un paese è nozione di difficile o nulla consistenza. I diritti e le libertà riconosciuti e protetti dalla Convenzione europea sono numerosi e diversi. È possibile essere inclini a spingere molto avanti la protezione e valorizzazione dell’uno ed essere invece piuttosto prudenti nei confronti di un altro. In società pluralistiche come sono quella italiana e generalmente quelle europee, ciascuno di noi si ritrova su posizioni (e in compagnie!) diverse, tema per tema, questione per questione. Nel mosaico di culture che vivono (anche in modo conflittuale) nel Paese, il giudice “eletto a titolo dell’Italia” si trova ad essere espressione, volta per volta, di una delle diverse Italie, che coesistono e si confrontano in tutta legittimità storica e culturale. Di ciò trovo conferma nel fatto che talora la stessa causa vede, in fasi diverse, intervenire una persona diversa nella funzione di “giudice nazionale” (ad esempio per l’intervenuta scadenza del mandato del precedente giudice). È accaduto che il nuovo “giudice nazionale” si sia orientato diversamente da quanto ha fatto il primo. Non è dunque la “nazionalità” che conta, ma la personale inclinazione culturale.
Talora la posizione di «giudice nazionale» -che nella Convezione ha una portata solo procedurale- induce e sollecita la pretesa negli ambienti politici e di opinione pubblica nazionale che il giudice difenda quelli che sono creduti gli interessi o gli orientamenti culturali del paese. Con la conseguenza che in caso diverso emerge l’accusa di slealtà, tradimento, ecc., specialmente in tempi di intolleranza crescente. E la pretesa di assicurarsi un giudice su cui fare affidamento nella difesa dell’interesse del governo convenuto in giudizio davanti alla Corte, può comparire poi al momento della designazione da parte del governo della terna di candidati da proporre al Consiglio d’Europa.
L’autonomia e indipendenza della giurisdizione nazionale da ogni altro potere dello Stato in che misura è assimilabile a quella dei giudici incardinati nella Corte edu?
Guido Raimondi
Il tema dell’indipendenza della giurisdizione è evidentemente cruciale, assieme a quello dell’eccellenza tecnica dei giudici e della loro integrità morale, per la credibilità della giurisdizione, a livello interno come a livello internazionale.
All’indipendenza dei giudici, ovviamente di quelli nazionali, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedicato una grande attenzione, giudicando che la sua importanza va oltre lo stretto ambito della giurisdizione, essendo l’indipendenza della giustizia condizione indispensabile per la realizzazione ed il mantenimento della democrazia e della preminenza del diritto, quindi delle premesse imprescindibili perché un sistema di protezione dei diritti fondamentali possa esistere.
In particolare, la giurisprudenza ha tratteggiato l’importanza fondamentale dell’articolo 6 della Convenzione, che prevede le garanzie del giusto processo, tra le quali l’indipendenza delle corti, spesso associata all’imparzialità. Il ruolo eminente di questa disposizione, nell’ambito del fondamentale principio della preminenza del diritto (Rule of Law) è sottolineato con grande forza.
E a sua volta la preminenza del diritto è condizione indispensabile della democrazia per come questa è intesa nella Convenzione. In alcune sue celebri pronunce, come Delcourt c. Belgio del 17.1.1970 (§ 25), De Cubber c. Belgio del 26.10.1984 (§ 30), Moreira de Azevedo c. Portogallo del 23.10.1990 (§ 66), la Corte ha detto con chiarezza che, in una società che possa dirsi democratica ai sensi della Convenzione, il diritto a un’equa amministrazione della giustizia occupa un posto di tale rilievo che un’interpretazione restrittiva dell’articolo 6 non corrisponderebbe allo spirito e alla ratio di questa disposizione. Nell’altrettanto celebre caso Sunday Times c. Regno Unito, sentenza del 26.4.1979, la Corte ha detto che il diritto a un’equa amministrazione della giustizia “consacra la preminenza del diritto in una società democratica”.
Il tema è dunque particolarmente sentito alla Corte.
Detto questo, i parametri che la giurisprudenza della Corte ha elaborato per valutare l’indipendenza dei giudici nazionali ruotano intorno a quattro elementi, cioè le procedure di nomina di giudici, la durata del loro mandato, le garanzie e le protezioni contro possibili pressioni esterne e l’apparenza.
Volendo applicare tali parametri agli stessi giudici che ne sono gli autori, direi che il risultato è grosso modo soddisfacente. Dico grosso modo perché il risultato finale dipende dal grado di correttezza e buona fede con il quale gli Stati applicano la Convenzione. Ciò sia al momento della selezione e dell’elezione dei giudici della Corte, sia durante il loro mandato sia alla conclusione di questo, specialmente nel caso di giudici che, al momento di lasciare la Corte, sono lontani dall’età della pensione.
Ma procediamo con ordine.
Per quanto riguarda la nomina iniziale, va detto che le scarne norme previste dalla Convenzione, che si limitano a dire che ogni Stato parte presenta una terna di candidati (che debbono certo possedere i requisiti professionali e morali richiesti dalla Convenzione), tra i quali l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa elegge il giudice, oggi sono accompagnate da una ricca prassi, che limita la discrezionalità degli Stati proprio in vista di assicurare al massimo l’indipendenza dei membri della Corte.
L’Assemblea Parlamentare, che ha rivendicato a sé il potere di respingere una lista di candidati presentata da uno Stato e quindi, di fatto, ritardare o addirittura impedire l’elezione di un giudice, ha imposto agli Stati di pervenire alla scelta delle tre personalità attraverso una procedura trasparente, con un concorso pubblico che permetta l’audizione dei candidati (almeno di quelli più meritevoli) da parte di una commissione indipendente. L’Assemblea richiede anche che ad essa sia offerta una vera scelta, cioè che tutti e tre i candidati proposti posseggano i requisiti richiesti per l’elezione. Si richiede anche che la lista comprenda almeno un esponente del sesso meno rappresentato alla Corte (attualmente quello femminile). I candidati vengono poi esaminati da una speciale Commissione dell’Assemblea, formata da parlamentari con formazione giuridica, che formula, in vista del voto finale da parte del Plenum dell’Assemblea, le proprie preferenze.
A ciò si aggiunge un vaglio delle candidature, successivamente alla elaborazione della lista dei candidati da parte dello Stato interessato e prima della sua presentazione all’Assemblea, da parte di un Panel indipendente di eminenti giuristi. Le raccomandazioni del Panel non sono vincolanti, ma hanno evidentemente un peso, anche perché il Presidente di questo gruppo si riunisce con la Commissione competente dell’Assemblea prima che questa proceda all’audizione dei candidati.
Relativamente alla durata del mandato, il regime attuale è quello di un mandato novennale non rinnovabile. In precedenza (fino all’entrata in vigore del Protocollo n. 14 ala Convenzione nel 2010) il mandato era di sei anni rinnovabili. La scelta del Protocollo di rendere il mandato non rinnovabile fu dettata proprio dalla preoccupazione di proteggere l’indipendenza dei giudici, per evitare che, approssimandosi la fine del loro mandato, essi cercassero il favore dei loro governi, dai quali, in definitiva, dipendeva il loro eventuale rinnovo.
Certamente la soluzione data dal Protocollo non ha risolto tutti i problemi. In diversi documenti sia l’Assemblea Parlamentare sia il Comitato dei Ministri hanno sottolineato l’importanza di ciò che accade ai giudici dopo la fine del loro mandato.
Il rischio per l’indipendenza dei giudici portato da comportamenti degli Stati che li penalizzino al momento del loro rientro in patria dopo nove anni alla Corte è evidente, ma qui, come dicevo, è questione del livello di correttezza e buona fede con il quale gli Stati applicano la Convenzione e, bisogna dire, del livello di maturità dei loro sistemi democratici. Purtroppo, non si può dire che i comportamenti degli Stati a questo proposito siano stati cristallini in tutte le circostanze.
Si può dire però, anche per rassicurare gli utenti della giustizia europea, che la Corte possiede potenti anticorpi per far fronte a possibili deficit d’indipendenza. Un giudice che prendesse posizioni identificabili come protettrici dell’interesse politico del proprio Paese, o anche di un altro Paese, finirebbe ben presto per perdere ogni credibilità, e quindi ogni influenza all’interno della Corte.
Certamente la Corte è molto attenta al tema della protezione dei propri giudici da pressioni esterne, e non manca di sollecitare gli organi politici del Consiglio d’Europa, il Comitato dei Ministri e l’Assemblea Parlamentare, perché si facciano carico di misure adeguate.
Quanto all’apparenza, la Corte è estremamente severa a questo riguardo. Le regole interne sull’astensione e la ricusazione si basano sulla decisione da parte della formazione di giudizio, escluso il giudice interessato, in caso di disaccordo tra lo stesso giudice e il presidente della formazione di giudizio. La prassi è orientata nel senso che, in caso di dubbio, si debba privilegiare l’esclusione del giudice interessato dalla procedura, anche se si tratti, appunto, di una mera questione di apparenza.
In definitiva, quindi, le norme e la prassi assicurano un livello di indipendenza soddisfacente. Vero è però che comportamenti impropri degli Stati, come la penalizzazione dei giudici alla fine del loro mandato, possono creare qualche preoccupazione, sapendo però che la Corte è in grado di reagire efficacemente nel caso dovesse palesarsi un deficit di indipendenza per questo o quel giudice.
Vladimiro Zagrebelsky
Direi innanzitutto che l’autonomia e indipendenza della magistratura (art. 104 Cost.) e la soggezione soltanto alla legge dei giudici (art. 101 Cost.) sono cose diverse. La legge cui i giudici sono soggetti è ora altra cosa rispetto alla nozione che se ne aveva, non solo da parte dei filosofi illuministi, ma anche per tutto il periodo successivo fino ai lavori della Assemblea costituente compresi, che produssero la formula dell’art. 101. Tuttavia resta importante il senso di quella formula per l’indicazione derivante dall’uso del termine “soggezione”. Certo la legge è ora qualcosa di complesso, perché il testo di una legge ordinaria vive in un ambito di altre norme anche gerarchicamente superiori. L’esito della interpretazione conforme è spesso lontano da quello “fatto palese dal senso delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore”. Tuttavia non è dubbio che i vincoli cui il giudice italiano è soggetto sono più stretti di quelli che riguardano il giudice della Corte europea, che applica (e innova) il contenuto delle norme della Convenzione, redatte in stile costituzionale e soprattutto integrate e sviluppate dalla ormai imponente giurisprudenza della Corte. Ciò dico per segnalare che il vincolo al testo letterale della Convenzione è per il giudice europeo tenue. I criteri interpretativi della Convenzione, indicati dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, lasciano molta autonomia al giudice. Per il modo di lavorare della Corte, vincoli derivano invece dalla regola -normalmente osservata- di rispetto dei precedenti pertinenti.
Ciò detto, rimane anche per il giudice europeo il principio secondo il quale l’indipendenza -dato connaturato all’idea stessa di giudice- implica che il giudice deve operare “senza timori e senza speranze”. In funzione di questo carattere del suo status, la posizione del giudice europeo è assimilabile a quella del giudice nazionale. In proposito rilevano sia le procedure che portano alla sua elezione da parte della Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, sia le prospettive che il singolo giudice ha (o opera per avere!) al suo rientro al termine del suo mandato novennale (non più rinnovabile, dopo l’entrata in vigore del Protocollo n.14).
Sul primo punto ho l’impressione che il controllo operato dal sistema del Consiglio d’Europa sull’idoneità dei candidati inseriti nella terna comunicata dai governi sia piuttosto efficiente. Ma si tratta di controllo sulla qualificazione dei candidati, che non investe anche il diverso profilo che riguarda la possibile esclusione di candidati maggiormente qualificati, ma, per una ragione o l’altra, non graditi al governo proponente. Quest’ultimo punto dovrebbe essere curato e garantito dai comitati (“autorevoli e indipendenti”) che devono assistere i governi nella formazione della terna. Ma in realtà nulla indica che ciò avvenga e che in quella sede non si operi una “selezione negativa”, per ragioni diverse dalla qualificazione e idoneità della persona esclusa. Quei comitati finiscono comunque per sollevare il governo dalla responsabilità della scelta comunicata al Consiglio d’Europa.
Sul secondo punto, quello delle speranze e dei timori nei confronti delle autorità del proprio Paese, nel quale si rientra al termine del mandato, è difficilissimo farsi una idea della posizione reale dei singoli giudici in rapporto alle autorità degli Stati di provenienza o ad enti internazionali vari. Si può pensare che la giovane età dei giudici eletti -molto frequente ora- può creare situazioni imbarazzanti. Essi infatti legittimamente possono ancora aspirare a posti, cariche, ecc. e dunque “avere speranze”.
Quali sono, a Suo giudizio, le sfide che attendono la Corte Edu nel prossimo futuro, con particolare riferimento alla gestione dei ricorsi diretti, ai tempi di definizione dei relativi procedimenti e al ruolo del margine di apprezzamento? E quali quelle che si porranno al giudice nazionale rispetto al suo ruolo di giudice comune della Convenzione dopo l'entrata in vigore del Protocollo n.16 annesso alla CEDU, ma non ancora reso esecutivo in Italia?
Guido Raimondi
Non vorrei entrare nell’arena politica, ma è un fatto che l’evoluzione degli eventi in Europa ha condotto negli ultimi anni a una situazione nella quale si può constatare una pressione sul principio democratico della preminenza del diritto, mentre sono sempre meno rare manifestazioni di insofferenza verso organi di garanzia, sia interni sia internazionali come la Corte europea dei diritti dell’uomo.
La mia generazione ha a lungo pensato che una volta instaurata la democrazia non sarebbe stato possibile tornare indietro. Noi avevamo la certezza che democrazia era lì per l’eternità. Era un’illusione? Spero veramente di no, ma oggi siamo confrontati a un fenomeno di disincanto sociale potenzialmente capace di rendere fragile la democrazia.
Per le giovani generazioni, l’adesione immediata all’idea dei diritti umani non è più cosa evidente. Le ragioni sono molteplici e varie: la stagnazione del livello di vita; i timori suscitati dai fenomeni migratori, con la connessa tentazione di ripiegarsi su sé stessi rifiutando il confronto con l’altro; lo sviluppo anarchico dei cosiddetti “social” e la disseminazione massiccia di “fake news”. La disaffezione dei cittadini nei confronti del modello democratico è tale che la diffusione dei discorsi estremisti e, qualche volta, l’arrivo al potere di leader capaci di attaccare le stesse fondamenta della democrazia pluralistica sono divenuti più facili. Ma i diritti umani non possono vivere e prosperare, come il Preambolo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo dice chiaramente, senza una democrazia effettiva.
Un segnale preoccupante, sul quale mi sono soffermato in occasione del mio discorso inaugurale dell’anno giudiziario della Corte, nel gennaio di quest’anno, è quello del moltiplicarsi delle violazioni dell’art. 18 della Convenzione. Questo articolo dispone che le restrizioni che possono essere apportate ai diritti e libertà garantiti dalla Convenzione devono obbedire allo scopo per il quale esse sono permesse, e non ad altri fini. Questa disposizione, essenziale in una democrazia pluralista, risulta essere stata violata, da quando esiste la Convenzione, dodici volte. Ebbene, cinque di queste occasioni si sono verificate nel solo anno 2018. Il sintomo è inquietante e rivelatore. Senza accusare questo o quel Paese, si può constatare che lo scopo perseguito è spesso quello di ridurre al silenzio un oppositore politico o di soffocare il pluralismo politico, che è una componente essenziale di quel “regime politico sinceramente democratico” di cui parla, come dicevo, il Preambolo della Convenzione.
Si può dunque prevedere che la navigazione non sarà tranquilla negli anni a venire. La Corte dovrà contare sulla sua integrità, sulla qualità delle sue decisioni e sul sostegno dei giudici nazionali, evitando ogni sconfinamento nel campo della politica.
Certamente permarranno nei prossimi anni i problemi di arretrato con i quali la Corte è confrontata ormai da molto tempo. Gli investimenti effettuati nel campo delle nuove tecnologie stanno dando i loro frutti, ed è possibile che miglioramenti ulteriori siano visibili nel prossimo futuro, anche grazie all’intelligenza artificiale. Tuttavia, l’unica via seria per restituire efficienza alla Corte è il miglioramento dei sistemi nazionali di tutela. Quindi, una volta di più, sono i giudici interni i veri protagonisti del sistema.
Porrei quindi ancora una volta l’accento sui giudici nazionali, la cui azione sarà fondamentale per il futuro del sistema europeo di tutela dei diritti umani. Il mio auspicio è dunque quello che l’opera di intensificazione del dialogo tra i giudici di Strasburgo, con la Rete ed altri mezzi, compreso Il Protocollo n. 16 alla Convenzione, continui e si sviluppi sempre di più, in vista del definitivo consolidamento di quella fiducia tra i due livelli che è condizione del permanere del successo di un progetto, quello pensato da grandi europei visionari con la Convenzione firmata a Roma il 4 novembre 1950, che ha garantito un baluardo a difesa della democrazia e della preminenza del diritto, migliorando quotidianamente la vita di tutti noi.
Il Protocollo n. 16, che consente alle Corti supreme e costituzionali nazionali di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’ambito di una concreta procedura giurisdizionale, per ottenerne un parere non vincolante sull’interpretazione della Convenzione, è ormai entrato in vigore, ed è stato attivato già da due Corti superiori europee, la Corte di cassazione francese e la Corte costituzionale armena.
La prima risposta della Corte di Strasburgo, fornita alla Corte di cassazione francese in un delicato caso di maternità surrogata, è stata favorevolmente recepita, ed ha costituto una manifestazione di efficienza, perché la Corte è riuscita a finalizzare il suo parere in pochi mesi. Molto del successo futuro del nuovo meccanismo dipenderà dalla capacità della Corte di mantenere questo livello di efficienza.
Sappiamo che l’Italia non ha ratificato per il momento questo strumento, né la ratifica sembra imminente. Credo che, sull’esempio di quanto è stato fatto negli altri Paesi europei, sarebbe opportuno consultare le Corti interessate, che da noi sono le stesse che hanno firmato Protocolli d’intesa con la Corte di Strasburgo.
In linea generale vorrei dire che il Protocollo è da accogliere con favore, in quanto potente strumento di cooperazione tra i giudici supremi e costituzionali nazionali, anche per il suo valore simbolico.
Detto questo, credo che il giudice nazionale dovrebbe essere prudente nell’utilizzare questo strumento, sia per la sua incidenza sui tempi della procedura interna sia per il suo impatto sulla capacità di lavoro della Corte europea dei diritti dell’uomo, ma al tempo stesso non dovrebbe esitare a farne uso in presenza di una questione non ancora risolta dalla giurisprudenza di Strasburgo.
L’attenzione del giudice interno, non solo evidentemente quella delle Corti superiori, dovrebbe restare concentrata sulla buona applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, nell’ambito fissato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, nella costante ricerca di soluzioni armoniche che tengano conto dei valori convenzionali e dei valori costituzionali, tra i quali, a mio sommesso giudizio, non potrà mai esservi vera contraddizione. Nemmeno può esservi contraddizione tra la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il cui art. 52 § 3 garantisce l’applicazione della Convenzione nel sistema dell’Unione europea come “contenuto minimo” dei diritti corrispondenti della stessa Carta.
Vladimiro Zagrebelsky
a)Io credo che il problema drammatico che deve affrontare la Corte, centrale nel sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali, sia quello del sovraccarico di ricorsi, che non riesce a definire in tempi utili rispetto sia all’interesse del ricorrente, sia allo scopo generale, relativo a tutti i sistemi nazionali, che hanno le sentenze (delle Camere, per non parlare della Grande Camera). Perché la difesa del diritto individuale sia efficace e non si riduca al riconoscimento, quando verrà la sentenza, di un indennizzo monetario, occorre che la decisione della Corte sia tempestiva. Essa già giunge dopo la lunga trafila dell’esaurimento delle vie interne. Ma a quel periodo di tempo si aggiunge quello incredibilmente lungo dell’attesa della sentenza della Corte. Il tempo di attesa non è solo lunghissimo (specie se si pensa che in gioco sono diritti fondamentali). Esso è anche imprevedibile e casuale. Negli ultimi quindici giorni, tra ottobre e novembre 2019, la Corte ha comunicato sentenze di Camera, contro la Slovacchia (ricorso del 2014), Belgio (ricorso del 2011), Russia (ricorso del 2009), Bulgaria (ricorso del 2009), Georgia (ricorso del 2010), Azerbajgian (ricorso del 2016), Ungheria (ricorso del 2015), Svizzera (2 ricorsi del 2016 e 2017), Grecia (ricorso del 2018), Croazia (ricorso del 2016), Moldova (ricorso del 2017), Turchia (ricorso del 2010). Come si vede, tempi non solo lunghi, ma anche molto diversi per ciascuna sentenza, senza che natura e importanza del caso offra una spiegazione. La spiegazione è piuttosto da ricercare nell’organizzazione della Corte, con le sue Divisioni di cancelleria separate per paese e lingua, con il diverso carico di lavoro e disponibilità di personale, ecc. Non si tratta quindi di poca produttività, ma di problemi strutturali della Corte, anche legati alla quarantina di diverse lingue in cui giungono i ricorsi e soprattutto alle decine di migliaia di ricorsi presentati annualmente. Nel corso del mio mandato, con difficoltà e resistenze da parte degli uffici amministrativi e dei giudici, è stato finalmente ammesso il sistema delle priorità nella trattazione dei casi. Ma se la Corte chiudesse ora l’accesso di nuovi ricorsi e decidesse di trattare solo i casi prioritari, sarebbe impegnata per anni! Vi è dunque una crisi della Corte, grave e non reversibile con gli espedienti di cancelleria recentemente introdotti. La crisi riguarda la capacità della Corte di incidere realmente, in particolare assicurando quello che si continua a dire essere pilastro del sistema: il ricorso individuale e il diritto dell’individuo di ottenere tutela. La Corte si dice «vittima del suo successo»; tendendo a segnalare però solo gli –indiscutibili- profili di successo.
Eliminato ogni filtro ai ricorsi in entrata si è garantito accesso al giudice europeo ad ogni persona che ritenga di essere vittima di una violazione. Si tratta di sistema di grande valore e che deve essere preservato. Ma il suo valore positivo non è legato necessariamente al fatto che il ricorrente abbia diritto anche a una decisione della Corte. Oggi quel diritto non è garantito poiché i tempi lunghissimi rendono spesso inutile la sentenza che infine arriva. Ma non vi è la trasparenza di dire che non a tutte le richieste può esser data risposta.
Vi è un numero altissimo di ricorsi ripetitivi che non dovrebbero venire alla Corte, che già si è pronunciata. Gli Stati dovrebbero prendere atto delle sentenze e rimuovere a livello interno le ragioni delle violazioni che continuano a verificarsi. Nei confronti degli Stati che in tal modo non danno esecuzione alle sentenze della Corte dovrebbe agire il Comitato dei Ministri, nel quadro del suo ruolo secondo lo Statuto del Consiglio d’Europa. Ma il Comitato non ha né l’autorevolezza, né i mezzi utili a tal fine.
La Corte, per parte sua ha introdotto da tempo la “procedura pilota”, con le diverse varianti che conosciamo. Erroneamente si usa il termine “sentenza pilota”: pilota è la procedura che implica la sospensione della trattazione dei ricorsi simili. La sentenza non ha valenza diversa da quelle comuni. La procedura pilota mi pare che abbia poca efficacia, a parte forse i casi in cui allo Stato si richieda di introdurre meccanismi di riparazione interna alle violazioni ripetitive. Comunque si tratta di strumento che espone la Corte al limite delle competenze del Comitato dei Ministri e non risolve il problema.
b) Quanto al largo uso che la Corte fa del riconoscimento del margine di apprezzamento statale, rivendicato dai governi (e enfatizzato dal Protocollo n. 15), osservo che esso rimette il riconoscimento e la protezione dei diritti fondamentali al buon volere dei governi e delle maggioranze politiche che li sostengono nei parlamenti nazionali. La Corte sembra supporre una unità sostanziale delle società e della loro espressione politica. Sappiamo invece che così non è, particolarmente nelle questioni delicate in cui la Corte è indotta a riconoscere il margine di apprezzamento nazionale (che sarebbe meglio chiamare “governativo”). Il risultato è che alla fine si riconosce l’autonomia della maggioranza, mentre la natura dei diritti fondamentali e il ruolo della Corte dovrebbero assicurare la protezione delle minoranze, i cui membri sono quelli da proteggere in sede europea.
È poi mia impressione che vi sia una certa contraddizione nella posizione della Corte, particolarmente evidente là dove essa afferma che il margine di apprezzamento nazionale deve essere più limitato qualora in gioco vi sia l’identità dell’individuo (il ricorrente), ad esempio in ordine alla libertà religiosa, e tuttavia afferma che il margine di apprezzamento sarà invece più ampio ogniqualvolta si tratti di casi aventi a che fare con la dimensione morale o etica. Ma allora il margine sarò ampio o stretto?
La questione del ruolo della maggioranza apre anche un diverso ordine di problemi, che si lega a quello del significato e dell’accertamento del c.d. consenso europeo e la rivendicazione di sempre più ampio margine di apprezzamento nazionale da parte dei governi, con la disponibilità della Corte a riconoscerlo. Si tratta di rivendicazione che non riflette soltanto la attuale crescita del nazionalismo e la crisi europea, ma che è anche frutto di un fenomeno legato alla giurisprudenza della Corte. L’orientamento evolutivo della giurisprudenza della Corte la conduce, non solo ad aggiornare il contenuto della protezione, ma anche ad ampliarlo. Esso ha avuto, come contrappeso (e come via di composizione di contrastanti orientamenti esistenti tra i giudici della Corte), un ampiamento della portata del margine di apprezzamento nazionale, che lascia campo libero a notevoli differenze di tutela dei diritti convenzionali. La domanda che occorre ora porsi è se, nell’interesse della costruzione di un’area tendenzialmente omogenea nel livello di tutela dei diritti, il ruolo della Corte debba essere riportato all’affermazione rigida del livello minimo comune di tutela, invece che a quello diverso e forse opposto di stimolo a più elevati livelli di tutela, accompagnato però dall’ammissione di ampia differenza pratica nei diversi sistemi nazionali. L’origine storica della Convenzione con il suo Preambolo, l’ancora irrealizzato progetto di unificazione europea e le attuali contingenze politiche mi paiono spingere nella prima direzione.
c) Sarò breve per quel che riguarda il nuovo strumento del parere della Corte introdotto dal Protocollo n. 16. Si tratta di parere non obbligatorio, né vincolante. Esso potrà essere reso accompagnato da opinioni dissidenti dei giudici rimasti in minoranza. Spero di sbagliare, naturalmente, ma non credo che esso contribuirà significativamente a prevenire violazioni della Convenzione in sede nazionale. Soprattutto se si considera che i pareri della Corte si fonderanno certo sulla propria giurisprudenza, che è già conoscibile e vincolante. Così mi pare sia avvenuto con il primo parere dato alla Corte di Cassazione francese. L’Arrêt n. 648, 4 ottobre 2019, successivo al parere della Corte europea, avrebbe ben potuto essere dello stesso tenore con la semplice considerazione della pertinente giurisprudenza della Corte (tra l’altro relativa allo stesso caso su cui ha finito per pronunciarsi la Corte di Cassazione). E rimarrà un rapporto non chiaro tra la giurisprudenza derivante dalle sentenze della Corte e i pareri che essa potrà esprimere, oltre che, come nel caso della Cassazione francese, tra i pareri successivamente espressi, le sentenze della Corte e la loro esecuzione.
Naturalmente l’efficacia del nuovo strumento si dimostrerà o negherà con il tempo, cosicché la mia attuale impressione potrà dimostrarsi infondata.
4. La conclusioni
Roberto Giovanni Conti
Le risposte fornite da Raimondi e Zagrebelsky suscitano un coacervo di sensazioni, più che prestarsi a delle vere e proprie conclusioni, dovendo l’esperienza da entrambi maturata nella Corte europea dei diritti dell’uomo essere contestualizzata per essere adeguatamente compresa.
Il mandato più risalente nel tempo (2001-2010) di Zagrebelsky, maturato durante il novennio in cui i giudici nazionali (soprattutto quelli italiani) hanno “scoperto” che la CEDU facesse parte del sistema di protezione dei diritti fondamentali ed avesse una sua dignità autonoma rispetto alla Costituzione, al punto di garantire livelli di protezione alla stessa superiori. Scoperta originata traumaticamente tanto dal contenzioso in materia di irragionevole durata del processo – padre naturale della c.d. Legge Pinto e del coacervo di questioni successivamente poste – che da quello in materia di espropriazione. Da qui i primi tentativi volti a riconoscere – da parte del giudice comune – un’efficacia particolarmente penetrante della CEDU nel sistema interno – fino a riconoscere la diretta disapplicazione del diritto interno con essa contrastante –. Ciò accade fino alle ben note sentenze gemelle della Corte costituzionale nn.348 e 349 del 2007 che, per la prima volta, hanno messo ordine sul ruolo della CEDU e del suo giudice, cominciando a delineare un sistema nel quale la partita sulla CEDU si è cominciata a giocare a tre giudice comune, Corte costituzionale, Corte edu –.
L’esperienza, assai più recente (2010-2019) e ancora viva nella riflessione di Raimondi, ha per converso avuto il suo svolgimento in un periodo durante il quale i giudici nazionali hanno iniziato a misurarsi concretamente con la giurisprudenza di quella Corte cominciando a maneggiarla ed ad interpretare il diritto interno in modo convenzionalmente orientato. In altri casi quegli stessi giudici hanno disubbidito alla CEDU, a volte inconsapevolmente, altre convintamente.
Un’epoca, quest’ultima, ancora in progress, in cui non sono mancate – e non mancano – le interlocuzioni del giudice comune con la Corte costituzionale per verificare la solidità del parametro convenzionale e la sua idoneità a costituire la base per fondare il giudizio di incostituzionalità di una norma interna con esso contrastante, ma sempre con la mediazione del parametro costituzionale (art.117 1^ c. Cost.) proprio in relazione alla summa dei principi fissati dalle ricordate sentenze gemelle e dalle successive pronunzie della Corte costituzionale, fra le quali spicca la n.49/2015, croce e delizia quando si discute del concetto di consolidamento della giurisprudenza della Corte edu.
Se è questo il “contesto” delle due esperienze, è forse più agevole comprendere la diversità di rime fra alcune delle risposte. Quella più risalente di Zagrebelsky inevitabilmente meno condizionata dai più recenti indirizzi su importanti questioni, ordinamentali e di merito, espressi dalla Corte e per questo a tratti più improntate a fare emergere talune criticità, ancorché in modo costruttivo – in previsione, appunto, di una loro possibile attenuazione ed eliminazione -. L’altra, più recente, di Raimondi, più conciliante e “positiva”, fortemente ispirata dagli indiscutibili “successi” che la Corte edu ha conseguito negli ultimi anni in termini di effettività delle sue decisioni, di radicamento nei Paesi membri del Consiglio d’Europa e di acquisita credibilità all’interno delle giurisdizioni nazionali, anche di quelle tradizionalmente meno inclini a misurarsi con quel sistema di protezione dei diritti umani.
Seguendo questa prospettiva Raimondi non ha mancato di indicare nella cooperazione tra i giudici – europei e nazionali – “l’assoluta priorità” del suo mandato, prima e dopo la nomina a Presidente della Corte, culminata nella conclusione di protocolli d’intesa con le Corti superiori italiane e fra queste, in particolare, con la Corte di Cassazione che ha fatto da apripista alle successive intese, capaci di alimentare e dare linfa vitale alla Rete delle Corti superiori europee gestita dalla Corte edu – v., diffusamente, A. Di Stasi, Corte di Cassazione e Corti europee; in A. Didone e F. De Santis (a cura di), I processi civili in Cassazione, Milano, 2018, pp. 356 ss.–.
I frutti di questo dialogo sono tangibili.
Certo, c’è ancora chi non nasconde un senso di fastidio verso la Corte di Strasburgo, non perdendo l’occasione per evidenziare gli errori nei quali è incorsa, le inesattezze, le differenze con la giustizia interna, “giusta” per antonomasia.
Ma vi è anche chi non smette di pensare che le due giurisdizioni debbano camminare insieme, stare insieme, ragionare insieme, magari litigare insieme. Quest’ultimo clima è sicuramente il frutto del dialogo intrapreso dalla Corte edu e implementato anche dalla Corte di Cassazione.
Ma alla base dei rapporti fra le giurisdizioni nazionali e quella della Corte edu vi sono il modo con il quale la Corte edu esprime le proprie decisioni e il modo con il quale i giudici nazionali maneggiano quelle pronunzie.
L’analisi di Zagrebelsky è stata sul punto particolarmente attenta evidenziando, per un verso, la necessità di una maggiore accortezza della Corte edu nel valutare gli effetti delle proprie decisioni da parte delle autorità nazionali e dei giudici e, per altro verso, sottolineando l’esistenza di pericolose oscillazioni nella giurisprudenza della Corte edu, non sempre orientate nel senso della progressiva estensione dei diritti ed anzi capaci di determinare quel disorientamento sul valore della giurisprudenza del giudice di Strasburgo in cui si colloca e giustifica la questione del “consolidamento”.
In questa prospettiva non sono mancati da Zagrebelsky alcuni rilievi in ordine alla politica espansiva dei diritti che la Corte edu ha affiancato ad un crescente ricorso al margine di apprezzamento in favore dei singoli Stati. Politica giudiziaria che finirebbe con l’incentivare notevoli diversità di livelli di protezione di un medesimo diritto fra i diversi Paesi contraenti. Né sono commendevoli i tempi dei giudizi e la diversità di durata degli stessi– difficilmente comprensibile secondo Zagrebelsky–, al punto da ipotizzare una sorta di imprevedibilità nella durata di definizione di procedimenti che, involgendo la prospettata violazione di diritti fondamentali, dovrebbero invece avere una tempistica prevedibile e temporalmente coerente rispetto ai beni in gioco.
Una serie di contraddizioni che reclamano per il futuro scelte operative di non facile individuazione, sembra dire Zagrebelsky, soprattutto quando constata che la Corte edu non ha la capacità di fare fronte all’enorme numero di ricorso che è chiamata ad esaminare, in assenza di un efficace meccanismo di filtri.
Uno spaccato – almeno con riguardo al problema dei tempi della giustizia – certo non particolarmente rassicurante.
Tali criticità strutturali, peraltro, non sembrano mettere comunque in discussione il ruolo centrale della Corte edu e l’efficacia della sua giurisprudenza, alla quale si affianca quella della Corte di Cassazione che, pur con risorse non parametrate ai carichi di lavoro e nell’assenza di filtri, fronteggia anch’essa le sopravvenienze cercando di offrire una risposta di giustizia coerente rispetto alla sua funzione nomofilattica ma al tempo stesso propulsiva rispetto alla tutela dei diritti anche di matrice convenzionale.
Sono costi, questi ultimi, non imputabili né alla Corte edu né al giudice di legittimità, sui quali tuttavia la discussione è sempre feconda, purché vi siano interlocutori capaci di comprenderne il senso e non di distorcerne il significato. Per questo è indispensabile difendere la Corte edu dagli attacchi – immeritati – che essa ha anche di recente subito, come ha ricordato Raimondi ( sia consentito, sul punto, rinviare a quanto esposto sulle pagine di Questione giustizia in R. Conti, La Corte Edu attaccata, ieri e oggi. Di chi è la colpa?).
Una riflessione particolare meritano le risposte relative al tema dell’indipendenza della giurisdizione interna e della Corte edu. Sul punto, i due intervistati hanno confermato la centralità dei detti canoni, sintetizzando nelle risposte argomenti affrontati in maniera sistematica in recenti scritti – G. Raimondi, L’indipendenza delle corti nel diritto costituzionale, comparato ed europeo: la prospettiva della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Corti europee e democrazia, Rule of law, indipendenza e accountability, a cura di G. Pitruzzella- O. Pollicino e M. Bassini, Milano, 2019, 77; V. Zagrebelsky, Nozione e portata dell’indipendenza dell’Ordine giudiziario e dei giudici Ruolo del Consiglio superiore della magistratura, in OsservatorioAIC.it, 3 dicembre 2019 –.
Entrambi sono convinti che sia l’indipendenza delle Corti a costituire la pre-condizione per l’affermazione effettiva dei diritti fondamentali, qualunque ne sia la matrice, costituzionale, eurounitaria o convenzionale, poiché tale garanzia fa parte dei principi giuridici generali che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
La circostanza che l’indipendenza sia caratteristica riguardante tanto le giurisdizioni nazionali che quella della Corte edu avvicina, ancora una volta, le due esperienze per certi altri aspetti diverse.
Certo, si potrebbe sostenere che le ricordate oscillazioni giurisprudenziali all’interno della Corte edu non costituiscono un disvalore se riflettono una presa di coscienza nuova della Corte su una determinata questione, magari in relazione agli apporti forniti sulla questione concreta dalle giurisdizioni nazionali.
Insomma, l’ampliamento delle occasioni di confronto, diretto o indiretto e dunque di dialogo della Corte edu con le giurisdizioni nazionali potrebbe essere la base giustificativa di taluni radicali mutamenti giurisprudenziali che esaltano, in ogni caso, il ruolo della Grande camera della Corte edu, come luogo elettivo nel quale fissare i termini della decisione modificativa del pregresso indirizzo, fornendole il crisma della certezza del precedente.
Particolarmente rilevanti le opinioni, sul punto concordi, di Raimondi e Zagrebelsky sulle dinamiche interne alla Corte edu ed ai suoi giudici. Aspetti sui quali difficilmente si riflette e che, invece, rappresentano il vero DNA di quella giurisdizione.
La fiducia che sostiene i singoli giudici, a prescindere dalle appartenenze nazionali perché alimentata da prospettive di fondo e “culture” differenti, aiuta a comprendere la diversità del giudice di Strasburgo da quello interno, ma al contempo lo avvicina alle corti nazionali, nelle quali le maggioranze nei collegi giudicanti si formano, talvolta, su dinamiche sovrapponibili a quelle testé descritte.
L’avere fatto comprendere che il vincolo fra giudice e Stato di appartenenza viene superato dalla comunanza culturale che si va instaurando, volta per volta, fra giudici di diverse nazionalità costituisce la misura di quanto la Corte edu sia luogo giudiziario da rispettare, come qualunque altro giudice.
Ma è proprio l’insistenza, da parte dei due giudici, sulla natura poliedrica e multinazionale della Corte edu a fare riflettere sul modo di esercizio della giurisdizione di un organo di giustizia sui generis, nel quale la fatica della ricomposizione delle differenze fra i livelli di protezione dei diritti dei vari Paesi contraenti che caratterizza il processo decisionale della Corte europea sembra essere la stessa della giurisdizione che si manifesta nelle decisioni del giudice nazionale.
Ma, appunto, il giudice nazionale come si interfaccia, quale ruolo ha in questo processo?
Un ruolo centrale, soprattutto se si guarda agli aspetti meno brillanti della Corte edu di cui si è già detto.
La complessità del sistema di protezione dei diritti fondamentali rappresentato dalla CEDU e dalle modalità con le quali essa opera, anche per il tramite del suo “diritto vivente”, non è stata da nessuno dei due giudici sottaciuta, avuto riguardo all’esistenza di Carte costituzionali risalenti all’interno della gran parte dei Paesi UE. Ed è proprio qui che quella complessità ripiomba sul giudice nazionale.
Il successo della Corte edu reca con sé l’individuazione di punti critici di non marginale rilevanza, alcuni dei quali attinenti al ruolo stesso della legge e del giudice nella protezione dei diritti, al punto da far ipotizzare che il futuro della giurisdizione comune sarà sempre più orientato a sagomare la giustizia del caso concreto sulla base di leggi “aperte” che lasciano un certo margine di libertà al giudice, fissando solo la cornice di riferimento poi concretamente riempita volta per volta (Zagrebelsky).
C’è da avere paura di questa “discrezionalità” del giudice nazionale? Stiamo vivendo un’epoca in cui si stanno torcendo i capisaldi della democrazia, affidandoli alla imponderabile lotteria della giustizia e degli operatori chiamati, volta per volta, ad applicarla ovvero siamo alle porte di una nuova esperienza democratica fondata sui diritti fondamentali scolpiti nelle Carte dei diritti che va contaminando i sistemi nazionali in modo inarrestabile e nella quale l’elemento portante è rappresentato da una condivisione di ruoli, fra legislatori e giudici, entrambi imprescindibili per il raggiungimento della migliore giustizia possibile?
Temi sui quali la magistratura non potrà non interrogarsi proprio in ragione dell’avvertita consapevolezza che, non riuscendo la Corte edu ad operare con celerità per problemi strutturali, il peso maggiore rispetto al controllo di convenzionalità non potrà che ricadere sempre di più sul giudice nazionale. Per questo si torna ad insistere sulla necessità di una nuova stagione, una nuova Gardone che si volga a riflettere in modo più attento sui temi del giudice rispetto all’interpretazione e alle interpretazioni delle fonti interne e sovranazionali, del significato che oggi assume la guarentigia della soggezione del giudice alla legge di cui all’art.101 Cost.,
La strada del dialogo e della cooperazione sembra essere, per Raimondi, la certezza e al contempo la sfida del futuro per le Corti ed in questa prospettiva assume valore centrale il Protocollo n.16 annesso alla CEDU che, come è noto, ha introdotto il meccanismo della richiesta di parere preventivo in favore delle Alte Corti nazionali. Strumento sul quale fin dall’inizio – v. V. Zagrebelsky, Parere consultivo della Corte europea dei diritti dell’uomo: vera e falsa sussidiarietà, in La richiesta di pareri preventivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali, a cura di E. Lamarque, Torino, 2016, 91 – ebbe a nutrire riserve addirittura sul suo varo definitivo da parte dei Paesi membri e più ancora sulla sua concreta utilità e praticabilità.
Il punto è estremamente delicato, essendo in corso i lavori preparatori del disegno di legge, di origine governativa, teso ad introdurre detto Protocollo nel sistema ordinamentale interno. I lavori preparatori innanzi alle commissioni parlamentari – https://www.camera.it/leg18/1104?shadow_organo_parlamentare=2803&id_tipografico=03 – hanno messo a nudo posizioni diverse -v., in particolare, l’intervento del Prof. Luciani – riportato in https://www.sistemapenale.it/it/documenti/massimo-luciani-audizione-su-autorizzazione-alla-ratifica-protocollo-15-e-protocollo-16-cedu - e, fra queste, quella dell’attuale Giudice italiano della Corte edu, Raffaele Sabato, favorevole alla ratifica ed esecuzione di detto Protocollo.
Raimondi ne ha qui puntualmente evidenziato i lati positivi.
Zagrebelsky, confermando quanto già altre volte espresso sul punto, ha insistito sulla scarsa utilità dello strumento, proprio in ragione delle sue caratteristiche – non obbligatorietà, non vincolatività – ma anche sulla non pericolosità dello stesso -v., in particolare, l’audizione del 19 novembre 2019, cit.– risultando comunque nel pieno dominio delle – recte, di tutte le – Corti coinvolte farne un uso accorto.
Qui va solo evidenziato che le preoccupazioni circa un’indebita equiparazione di effetti fra il rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia e quello disciplinato dal Protocollo 16, pur autorevolmente prospettate nel corso delle audizioni non sembrano persuasive.
Risulta, infatti, in modo inequivoco dalle riflessioni dei Saggi – a suo tempo nominati dal Consiglio d’Europa – precedenti al varo del Protocollo che tale equiparazione venne espressamente esclusa proprio attribuendo carattere non obbligatorio alla richiesta di parere del giudice nazionale e natura non vincolante al successivo parere della Corte, alla quale è riconosciuta, peraltro, la possibilità di non dare corso alla richiesta di parere – v. le linee guida approvate dalla Corte edu il 18 settembre 2017, https://www.echr.coe.int/Documents/Guidelines_P16_ENG.pdf e, volendo, R. Conti, La richiesta di parere consultivo alla Corte europea delle Alte Corti introdotto dal Protocollo XI CEDU ed il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Prove tecniche di nomofilachia europea, in La richiesta di pareri preventivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali, cit., 97; id., Il parere preventivo della Corte Edu (post-Prot. 16) in tema di maternità surrogata –. Ciò sembra consentire una lettura del Protocollo inidonea a pregiudicare le regole fissate dalle sentenze c.d. gemelle del 2007, né a marginalizzare il ruolo della Corte costituzionale, che dovrebbe essere anzi essa stessa a pieno titolo parte del medesimo meccanismo.
Ancor meno persuasivi paiono i rilievi adombrati nel corso di alcuni audizioni a proposito della necessità di adottare il Protocollo 16 con legge costituzionale, non deponendo a favore di tale opzione né i contenuti del Trattato, non inclusivi di limitazioni di sovranità in ragione delle caratteristiche strutturali del procedimento e del contenuto del parere, né tanto meno la circostanza che la CEDU fu introdotta in Italia con legge ordinaria, rendendo pertanto incomprensibile l’opzione anzidetta rispetto ad una modifica aggiuntiva che ha sicuramente un’efficacia ridotta rispetto a quella prodotta dalle sentenze della Corte edu.
Non sembra allora potersi dubitare che l’analisi del come si atteggerà lo strumento del parere preventivo non può essere fatta in vitro, ma richiederà l’esame in vivo della giurisprudenza che andrà formandosi nelle Corti nazionali e in quella di Strasburgo. Sarebbe dunque un errore pregiudicare il nostro Paese impedendo di fornire, attraverso i propri organi giurisdizionali, il proprio apporto a questo dialogo che si prospetta già come effettivo per i Paesi che hanno reso esecutivo il protocollo.
La speranza è, dunque, che il dibattito parlamentare possa presto arricchirsi attraverso le voci degli organi giurisdizionali che dovrebbero appunto alimentare la cooperazione virtuosa fra le Corti al quale si dirige il Protocollo n.16, come ha opportunamente sollecitato Raimondi.
Intanto, non resta che ringraziare i nostri due Giudici, nazionali ed europei, per avere scritto nel corso dei loro anni trascorsi alla Corte edu e, qui, a quattro mani, delle pagine destinate a rimanere nel patrimonio di tutti gli operatori di giustizia.