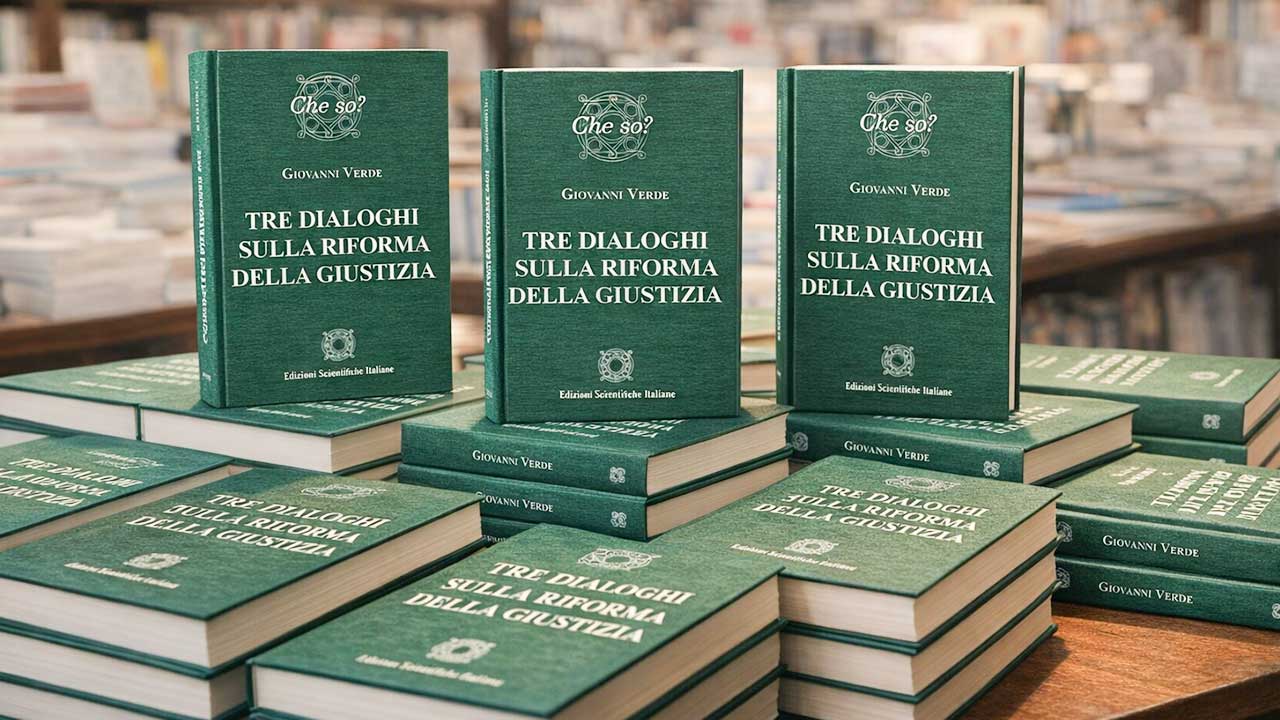
Se il luogo in cui trova ambiente l’opera letteraria è in genere celebrato come motivo ispiratore e chiave esplicativa della stessa (Trieste per Svevo, Dublino per Joyce, Napoli per Marotta, e via discorrendo), osservazione analoga può essere applicata anche ad altro genere di scritti, comunque riconducibili ad espressioni culturali correlate ad alti sentimenti civili. Quest’ultima notazione va agevolmente riferita ai pregevoli Tre dialoghi sulla riforma della giustizia di cui è autore Giovanni Verde: la sua ricca biografia professionale ed i suoi incarichi accademici ed istituzionali è superfluo ricordare, tanto nota è la sua figura (ed in ogni caso sono rintracciabili nel retro della copertina del libro).
Ed infatti, il denso volumetto racconta di immaginari colloqui tra novelli Candide e Pangloss in veste di acuti e critici commentatori della recente legge di revisione costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare sottoposta a duplice referendum confermativo aperto ad un unico quesito doverosamente rielaborato, secondo gli schemi propri del procedimento, dall’ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione.
I tre dialoghi si svolgono nella capitale partenopea in cui l’Autore è nato e vissuto ed hanno luogo in altrettanti posti rappresentativi della filosofia, del carattere, della bellezza, dei costumi quotidiani della città: un caffè celebre, una rinomata pizzeria, la luminosa passeggiata in Via Caracciolo. In ciascuno i dialoganti-sovente incalzati dal “quisque de populo”, un arguto ed invadente, perché avido di sapere, cameriere in servizio nel primo di essi – l’ingenuo ma intellettualmente fervido Candide mostra sommo interesse per le riflessioni che sull’ampio tema effettua un Pangloss giustificatamente meno ottimista del suo predecessore letterario e della relativa fonte filosofica ispiratrice.
Ansia di conoscere e comprendere, per ricavare orientamento verso una scelta congiuntamente ardua e lacerante, grazie ad un interlocutore misurato ed incline a fornire spunti, argomenti, esperienze senza imposizioni o, perfino, suggerimenti, quasi si trattasse di un Virgilio che disambigua la selva, ma anche di un Martin che fa capolino dal Candide ou l’optimisme e parla come contraltare occulto dello stesso Pangloss.
Il primo dialogo ha ad oggetto lo stesso fine della riforma, nei termini in cui esso è propalato: la separazione della carriera giudicante da quella requirente, con sottesa l’indagine sul ruolo del pubblico ministero. Nella sofferta ricerca di un’analisi che consenta all’interlocutore di formarsi un convincimento scevro da pregiudizi, manifesti e latenti, Pangloss pronuncia una frase stentorea che, nella sua apparente, glaciale neutralità, esibisce la profondità delusa del suo pensiero: la riforma non toglie né aggiunge… Sebbene non sia reso esplicito il complemento di termine del virtuale dativo il costrutto della frase potrà da ogni lettore essere congruamente individuato nella giustizia in generale e nel suo particolare sistema di amministrazione. Si intende chiaramente che entrambi resteranno non soltanto invariati ma anche inevitabilmente beffati nella loro esigenza di effettivo potenziamento e miglioramento. Da questa amara constatazione,che di per sé logicamente comporterebbe il radicale rigetto di una riforma lacerante ed al contempo incapace di incidere beneficamente su un tessuto meritevole di essere preservato in ragione delle sue nobili origini, per quanto consunto, Pangloss fa scaturire la più sconfortante delle constatazioni, quella che svela come l’ordine giudiziario sia rimasto, se non inconsapevolmente almeno incolpevolmente, impigliato in una lotta tra poteri dello Stato ingaggiata per combattere non già e non solo quella categoria professionale ma l’assetto stesso dello Stato, in quanto affetto da “ipertrofia penalista, figlia di un perbenismo di facciata”. Quel che riesce, tuttavia, incomprensibile ed intimamente contraddittorio è per Pangloss il fatto che, mentre questa tenzone si proporrebbe lo scopo di riportare la Costituzione – di certo non agevolatrice di un siffatto disegno – al suo alveo originario e, quindi, di realizzarne la piena attuazione, la strada intrapresa sia stata quella della revisione costituzionale. In altri termini, l’improvvido riformatore ha pensato di attuare la Costituzione attraverso la sua revisione. Ed infatti, Pangloss ammonisce Candide, la nostra legge fondamentale pensò al pubblico ministero come un ibrido, affidandogli una funzione necessariamente collaborativa al fianco e non di fronte al giudice. A questo argomento ricostruttivo dell’intenzione del Costituente si affianca un altro, razionalmente idoneo a confutare il motivo dominante addotto a favore della riforma. Pangloss è fermamente persuaso che il nostro sistema processuale penale non sia qualificabile come accusatorio, ossia tendente a conseguire non l’obiettivo della verità quanto quello della regolarità del processo secondo la tradizione del common law anglo-americano in cui si parla di fair trial e di due process of law. Ma la realtà italiana certifica che il processo penale deve aspirare all’accertamento della verità, così smentendo la sua supposta natura modellata sull’esempio d’oltremanica e d’oltreoceano. Solo una genuina indole accusatoria, infatti, potrebbe rendere ineluttabile la separazione delle carriere. E ciò perché il reale presupposto giustificativo della stessa potrebbe essere solo quello del suo innesto in una società liberal-democratica: e qui Pangloss dismette i panni dell’ottimismo Leibniziano per indossare quelli Voltairiani che lo conducono alla sconsolata diagnosi che il nostro modello sociale è solo lontano parente di quello, appunto, liberal-democratico. Il pensiero di Pangloss non riesce a dissimulare quello dell’Autore dei tre dialoghi: questo traspare nell’occasione in cui, pur riconoscendosi che la riforma nasce da uno stagnante malessere, che ha le sue radici anche nell’eccessivo ricorso alla sanzione penale, si esclude che la separazione delle carriere abbia l’attitudine a curarlo proprio in quanto ci si trova di fronte ad uno schema processuale solo nominalmente accusatorio. Emerge, così, il mero carattere ideologico dell’etichetta che al processo penale italiano si pretende di affibbiare allo scopo di legittimare l’inesorabilità della riforma. Molto nette ed elevate sono le parole che il Pangloss-Verde ( non in senso cromatico ) pronuncia a conclusione del primo dialogo suscitando l’insinuante interesse del cameriere che serve la tazza fumante di caffè: “La volontà popolare non deve essere il prodotto di impulsi e suggestioni: occorre un accorto dosaggio delle tecniche normative”.
Queste parole, e l’alto concetto che esprimono, varrebbero, secondo il lessico processual-civilistico di cui Giovanni Verde è impareggiabile Maestro, ad assorbire ogni altra questione che possa in astratto agitarsi attorno alla legge di revisione costituzionale. Ed allora il dialogo tra i due conversatori insaziabili prosegue,senza che a saziarli possa provvedere il fatto che esso si svolga in una pizzeria che sembra garantire la genuinità dei prodotti e, con essa, stimolare un confronto favorito dal luogo presumibilmente affollato e fremente di ordinazioni altisonanti. Destinatario delle stesse è un cameriere che, comunque, non cessa di intromettersi per chiedere ai due prestigiosi avventori quel “consiglio” che, ad altri fini, si pretendeva dal Don Raffaè di De André. Si parla adesso del Consiglio Superiore della Magistratura, del quale il nostro Autore è stato illuminato vice-presidente, e, più in particolare della sua crisi o, forse anche, delle sue cicliche crisi. È molto abile, perché abilmente guidato ed inspirato, Pangloss nell’impedire che il ragionamento pretestuoso si insinui subdolamente nelle pieghe della scelta referendaria finendo con il porgerle la pudica foglia di fico. Ed il pretesto prevedibile è costituito dal cosiddetto caso Palamara che il dialogante deprime opportunamente al rango di “una miserevole vicenda che ha coinvolto poche persone”. E Pangloss, dalle cui labbra Candide non può che pendere, senza, tuttavia, riceverne una indicazione specifica, scova brillantemente l’artificio retorico attraverso cui surrettiziamente si cerca di munire di base logico-giuridica il criterio di preposizione ai due nuovi CSM, ovvero l’estrazione dei magistrati da un lotto (una lotteria, più esattamente) indistinto. Doppio è il severo registro verbale adottato. In primo luogo, Pangloss impartisce al desideroso Candide una salutare lezione di democrazia partecipativa con il ricordargli che la lotta alle correnti maschera la lotta all’ideologia (beninteso alla sua fenomenica e concettuale ineliminabilità, è il caso di aggiungere restando fedeli all’idea del parlante nel dialogo) del singolo magistrato. Ancor più incisivo ed arioso è il secondo passaggio verso l’abbattimento del totem del sorteggio: “Quando si rompe il legame della rappresentanza si fa spazio alle clientele. Il sorteggio è un criterio livellatore. Il merito e la competenza sono un lievito di cui non si può fare a meno”. Ed anche le tendenze popolar-populistiche vengono spazzate via con il loro corteo di mistificanti suggestioni, messe in ginocchio dalla convincente puntualità del riferimento storico: “L’egualitarismo fatalmente scade in qualunquismo”, avvicinandosi a quella forma di governo noto nell’antica esperienza greca con il nome di olocrazia, ossia “governo della plebe” ben lontana dall’ideale democratico cui ieri come oggi le società mature dovrebbero tendere seguendo l’architettura della nostra Costituzione.
L’Autore tace per non incorrere nel vizio di campanilismo gastronomico ma è ragionevole la congettura che la degustazione del patrimonio universale offerto dalla cucina napoletana e servito dall’instancabile cameriere che volentieri si tratterrebbe con i dialoganti, pur richiamato dalla vociante clientela, sarà stato anche più sapida. E cala il sipario sul secondo dialogo.
Il terzo, a differenza dei primi due, si svolge interamente all’esterno, nel celebrato lungomare in una splendida giornata di sole e la vista di Capri che si staglia nitida all’orizzonte. Insomma, la scena più adatta per essere sorretti dall’ottimismo chiacchierando di alta corte disciplinare: ne risentirà la bellezza del contesto? Era facile, ed azzeccata, la previsione dell’autoavveramento della profezia che il tema avrebbe potuto offuscare la magia del luogo e del clima. Ed infatti, si inizia a discutere lievemente ironizzando sull’apposizione alla nuova corte disciplinare dell’aggettivo “alta” evidentemente teso a dimostrarne la levatura. Viene, così, regalata all’implacabile Pangloss l’occasione per supporre che la spendita del qualificativo valga a compensare la debolezza del pensiero che sorregge il nuovo organismo. Debolezza la cui più profonda radice risiede nel sostanziale tradimento dell’originario progetto costituzionale, indiscutibilmente rivolto a preservare, attraverso il conferimento al Consiglio Superiore della Magistratura della potestà disciplinare, l’autonomia dell’ordine giudiziario. Ora, proprio la fuoriuscita dal primitivo circuito consiliare dell’organo disciplinare vale a consolidare il fondato sospetto di esplicita e calcolata frattura dell’ordito costituzionale. Né, si chiede Pangloss, suscitando il candido stupore dell’interlocutore, appare perspicua la ragione della mancata attrazione delle altre giurisdizioni, amministrativa, contabile, militare, nel medesimo meccanismo concepito solo per i magistrati ordinari (giudici e pubblici ministeri un’altra volta riaggregati).
L’immagine in dissolvenza fissa i due dotti dialoganti percorrere Via Caracciolo quando vengono inseguiti dal saggio cameriere che nel suo melodioso,carezzevole dialetto richiama il popolare detto che individua tre sole categorie di potenti: il Papa, il re, il totale impossidente (“Tre songo 'e putiente: 'o papa,'o re, e chi nun tene niente”). L’eco della brevissima, felicissima stagione della Napoli rivoluzionaria del 1799, con l’acre gusto del “resto di niente”, induce Pangloss e Candide a chiedersi se, in un Paese che ha perso l’abitudine di leggere e riflettere, sia meglio “farsi i fatti propri”. L’epilogo è doloroso ma sembra perfettamente coerente con le osservazioni prognostiche dettate dai tre dialoghi.
Questi donano facce diseguali di un prisma che raffigura un Paese attraverso l’introspezione dei suoi meccanismi normativi e dei rispettivi riflessi sia sulle Istituzioni sia sull’intera comunità nazionale ed i suoi singoli componenti, colti nella quotidianità delle abitudini di vita. E l’introspezione reca con sé il quadro della disgregazione di un assetto di lontana risalenza energicamente rimaneggiato in nome di vaghe e seducenti sirene che evocano il fascinoso traguardo di una “giustizia più giusta” senza chiedersi se la revisione proposta “inaudita altera parte” tolga o aggiunga. Ed allora, a questa sovrapposizione, sottratta ad ogni dibattito, di una nuova architettura a quella che aveva sfidato, riuscendone invitta, la sfida del tempo deve civilmente e sapientemente corrispondere una nuova prospettiva di riflessione critica. Questo era il proponimento dei “Tre dialoghi”. Ben può dirsi che esso sia stato onorato in virtù di ragionamenti celebrativi della Costituzione del 1948 in quanto strumento di civile convivenza e non semplice declamazione di principii astratti e privi di anima.
Va, pertanto, reso merito all’Autore di questo importante contributo, concepito in uno dei momenti più delicati ai fini della stabilità dei nostri apparati normativi ed istituzionali di aver dato voce colta e ben meditata, razionalizzando, ad una sensazione di smarrimento che pervade quanti a ragion veduta temono di vedersi travolti dalla valanga riformatrice e con essa la coerenza del sistema giuridico. Va dato credito a Giovanni Verde di aver dedicato la vita alla difesa dei valori e del bene della cosa pubblica, alla diffusione della cultura giuridica a vantaggio della collettività e nel totale disinteresse per la fortuna della propria personale posizione. Un esempio da seguire ed un debito di riconoscenza da tributare per aver schiuso menti e cuori ad una giusta e nobile causa.
