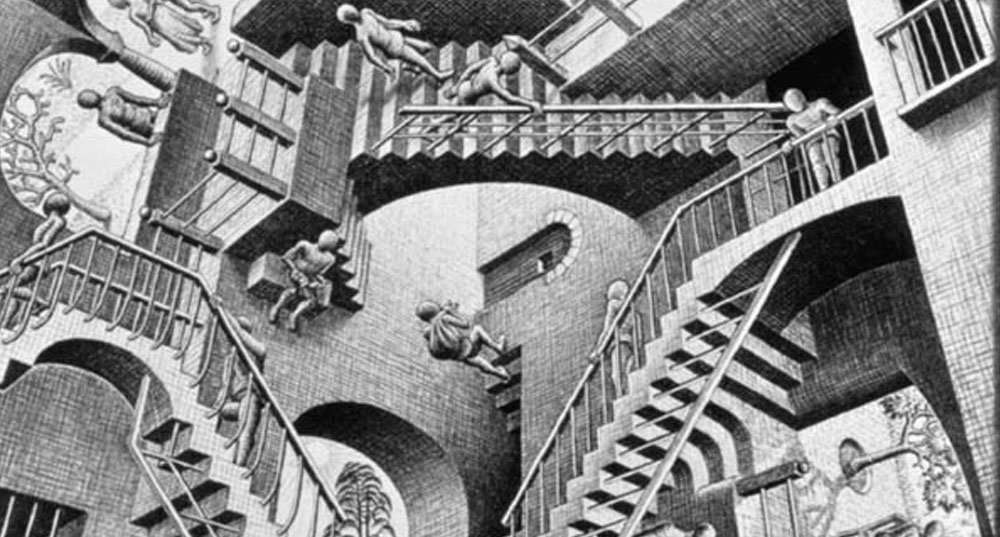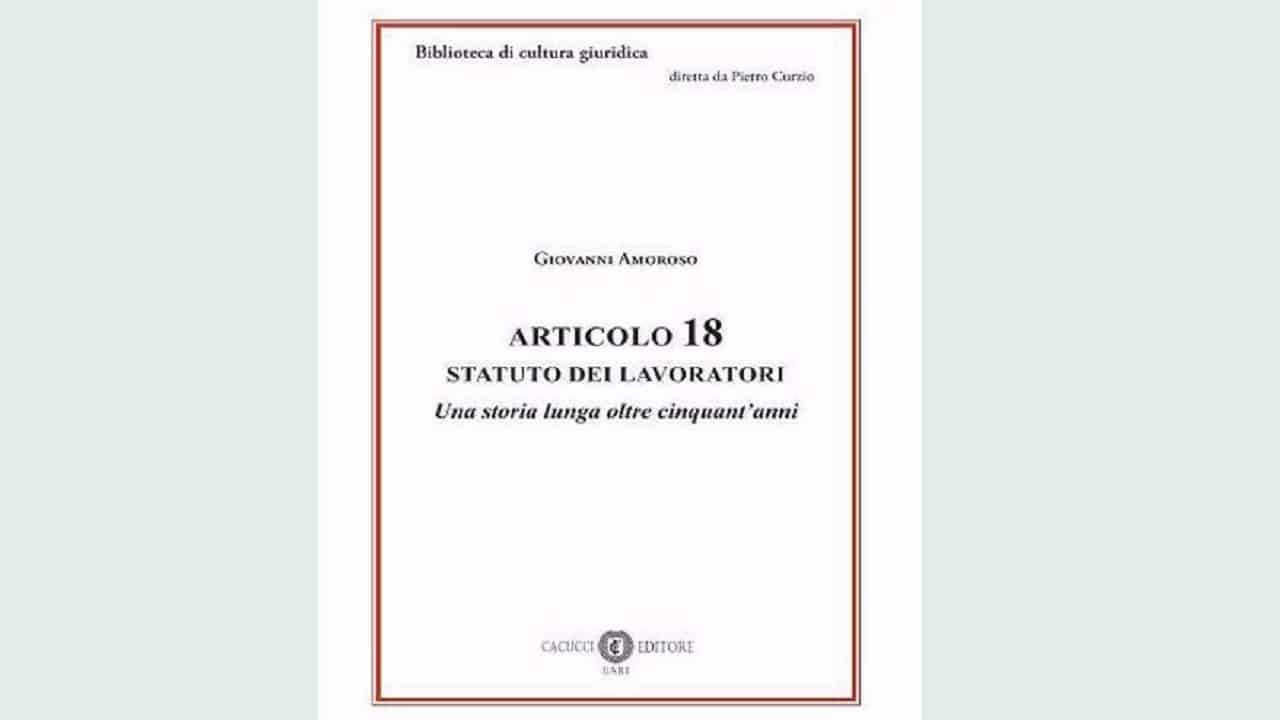Il referendum abrogativo parziale dell’art. 19, commi 1,1-bis, e 4, e dell’art. 21, comma 01, del d.lgs.15 giugno 2015, n. 81 sui contratti a termine
V. A. Poso Su iniziativa della CGIL sono stati promossi quattro referendum abrogativi di importanti norme lavoristiche (dopo la comunicazione in data12 aprile dell’iniziativa referendaria, l’annuncio delle richieste è stato pubblicato nella G.U. n. 87 del 13 aprile 2024; il deposito presso la Cancelleria della Corte di cassazione della documentazione attestante le firme raccolte è stato effettuato il 19 luglio 2024).
Il terzo, sinteticamente denominato dai promotori “Lavoro Stabile” ha ad oggetto il seguente quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?».
Secondo il manifesto pubblicitario di questo referendum, confezionato dalla CGIL, per realizzare il “lavoro stabile”, il quesito è inteso, in estrema sintesi, ad abrogare le norme che hanno liberalizzato l’utilizzo del lavoro a termine e limitare il ricorso a questo tipo di lavoro solo in presenza di causali specifiche obiettive e temporanee – previste e disciplinate dai contratti collettivi – verificabili dal giudice, anche per i contratti di durata non superiore a dodici mesi così da superare la precarietà dei contratti di lavoro, anche in caso di proroga e rinnovo; e ad abrogane la norma che consente alle parti individuali del contratto di lavoro di individuare la causale del termine, «che nei fatti apre la strada ad assunzioni a termine senza alcun controllo», essendo il lavoratore in attesa di essere assunto dell’autonomia necessaria per valutare e decidere. Per i promotori di questo referendum il lavoro «deve essere stabile perché la precarietà è una perdita di libertà».
Chiedo, in particolar modo, ai giuslavoristi di tracciare un quadro sintetico della disciplina del contratto a termine – con riferimento agli aspetti più rilevanti che qui interessano e ai principi informatori delle norme che si sono succedute – per come si è evoluta, a partire dalla l. 18 aprile 1962, n.230.
S. Ciucciovino. La disciplina del contratto a termine è stata attraversata nel corso degli anni da numerose e continue modifiche. Essa ha assunto progressivamente una vera e propria valenza simbolica, anche nell’opinione pubblica, rispetto alla questione della “precarietà lavorativa”. Da questo punto di vista, le diverse riforme del contratto a termine messe in atto dai Governi che si sono succeduti, almeno dagli anni 2000 in poi, sono state connotate da una forte connotazione “politica”.
Non a caso anche la proposta referendaria in commento, nell’intento di contrastare la precarietà lavorativa, prende di mira il contratto a termine. Va detto, però, che il fenomeno della precarietà – specie nelle forme più deprecabili - è addebitabile in larga parte a forme di lavoro ben meno tutelate del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; forme più o meno irregolari, grigie e mascherate, rispetto alle quali non si è notato lo stesso livello di attenzione che è stato riservato al contratto a tempo determinato.
Ciò detto, al netto di interventi correttivi di portata minore, dagli anni ‘60 del secolo scorso ad oggi si contano almeno sei grandi riforme del contratto a termine, rispettivamente apportate con la l. n. 230/1962, con l’art. 23 della l. 56/1987, con il d. lgs. n. 368/2001, con il d. lgs. 81/2015 (c.d. Jobs Act), con il d.l. 87/2018, convertito in l. 96/2018 (c.d. decreto Dignità) e, infine, con le successive correzioni del c.d. decreto sostegni bis (d.l. 73/2021, conv. in l. 106/2021). Ciascuna di queste riforme corrisponde ad una precisa ispirazione di politica del diritto e fissa uno specifico bilanciamento del ruolo del legislatore, dell’autonomia collettiva e dell’autonomia individuale nel governo del lavoro temporaneo.
Tutto inizia con la legge n. 230 del 1962 che poneva un divieto generale di apposizione del termine al contratto di lavoro, salve le eccezioni previste e disciplinate dallo stesso legislatore. Si trattava di ipotesi che legittimavano l’assunzione a termine: per esigenze stagionali; per esigenze sostitutive; per l’esecuzione di un’opera o un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale; per lavorazioni che richiedevano maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative non continuative e, infine, per il personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli. All’epoca, è bene ricordarlo, vigeva un regime di libera recedibilità dai contratti di lavoro a tempo indeterminato, con il solo limite del preavviso ex art. 2118 c.c. e, quindi, la precarietà era una caratteristica comune sia alle assunzioni a termine che a quelle a tempo indeterminato.
La normativa limitativa dell’assunzione a termine del 1962 cominciò a rivelarsi invece particolarmente restrittiva quando, pochi anni dopo, nel 1966 e nel 1970, si posero vincoli stringenti al licenziamento del lavoratore assunto a tempo indeterminato. A quel punto l’interesse per l’assunzione a termine si caricò di nuovi significati, in quanto il termine consentiva all’impresa di chiudere il rapporto di lavoro senza dover passare per le strettoie della giustificazione del licenziamento del lavoratore assunto a tempo indeterminato.
Con le crisi degli anni ’70 le prospettive di mercato in cui operavano le imprese si fecero più incerte e difficili e ciò alimentò la richiesta di contratti temporanei che si scontrava con il rigido impianto regolativo della legge n. 230/1962. Così, a partire dagli anni ’80, prese avvio una fase del diritto del lavoro di cauta attenuazione delle rigidità legali, che venne affidata alla contrattazione collettiva. Si aprì allora la stagione della cosiddetta “flessibilità negoziata”, di cui l’art. 23 della l. n. 56/1987 è emblematica. Questa norma configurò una tappa importante di riforma della disciplina del contratto a termine, in quanto affidò al contratto collettivo nazionale, con una vera e propria “delega in bianco”, il potere di prevedere “ulteriori ipotesi” di legittima apposizione del termine, aggiuntive rispetto a quelle legali già previste dalla legge del 1962. Una valvola di sfogo della domanda di flessibilità che le imprese potevano attingere attraverso le relazioni sindacali. Questa normativa, nell’affidare all’autonomia collettiva la gestione della flessibilità in entrata, accrebbe notevolmente il potere dei sindacati nei tavoli negoziali. Si passò, quindi, da un governo del lavoro temporaneo rimesso esclusivamente alla fonte legale, ad un governo in cui coesistevano la fonte legale e la fonte contrattuale collettiva.
Altre norme negli anni ‘80 e ‘90 replicarono lo stesso modello di flessibilità negoziata con una stretta integrazione tra fonte legale e collettiva. Si possono citare in proposito le norme sul contratto di formazione e lavoro e sul contratto di inserimento (l. n.863/1984 e l. n.451/1994), le norme sul lavoro temporaneo tramite agenzia (l. n.196/1997), le norme sull’apprendistato (l. n.196/1997), le norme sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (l. n.146/1990). Attraverso la delega in bianco dell’art. 23, l. n. 56/1987 e altre disposizioni di quel periodo storico cominciò ad emergere anche il contratto a termine con causale soggettiva, dove il termine costitutiva una sorta di incentivo all’assunzione di categorie svantaggiate: giovani, donne, soggetti a rischio disoccupazione (art. 8, l. n.223/1991). In questo panorama normativo, in cui l’assunzione a termine era veicolata e controllata dall’autonomia collettiva, anche il contenzioso giudiziario si rivelò contenuto, in quanto il contratto collettivo assolveva ad un sufficiente ruolo di garanzia della parte lavoratrice rispetto alla precarietà lavorativa, guardato con rispetto anche dai giudici.
Tutto cambiò con la riforma del contratto a termine realizzata dal governo Berlusconi con il d.lgs. n. 368/2001. Quella terza grande riforma pretendeva di cambiare gli equilibri complessivi che fino a quel momento avevano più o meno tenuto. Il legislatore, infatti, abbandonò la tecnica della flessibilità negoziata e anticipatamente filtrata dalla mediazione sindacale, tipica degli anni ‘80/’90 del secolo scorso, e optò per una tecnica di governo del ricorso ai contratti flessibili, risultata poi fallimentare, affidata alla norma legale ma, differentemente dalla l. n. 230 del 1962, questa volta incentrata sul precetto generale e aperto - il c.d. “causalone” - che identificava in non meglio specificate “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” i presupposti causali dell’apposizione del termine al contratto di lavoro. In questo modo si rimetteva, in definitiva, all’autonomia individuale l’individuazione dei presupposti oggettivi di assunzione a termine.
La norma a precetto indeterminato ha accresciuto enormemente il tasso di incertezza applicativa della disciplina legale e le dimensioni del relativo contenzioso giudiziale. Un contenzioso che ha fatto emergere il forte soggettivismo delle decisioni giudiziali orientate da un’interpretazione carica di opzioni valutative tipiche dell’applicazione di clausole generali che, come tali, necessitano di essere completate attingendo il significato delle norme da concetti presenti nella realtà sociale ovvero da fonti extra ordinem. In realtà la locuzione legale riferita alle “ragioni” oggettive di ricorso al contratto a termine non configurava una clausola generale (come è ad esempio quella del notevole o grave inadempimento o del congruo preavviso), quanto piuttosto un precetto legale a contenuto elastico che chiama l’interprete ad effettuare una valutazione che non dovrebbe essere ispirata ad opzioni di valore, bensì limitata alla verifica in concreto della sussistenza della ragione addotta dall’imprenditore afferente alla sfera delle decisioni produttive o organizzative dell’impresa, che come tali restano insindacabili, nonché alla verifica del nesso casale tra la ragione così enucleata e l’impiego del lavoratore assunto a termine.
Comunque la maggiore discontinuità segnata dalla riforma del 2001 rispetto al passato era rappresentata dalla soppressione di qualsiasi ruolo significativo della fonte collettiva nel governo della flessibilità in entrata. Il legislatore del 2001 poneva così fine alla stagione della flessibilità negoziata e apriva la nuova fase della flessibilità prevista direttamente dalla legge e rimessa all’autonomia individuale. Cioè all’accordo delle parti del rapporto di lavoro, tenute a concretizzare e contrattualmente specificare le ragioni oggettive genericamente previste dal legislatore. Non più quindi un mix di fonte legale e fonte collettiva, bensì un mix di fonte legale e autonomia individuale, in un quadro dove la norma legale non era puntuale, come lo era la l. n.230 del 1962, bensì aperta e indeterminata, accrescendo il grado di (apparente) discrezionalità dell’autonomia individuale.
La giurisprudenza ha, però, avuto una vera e propria crisi di rigetto nei confronti della riforma del 2001 e quella che è stata definita dai commentatori dell’epoca come una normativa di “liberalizzazione” del contratto a termine si è infranta, dopo almeno un quindicennio di tormentato contenzioso giudiziario, contro un’interpretazione fortemente restrittiva, rivelandosi in definitiva una vera e propria illusione ottica. I vincoli al contratto a termine, pur non previsti espressamente dal legislatore, né necessitati dalla normativa europea, sono stati sostanzialmente reintrodotti per via giudiziale, nella misura in cui è stato ritenuto sottointeso all’oggettività delle ragioni giustificative del termine, anche il requisito della sostanziale temporaneità delle stesse, di cui i giudici hanno fornito di volta in volta la propria personale accezione.
Questo sviluppo inglorioso della disciplina del contratto a termine rende più chiara l’operazione di politica del diritto sottesa alla successiva importante quarta riforma operata dal Jobs Act con il d. lgs. n.81 del 2015.
V. Speziale. Silvia Ciucciovino descrive in modo esaustivo l’evoluzione della disciplina del contratto a termine, la profonda valenza politica delle varie riforme che sono state introdotte, le diverse tecniche utilizzate e i contesti normativi nei quali esse sono state inserite.
Va rilevato, in primo luogo, che tra le innovazioni effettuate nel tempo va inclusa anche quella introdotta con il d.l. n. 48/2023, convertito nella l. n. 85/2023. Questa normativa va sicuramente ricordata per le importanti innovazioni che ha introdotto. Anche successivamente vi sono state modifiche ulteriori (nel 2024 e 2025), a dimostrazione del carattere assai “tormentato” della regolazione del contratto a termine.
Questo continuo processo riformatore è spiegabile con ragioni specifiche, connesse al ruolo del Diritto del lavoro nell’ambito della politica e alle diverse opinioni legate alla funzione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
In relazione al primo aspetto, non vi è dubbio che la riforma del Diritto del lavoro (e, in particolare di quello direttamente connesso alla regolazione del mercato del lavoro) sia ormai parte fondamentale di qualunque programma politico, venendo ad assumere un valore fortemente identitario per le maggioranze parlamentari e per il Governo da esse espresso che di volta in volta si succedono alla guida del Paese. L’idea, coltivata per lungo tempo anche a livello europeo, è che il Diritto del lavoro sia uno strumento di politica economica, al pari delle politiche di bilancio, di quelle dirette a sostenere il sistema produttivo o l’innovazione tecnologica, delle politiche fiscali e così via. Questa impostazione ha sicuramente un fondo di realtà, perché il Diritto del lavoro è un diritto della produzione, che influenza le dinamiche organizzative, la produttività, i costi diretti (retribuzione e oneri sociali) e indiretti (tutele normative più o meno limitative delle prerogative manageriali), i profitti di ogni singola impresa ecc.
Senza dimenticare i profili macroeconomici condizionati da questa branca del diritto, in rapporto ad esempio alla domanda aggregata di beni e servizi, al livello delle entrate fiscali (legate alle risorse distribuite dai contratti collettivi nazionali di lavoro), alla limitazione della concorrenza, alla regolazione del mercato del lavoro (politiche attive e capacità di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro), al rapporto tra salari e tasso di occupazione e disoccupazione e così via.
Tuttavia, la pretesa che il Diritto del lavoro possa avere una funzione essenziale nello sviluppo economico di un Paese e, in particolare, svolgere un ruolo determinante nei livelli di occupazione e di disoccupazione è assolutamente priva di riscontri empirici ed esprime una concezione che enfatizza oltre misura la funzione del diritto in generale – e di quello del lavoro in particolare – nell’ambito economico. Tale ruolo, in realtà, è assai limitato e non può certo sostituire gli strumenti tipici della politica economica (politiche di bilancio, fiscali, monetarie, sostegno economico alla domanda aggregata ecc.). Alcune regole in materia di lavoro possono indubbiamente avere un riflesso di tipo economico, ma in una misura molto più ridotta di quanto si è cercato di sostenere, con una accentuazione che, a ben vedere, rispecchia la impossibilità o difficoltà di utilizzare altri strumenti - come le politiche keynesiane di sostegno alla domanda aggregata e basate sul deficit spending o le svalutazioni competitive della moneta – che hanno caratterizzato lunghi periodi storici del nostro paese. Il Diritto del lavoro, in questo contesto, è stato chiamato a svolgere una funzione di supplenza di interventi di politica economica non più realizzabili o di minore impatto rispetto al passato con risultati economici che, a consuntivo, si sono rivelati deludenti.
La riforma costante del contratto a termine, peraltro, esprime anche il valore attribuito alla flessibilità del lavoro che, per oltre 25 anni, ha costituito, anche a livello europeo, il mainstream della materia. È evidente, infatti, che in sistemi giuridici in cui tutti i diritti dei lavoratori – considerati quali “rigidità” da rimuovere – sono prevalentemente incentrati sul contratto di lavoro a tempo indeterminato, il rapporto a termine è una alternativa valida ad un contratto standard considerato come eccessivamente tutelato e la maggiore diffusione del primo potrebbe incrementare la flessibilità del sistema, con tutti i presunti effetti positivi che ne possono scaturire. Anche in questo caso, la realtà ha smentito questa impostazione. Oggi anche le organizzazioni internazionali che maggiormente aveva sostenuto queste idee (Ocse, Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea) sono arrivate ad ammettere che la flessibilità del lavoro non produce gli effetti promessi sull’occupazione. Ed anzi, al contrario, una diffusione eccessiva di rapporti a termine può produrre conseguenze negative sui livelli di produttività, sugli investimenti formativi e quindi sulla stessa qualità del lavoro, inteso quale strumento fondamentale di creazione di valore per le imprese.
I fattori descritti sono dunque all’origine della “riforma continua” del rapporto a tempo determinato che ha caratterizzato gli ultimi 40 anni. Inoltre, la egemonia della lettura economica del diritto che ha caratterizzato questo lungo periodo ha causato una alterazione della funzione giuridica del contratto a termine, trasformato da modello contrattuale diretto a soddisfare esigenze temporanee di lavoro delle imprese e dei lavoratori a strumento di creazione di occupazione. Il tutto, in una concezione che considera l’occupazione prevalentemente sotto il profilo quantitativo (in base al noto aforisma che è meglio un lavoro non stabile che la disoccupazione), senza considerare che la qualità del lavoro – oltre ad essere fondata sulla nostra Costituzione e sulle tutele garantite dalle Carte dei diritti fondamentali a livello europeo – è un presupposto essenziale per una migliore produttività e qualità dei processi e dei prodotti delle imprese. Non è un caso, infatti, che il nuovo paradigma della impresa e dello sviluppo sostenibile si basino proprio sulla valorizzazione del lavoro quale strumento di realizzazione delle finalità sociali e produttive connesse al concetto di “sostenibilità”.
Le condizioni descritte spiegano perché il processo di liberalizzazione del contratto a termine, che si era svolto anche negli anni ’80 e ’90 ma con maggiore moderazione e filtrato anche dal controllo sindacale, si è particolarmente accentuato dal 2001 al 2018, con riduzione dei vincoli normativi e ampliamento delle sue possibilità di utilizzazione (salvo qualche intervento in controtendenza, come quello realizzato con la legge n. 247 del 2007). In sostanza, nel periodo di tempo indicato, le riforme del contratto a termine hanno avuto la finalità di assicurare alle imprese le assunzioni a termine come strumento generale e privilegiato di accesso al lavoro allo scopo di: a) consentire di testare le capacità professionali e le caratteristiche personali del lavoratore per periodi temporali più lunghi rispetto ai periodi di prova previsti dai CCNL; b) evitare i limiti giuridici connessi al licenziamento; c) in situazioni caratterizzate da incertezza economica e fluttuazioni nella domanda provenienti dal mercato, escludere l’inserimento in organico di lavoratori stabili, mantenendo una quota elevata di dipendenti temporanei.
Senza dubbio gli enormi processi di cambiamento che hanno caratterizzato i sistemi economici e i modelli organizzativi delle imprese nella parte finale del XX secolo e nei primi 25 anni di quello in corso hanno modificato la struttura della domanda di beni e servizi, con una maggiore alternanza nei flussi di intensità della produzione delle imprese, caratterizzati da picchi più elevati di attività, seguiti da periodi meno intensi. Vi era quindi l’esigenza di un uso diverso dei contratti a termine per fare fronte a queste nuove esigenze produttive, riducendo le eccessive limitazioni al suo ricorso che avevano caratterizzato alcune normative degli anni ’60 e ’70. Tuttavia, il processo che si è realizzato è andato ben al di là di questa necessità di adeguamento normativo e si è tradotto in una liberalizzazione eccessiva della disciplina, escludendo la mediazione sindacale e trasformando il contratto a termine in un modello contrattuale tendenzialmente fungibile con il lavoro stabile, con effetti economici importanti, che esaminerò in seguito.
Silvia Ciucciovino sottolinea come sarebbe scorretto collegare la diffusione del contratto a termine al fenomeno della precarietà, visto che essa sarebbe propria delle forme di lavoro irregolare meno tutelate. Non vi è dubbio che il rapporto a tempo determinato sia più protettivo per i lavoratori rispetto al lavoro “in nero” o anche ad alcune modelli contrattuali tipizzati dalla legge (si pensi al lavoro intermittente o a quello occasionale). Tuttavia, non va dimenticato che molti studi empirici hanno messo in evidenza come i dipendenti a termine abbiano di fatto retribuzioni inferiori a quelli stabili, nonostante la legge non consentirebbe questa differenziazione, espressamente vietata. Inoltre, le analisi sociologiche ed economiche hanno messo in rilievo come la reiterazione dei contratti a tempo determinato, consentita dalla disciplina vigente, può realizzare la cosiddetta “trappola della precarietà”. I lavoratori che per anni sono utilizzati con rapporti a termine, anche per i minori investimenti in formazione (che, per il loro costo e per l’attesa da parte dell’impresa di poterli utilizzare, sono generalmente destinati ai dipendenti stabili), hanno meno possibilità di essere assunti con contratti a t. indeterminato, con tutte le conseguenze annesse in termini di incertezza del reddito, minore possibilità di pianificare il proprio futuro, incremento nel gap di professionalità ecc.
Nel periodo antecedente alla introduzione del d.lgs. n. 81/2015, Silvia Ciucciovino descrive la riforma del 2001, con l’abbandono della tecnica della flessibilità negoziata dalla mediazione collettiva e l’introduzione di una causale legata a ragioni di carattere tecnico ed organizzativo. La Collega rileva poi come questa riforma abbia determinato un processo di notevole incremento del contenzioso caratterizzato da un forte soggettivismo delle decisioni giudiziali, ispirate ad opzioni di valore che avrebbero dovuto essere escluse nella interpretazione della disposizione. Si afferma, inoltre, che la giurisprudenza ha avuto “una crisi di rigetto nei confronti della riforma del 2001”, che ha ridotto in modo consistente l’intento di liberalizzare l’uso del contratto a termine e, dopo un quindicennio, ha adottato una interpretazione fortemente restrittiva della nuova normativa, reintroducendo in via giudiziale i vincoli che si era voluto evitare, in particolare tramite la riaffermazione della temporaneità delle ragioni tecniche ed organizzative previste dal d.lgs. n. 368/2001.
Rilevo, in primo luogo, che l’utilizzazione di norme “aperte” o a contenuto elastico non può che necessariamente ampliare la discrezionalità del giudice nella interpretazione delle stesse, rispetto a fattispecie più specificamente regolate. Tuttavia, l’uso di disposizioni con queste caratteristiche è ormai una tecnica ampiamente diffusa in tutti i settori del diritto e si lega a fattori di evoluzione dei sistemi normativi che rendono sempre più difficile ipotizzare una regolazione per fattispecie molto dettagliate, per ragioni diverse e che qui non posso esaminare (tra cui, comunque, la difficoltà di regolare con disposizioni molto particolareggiate una realtà in evoluzione rapidissima, che rende subito obsolete norme appena emesse). Inoltre, nel Diritto del lavoro la presenza di norme con queste caratteristiche è da sempre assai diffusa e senza che tale tecnica sia stata mai oggetto di critiche assai accentuate come nel caso del contratto a termine. Il caso sicuramente più significativo è quello della giusta causa e del giustificato motivo di licenziamento, dove la funzione della giurisprudenza nel dare contenuto a tali norme aperte è assai ampia. Ma gli esempi potrebbero continuare, perché disposizioni simili caratterizzano tutta la produzione normativa italiane (e anche europea).
La critica alla interpretazione della giurisprudenza basata su opzioni di valore non considera che questa tecnica interpretativa è un portato ineludibile della trasformazione del processo di ascrizione di un significato ad una norma, che è oggi un metodo aperto dove – secondo gli insegnamenti della ermeneutica giuridica – i valori sono parte integrante del processo, anche per la possibilità per il giudice di adottare direttamente una interpretazione costituzionalmente ed eurounitariamente orientata di una disposizione, accedendo a testi (Costituzione, Trattati) che sono fortemente impregnati di principi e valori a cui essi si ispirano. Senza dimenticare che anche norme sulla interpretazione legate a diversi periodi storici – come l’art. 12 delle preleggi – nell’attribuire rilievo alla “intenzione del legislatore” danno spazio proprio alle finalità perseguite dalla legge e alle scelte di valore ad essa sottese. Il problema, dunque, non è quello di una “interpretazione per valori”, che è ormai un dato acquisito delle tecniche interpretative, quanto la giustificazione che il giudice è in grado di dare sia sulla selezione dei valori, sia sulla loro utilizzazione nella lettura della disposizione sottoposta al suo giudizio, che è espressione del principio della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali previsto dall’art. 111, c. 6, Cost.
La tesi secondo cui la giurisprudenza avrebbe “remato contro” la riforma, limitandone la portata liberalizzatrice e reintroducendo presupposti (come la temporaneità) non previsti dalla legge, non mi trova d’accordo. La verità è che la tesi sostenuta da una parte della dottrina, secondo cui il “causalone” previsto dall’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 consentiva di stipulare il contratto in presenza di ragioni oggettive ma non temporanee, era difficilmente sostenibile. La formulazione letterale della disposizione, letta in connessione con la disciplina del lavoro stabile e con i valori costituzionali ed eurounitari esistenti, rendeva implausibile tale interpretazione. Essa, tra l’altro, anche in considerazione della assenza di limiti temporali massima alla durata del contratto, avrebbe consentito di instaurare rapporti a termine per periodi lunghissimi, rendendo di fatto questa tipologia contrattuale del tutto identica alle assunzioni a t. indeterminato, in palese contraddizione con la Direttiva 1999/70/Ce, che il d.lgs. n. 368/2001 ha implementato nell’ordinamento nazionale. La fonte europea, infatti, afferma che la “forma comune” dei contratti è quella senza limite di durata. E non è un caso che la giurisprudenza della Corte di giustizia europea abbia costantemente affermato, negli anni successivi alla sua emanazione, che la Direttiva andava interpretata nel senso di consentire la stipulazione di contratti temporanei e non tali da sostituire il lavoro stabile. La giurisprudenza italiana, e in particolare la Cassazione, non ha potuto fare altro che adeguarsi alla interpretazione più coerente con una lettura della normativa all’interno del sistema giuridico italiano ed europeo.
V. A. Poso. Soffermiamoci sul d. lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, emanato in attuazione dell’art. 1, c. 7, della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, che si inserisce nel complessivo disegno riformatore
- da molti non condiviso - del Jobs Act. Quali sono i punti salienti di questa disciplina, stando al testo originario del decreto legislativo?
V. Speziale. Il d.lgs. n. 81 del 2015, nella sua impostazione originaria, segna una netta cesura con la disciplina precedente meno recente. Il contratto a termine, che dagli anni ’60 in poi era sempre stato caratterizzato dalla presenza di una ragione giustificativa, diventa “acausale”. Il datore di lavoro ha solo un limite temporale massimo di 36 mesi, che peraltro può essere derogato in senso migliorativo o peggiorativo dai contratti collettivi e, comunque, esteso di altri 12 mesi in sede di negoziazione assistita. Inoltre, la normativa, oltre alla possibile e fondamentale modifica alla durata massima del rapporto, riattribuisce alla autonomia collettiva poteri regolatori e/o derogatori importanti, in materia di individuazione delle ipotesi di lavoro stagionale (art. 21, c. 2), di deroga ai limiti quantitativi nelle assunzioni a termine (art. 23, c. 1 e c. 2, lett. a) e in tema di diritto di precedenza (art. 24, c. 1), in relazione alla formazione dei lavoratori a termine (art. 26), per l’individuazione dei casi di servizi speciali nel settore turismo e pubblici esercizi di durata non superiore a tre giorni ed esentati dalla applicazione della disciplina generale sul termine (art. 29, c. 2, lett. b).
Le nuove regole segnano, innanzitutto, il passaggio da un controllo qualitativo sulle ragioni tecniche e organizzative ad uno prevalentemente quantitativo. Lo scopo perseguito è, in primo luogo, quello di eliminare la verifica giudiziaria sulla causale del contratto, escludendo il principio della temporaneità delle esigenze di lavoro a termine, che si era ormai consolidato nella giurisprudenza. L’intento di liberalizzare il rapporto e di depotenziare una interpretazione giurisprudenziale che ne restringeva l’utilizzo è assolutamente evidente. In alcuni commenti si è messo in evidenza che la riforma intendeva ridurre le incertezze applicative espresse dai giudici, che, in realtà, nel 2015 avevano trovato un loro assetto abbastanza consolidato e con un grado di indeterminatezza non certo superiore a quello presente nella giurisprudenza in materia di licenziamento o in altre ipotesi. In verità, questa sfiducia nel controllo giurisdizionale e la volontà di ridurre la discrezionalità del giudice è una finalità perseguita dalla legislazione del 2015 in generale, come dimostrano le vicende del d.lgs. n.23/2015 sul contratto a tutele crescenti, caratterizzato da tecniche normative che limitano il controllo del magistrato e, attraverso la diminuzione delle tutele, favoriscono discipline che consentono un’esatta predeterminazione dei costi sostenuti dalle imprese. Certezza del diritto e riduzione del contenzioso sono gli obiettivi fondamentali da perseguire, anche se determinano un sensibile decremento dei diritti dei lavoratori.
La vera finalità della riforma del 2015 era comunque un'altra: trasformare il contratto a termine, da strumento se non eccezionale quantomeno derogatorio rispetto alla “forma comune” del rapporto stabile, in un modello contrattuale del tutto fungibile rispetto al contratto a t. determinato. Nel limite massimo di 36 mesi, estensibile ulteriormente dai contratti collettivi senza “tetti massimi” e con la possibilità di ulteriori 12 mesi in sede di negoziazione assistita, si eliminava qualsiasi distinzione basata sulle ragioni organizzative dell’impresa o personali del dipendente. Il datore di lavoro poteva assumere a termine con più contratti e nei limiti massimi previsti dalla legge o dal contratto collettivo per soddisfare esigenze di lavoro stabile. In questo caso, gli obiettivi già descritti (testare il lavoratore per un periodo assai più lungo dei periodi di prova previsti dalla legge e dai Ccnl; bypassare i vincoli giuridici previsti per i licenziamenti individuali e collettivi; creare una quota fissa di personale a termine, indipendentemente dalla sussistenza di bisogni di lavoro temporaneo) sono stati la finalità principale perseguita dal legislatore.
In ogni caso, dal punto di vista delle tecniche normative, la eliminazione di una distinzione funzionale tra lavoro a termine e a t. indeterminato costituisce una vera e propria rottura con il passato. Essa, da un lato, ribadisce l’utilizzazione del contratto a termine come strumento di incremento della occupazione, che si sperava favorita dalla eliminazione della causale e del controllo giurisdizionale. Un sistema che, come vedremo, ha contribuito in modo rilevante ad aumentare la diffusione di contratti privi di stabilità. Inoltre, la finalità è quella di aumentare in modo consistente la flessibilità organizzativa delle imprese, indipendentemente dal carattere stabile o meno della esigenza di lavoro, e con possibilità di favorire un maggiore turn over nei livelli occupazionali.
Il limite dimensionale del 20 per cento dei lavoratori stabili costituiva, indubbiamente, un deterrente importante ad una espansione incontrollata del lavoro a t. determinato. Tuttavia, le numerose deroghe previste dalla legge per ipotesi escluse da limitazione quantitative (art. 23, c. 2) e soprattutto il potere derogatorio affidato ai contratti collettivi di qualunque livello estenderanno in materia significativa il tetto quantitativo, ampliando in misura significativa la diffusione del contratto a termine. L’evoluzione della contrattazione collettiva successiva alla emanazione della legge, sia a livello nazionale e soprattutto a livello decentrato, comporterà un innalzamento significativo dei tetti quantitativi. Per quanto attiene i contratti aziendali, vi sono stati casi dove il limite è stato incrementato in misura assai rilevante, arrivando al 70/80 per cento dell’intero organico dell’impresa.
La riforma del 2015, già anticipata da precedenti normative, come si è visto ha attribuito funzioni importanti alla autonomia collettiva. Tuttavia, in coerenza con l’ispirazione complessiva della riforma, il sindacato non poteva esercitare un controllo sulle ragioni economiche ed organizzative (aggiungendovene altre o specificando quelle legali), ma solo sulla quantità dei contratti. L’autonomia collettiva, inoltre, aveva un ampio potere derogatorio alle discipline legali in molte materie (intervalli temporali tra un contratto e l’altro, periodo massimo di trentasei mesi, diritto di precedenza). La deroga avrebbe potuto anche essere migliorativa. Tuttavia, come sottolineato da un’autorevole dottrina, la legge aveva attribuito al sindacato un potere contrattuale “in salita” e assai difficile da esercitare. Nella misura in cui, infatti, le deroghe avrebbero inciso sulla utilizzazione del contratto e sulle opportunità occupazionali che esso offriva, le organizzazioni sindacali hanno avuto forti difficoltà a contrastare le esigenze di una utilizzazione più ampia dal punto di vista quantitativo e più estesa sotto il profilo temporale di questa tipologia contrattuale.
L’alternativa, infatti, era quella di impedire l’assunzione di lavoratori, seppure a termine, con il rifiuto di opportunità di lavoro difficili da giustificare nei confronti dei lavoratori iscritti e non ai sindacati. E non è un caso che molti Ccnl, in settori economici importanti, hanno ampliato i tetti quantitativi e anche il periodo massimo di 36 mesi, consentendo di stipulare contratti a termine per periodi di 4 o 5 anni (a volte con tetti massimi previsti, insieme, per termine e somministrazione a t. determinato) e, in alcuni casi, hanno addirittura eliminato qualsiasi vincolo massimo di durata. Inoltre, come si è detto, questa tendenza alla disciplina più favorevole alle imprese si è manifestata anche a livello aziendale, con deroghe ancora più accentuate.
La riforma del 2015, in conclusione, oltre a mutarne natura e funzione, ha determinato una decisa liberalizzazione del contratto a termine, dimostrata anche dai dati statistici successivi al 2015, come vedremo.
La nuova disciplina, inoltre, ha posto problemi di compatibilità con la Direttiva 1999/70/CE, il cui rispetto, alla luce della prevalenza del diritto europeo su quello nazionale, deve sempre essere garantito. La Direttiva, finalizzata a prevenire l’abuso nella utilizzazione del contratto a termine, ha previsto tre modalità alternative di regole dirette a raggiungere tale scopo. Da questo punto di vista, la normativa introdotta dal d.lgs. n.81/2015 ne prevede due (la durata massima totale dei contratti e il numero delle proroghe, che, pur diversi, sono assimilabili ai rinnovi). Essa, quindi, sembra perfettamente in linea con la disciplina europea. Tuttavia, la Corte di giustizia (CGE) ha con molte sentenze affermato che la normativa nazionale che attua la Direttiva non debba essere tale da soddisfare esigenze di lavoro “permanenti e durevoli”. Tale limite opera, a giudizio della CGE, anche se vi sono due delle misure previste dalla fonte europea, come la presenza di ragioni obiettive e la durata massima dei contratti a termine successivi. Infatti, anche singole necessità oggettive temporanee non escludono l’abuso se, complessivamente considerate, sono tali da soddisfare esigenze lavorative non transitorie, tranne l’ipotesi della sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Le regole introdotte dal d.lgs. n. 81/2015, nella sua versione originaria, prevedevano la totale “acausalità” del contratto a termine, dei rinnovi e delle proroghe e una durata complessiva di utilizzazione molto ampia (36 mesi). Il limite temporale - nel caso di successione di rapporti - poteva essere ulteriormente esteso dalla contrattazione collettiva (o addirittura, come è accaduto, del tutto rimosso). La normativa, pertanto, di fatto consentiva l'uso di rapporti a termine per soddisfare esigenze stabili di lavoro, sia in considerazione della piena fungibilità tra tempo determinato e indeterminato - pur nel limite massimo previsto dalla legge o dai contratti collettivi - sia in considerazione di altre regole normative che consentono di estendere in modo significativo la durata dei contratti (ad esempio, con il semplice mutamento di mansioni). In tale contesto, inoltre, le norme sul contingentamento dei lavoratori assunti a termine non potevano svolgere alcuna funzione, perché esse non escludevano che i contratti stipulati potessero soddisfare stabili esigenze organizzative. Questo potenziale contrasto con la Direttiva, tuttavia, non ha originato un contenzioso né a livello nazionale, né a quello europeo.
S. Ciucciovino. Con il d. lgs. n. 81/2015 si procede ad una netta modifica, rispetto all’impianto del 2001, dei limiti sostanziali di ricorso al contratto a termine. Si inaugura una fase in cui l’assunzione a termine è acausale, cioè non più sottoposta a limiti sostanziali di carattere qualitativo (legati, come in passato, alle ragioni giustificative oggettive che avevano sviluppato tanto contenzioso), bensì assoggettata unicamente a limiti quantitativi di utilizzo, di agevole determinazione. Ciò ha determinato, più che una liberalizzazione del lavoro a termine, una tecnica di controllo e governo diversa dal passato, più quantitativa e meno qualitativa, sicuramente più certa e meno soggetta al sindacato giudiziale. In particolare i limiti quantitativi riguardano; la durata del singolo contratto (inizialmente 36, poi 24 mesi); la successione di più contratti con il medesimo lavoratore (inizialmente 36, poi 24 mesi); la proporzione in percentuale degli assunti a termine rispetto agli assunti a tempo indeterminato, infatti, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
La tecnica legislativa di regolazione e contenimento dei contratti temporanei (ma più in generale di tutte le tipologie flessibili) con il Jobs Act si caratterizza per il netto abbandono della norma generale ed elastica a contenuto indeterminato – che lasciava ampio spazio alle incertezze applicative e ad una valutazione e apprezzamento qualitativo della flessibilità da parte del giudice - per imperniarsi esclusivamente su limiti di carattere quantitativo, certi e agevolmente verificabili (percentuali massime e durata del singolo contratto o di più contratti in successione) che consentono di demarcare molto più agevolmente del passato i confini del lecito utilizzo dei contratti flessibili e praticamente azzerano ogni sindacato giudiziale sulla motivazione economica sottostante alla scelta datoriale di ricorso al lavoro temporaneo.
Con il d. lgs. n.81/2015 viene inoltre realizzato un riassetto complessivo delle fonti di disciplina dei contratti flessibili, con la restituzione di un considerevole spazio all’autonomia privata collettiva nella regolazione della flessibilità, con disposizioni che si configurano come vere e proprie deleghe in bianco al contratto collettivo, sul modello della flessibilità negoziata degli anni ’80/’90 del secolo scorso. Il contratto collettivo così ha potuto in questa materia riprendere a svolgere un ruolo essenziale e forse ancor più rilevante del passato. L’apertura all’intervento della autonomia collettiva è veramente considerevole, anche comparato alla stagione della flessibilità negoziata, sia per la facoltà concessa al contratto collettivo di integrare la disciplina legale e di derogarla anche in pejus, sia perché tale potere è riconosciuto non più soltanto al contratto nazionale, bensì a tutti i livelli contrattuali, con un rinvio ampio ai “contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e [a]i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria” (art. 51, d. lgs. n. 81/2015).
In realtà, non si può comprendere la portata della modifica della disciplina del contratto a termine del 2015 se non si guarda al più complessivo disegno riformatore del Jobs Act. Il cuore della riforma messa in campo dal Jobs Act, infatti, ruota attorno al riposizionamento del contratto di lavoro a tempo indeterminato al centro del sistema del diritto del lavoro per restituirgli la perduta primazia. Una posizione dalla quale, al di là delle formali declamazioni del legislatore, era stato obiettivamente scalzato anche dalla stessa produzione legislativa dell’ultimo ventennio, tutta tesa ad iniettare dosi di flessibilità al margine del contratto a tempo indeterminato, attraverso la creazione di alternative più o meno convenienti a quest’ultimo.
Non occorre essere acuti osservatori dei fenomeni giuridico-sociali per riconoscere che lo sviluppo abnorme della flessibilità tipologica e – segnatamente – di quella caratterizzata dalla temporaneità dell’impiego, ha ingenerato negli ultimi anni almeno due grandi distorsioni nell’utilizzo dei rapporti di lavoro temporanei: a) in primo luogo il termine contrattuale è stato utilizzato, spesso e volentieri, come surrogato del licenziamento, come vera e propria via di fuga dalle strettoie e dai costi di separazione dal contratto a tempo indeterminato connessi al licenziamento illegittimo; b) in secondo luogo la domanda di flessibilità espressa dal sistema produttivo ha trovato indulgente risposta proprio dal legislatore che l’ha convogliata nel canale della flessibilità numerica o esterna, grazie alla previsione di una pluralità di tipologie contrattuali temporanee.
Di questa miope scelta di politica del diritto in definitiva i lavoratori a termine, specie i più giovani, hanno pagato il prezzo più alto. Ma anche l’autonomia collettiva ha le sue responsabilità, perché sui temi centrali della flessibilità interna del contratto di lavoro subordinato standard – inquadramenti, orari e retribuzioni – non si può certo dire che i contratti collettivi abbiano messo a frutto gli ampi margini di governo di cui da sempre dispongono e che avrebbero potuto forse utilizzare di più per rispondere in modo condiviso ai bisogni di flessibilità del sistema produttivo e di accrescimento della produttività.
Questo contesto ha favorito la precarietà del lavoro ma soprattutto ha contribuito ad inquinare o viziare, se così si può dire, l’utilizzo pur formalmente legittimo dei rapporti di lavoro temporanei. La correzione di queste distorsioni è stata inevitabilmente lasciata nelle mani di una magistratura che ha acquisito un ruolo rilevantissimo (e forse eccessivo) nel controllo della dose di flessibilità legittimamente attingibile dal sistema economico.
Al di là del giudizio che se ne possa dare nel merito, è indubbio che il Jobs Act abbia gettato le basi per uno stravolgimento completo delle condizioni di contesto appena rammentate.
V. A. Poso. Sta di fatto che, almeno a leggere l’art. 1, comma 1, d. lgs. n. 81/2015, sin dalla sua rubrica: «Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro». È così, nella sostanza? Quanto incidono i contratti a termine nel complesso delle assunzioni?
S. Ciucciovino. Con i Jobs Act si è voluto incidere su alcuni dei principali fattori di condizionamento responsabili dell’utilizzo improprio dei contratti temporanei degli anni precedenti. In particolare, da un lato, ha introdotto una maggiore flessibilità in uscita dal contatto a tempo indeterminato standard (contratto a tutele crescenti) grazie alla sostituzione dell’art. 18 con un nuovo sistema rimediale economico per il licenziamento illegittimo (anche questo oggetto oggi di requisito referendario) e, dall’altro lato, ha introdotto rilevanti dosi di flessibilità funzionale interna al rapporto di lavoro che, nel disegno del legislatore, avrebbero dovuto innescare un processo di attrattività e ri-centralizzazione del contratto a tempo indeterminato. Tutto ciò avrebbe dovuto creare le premesse, nell’intenzione del legislatore, per depurare il contratto a termine da utilizzi strumentali, cioè volti all’aggiramento della disciplina limitativa del licenziamento dal contratto a tempi indeterminato, con l’intento di riportare il ricorso al contratto a termine ad un impiego fisiologico e non più sostitutivo del lavoro a tempo indeterminato.
Può dirsi riuscito questo proposito? Il tentativo di riforma dell’art. 18,St.Lav., è stato fortemente intaccato dalla Corte Costituzionale. Inoltre, sul piano delle flessibilità interne al rapporto di lavoro, l’autonomia collettiva non ha saputo sempre cogliere adeguatamente le sfide lanciate dal legislatore e non si è appropriata – come avrebbe potuto fare - della modernizzazione della disciplina del lavoro subordinato standard (basti pensare all’enorme ritardo con cui i CCNL hanno messo mano agli inquadramenti, senza dare adeguato seguito alla modifica dell’art. 2103 c.c.). Quindi due assi portanti dell’intero disegno di riforma in cui si inseriva la nuova disciplina del contratto a termine - flessibilità interne e flessibilità in uscita dal contratto a tempo indeterminato - sono stati fortemente indeboliti.
Dal punto di vista quantitativo le ricerche condotte dall’Osservatorio sul mercato del lavoro da me coordinato presso l’Università Roma Tre, che elabora dati forniti dal Ministero del lavoro, mettono in evidenza come la quota dei contratti a tempo determinato sulle attivazioni complessive (dati di flusso) è rimasta elevata e cresciuta dal 2010 al 2023 passando dal 56% del 2010 a valori intorno al 60% intorno al 2020 per attestarsi a circa il 67% nel 2023 e 2024. La quota delle attivazioni con contratti a tempo indeterminato si è ridotta nel tempo (eccetto un picco del 19,6% nel 2015), passando dal 16,5% del 2010 all’11,7% del 2017, per poi riprendere un trend leggermente crescente dal 2018 attestandosi al 12.5% nel 2023.
Se guardiamo ai dati di stock, il numero di persone occupate con un contratto a tempo indeterminato nel 2023 ha raggiunto uno storico picco di 15,57 milioni, l’84,2% dei lavoratori dipendenti. I lavoratori occupati con contratto a termine nel 2023 sono stati 2,97 milioni, pari al 15,8% del totale dei lavoratori dipendenti. Il dato è lievemente in calo rispetto al 2022, quando i lavoratori a termine superavano i 3 milioni ed erano pari al 16,8% del totale.
Guardando alla situazione occupazionale a 24 mesi degli assunti con contratto a termine si nota che, considerando i lavoratori attivi con un contratto a termine nel primo trimestre del 2022 (tra i 25 e i 55 anni), dopo 24 mesi circa il 30% risultava non essere più occupato con un contratto di lavoro dipendente. Il 24,4% risultava essere occupato con un contratto a tempo indeterminato, mentre il 39,7% con un contratto a tempo determinato.
I dati ci parlano, quindi, di un mercato del lavoro molto dinamico, ma non certo totalmente precarizzato. Guardando ai dati di stock la quota dei tempi determinati rispetto agli assunti a tempo indeterminato si attesta ampiamente al di sotto di quella soglia del 20% che il legislatore individua come una proporzione accettabile di ricorso al tempo determinato.
V. Speziale. Il d.lgs. n. 81 del 2015 aveva la finalità di incrementare l'occupazione attraverso la riforma della disciplina dei licenziamenti individuali (come risulta da quanto espressamente affermato nella legge delega) e rendendo più flessibili le assunzioni a termine. In relazione al primo aspetto, la nuova disciplina partiva dall'assunto - sostenuto dai teorici della Law & Economics - secondo cui regole troppo vincolanti in materia di licenziamento avrebbero ostacolato le assunzioni, con la conseguenza che la diminuzione di tutele avrebbe favorito la diffusione del lavoro stabile quale “forma comune”. Questa teoria, smentita dalla letteratura prevalente in materia economica, non ha trovato nessun riscontro empirico, con particolare riferimento al mercato del lavoro italiano, dove studi e ricerche approfonditi compiuti nell'arco di oltre un trentennio hanno addirittura messo in evidenza come tale mercato ha una struttura definita come “liquida”, perché caratterizzata da un turnover assai elevato nella creazione e distruzione di posti di lavoro. E le stesse vicende successive all'emanazione del decreto legislativo hanno confermato tale aspetto, nella misura in cui la consistente crescita dei rapporti di lavoro stabili realizzata subito dopo il d.lgs. 23/2015 è stata determinata non dalle modifiche della disciplina dei licenziamenti ma dagli elevati incentivi economici per le assunzioni a t. indeterminato, con un processo che si è interrotto non appena essi sono terminati (anche per gli alti costi incidenti sul bilancio dello Stato).
A parte tale aspetto, l'idea di ridare centralità al lavoro stabile è stata palesemente contraddetta dalla evidente riforma del contratto a termine, che ne ha ampliato in modo significativo la possibile diffusione. Il che dimostra una certa confusione nel disegno ispiratore del Jobs Act, che peraltro può essere compresa qualora le due riforme vengano lette insieme e inquadrate nel reale intento perseguito dal legislatore: diminuire le tutele in materia di licenziamento e rendere più agevole l'utilizzazione del contratto a termine. Si tratta di finalità che ben poco hanno a che vedere con l'obiettivo di riaffermare il lavoro subordinato a tempo indeterminato come forma comune del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda l’incidenza dei contratti a termine sulle assunzioni, i dati messi in evidenza da Silvia Ciucciovino rivelano una crescita costante di questa tipologia contrattuale dal 2010 al 2024 (dal 56% al 67%), con una riduzione delle attivazioni di lavoro stabile (passate dal 16,5% nel 2010, al 12,5% nel 2023). In tempi più recenti, l’Osservatorio sul mercato del lavoro della Università Roma Tre mette in evidenza percentuali che si collocano tra il 16,8% (2022) e il 15,8% (2023), pur in presenza di un elevata quantità di rapporti stabili. I dati sono in linea con la media europea, che si colloca intorno al 16% nel 2018 e nel 2022 (in base a dati Eurostat) è del 14%. In Italia, secondo l’Istat e con riferimento al 2024, le assunzioni a termine sono pari al 14,69 rispetto a tutti i lavoratori dipendenti. Altre fonti di rilevazione mettono in evidenza aspetti ulteriori. I dati Inps – aggiornati a marzo 2025 - affermano che, nel 2023, sul totale delle assunzioni effettuate (5.089.321), quelle a termine sono pari al 73,15% (3.722.959). Nel 2024, le assunzioni complessive sono pari a 4.962.658 e quelle a t. determinato sono il 74,36% (3.690.359), in un contesto dove, secondo le elaborazioni del Ministero del lavoro riferite alle comunicazioni obbligatorie gennaio – settembre 2024 e considerando tutte le tipologie contrattuali (t. determinato, collaborazioni, lavoro a chiamata, stagionale, somministrazione), le assunzioni stabili sono solo il 16%, mentre i contratti temporanei restano il principale canale di accesso al lavoro.
Si può dunque rilevare che, mentre la percentuale dei lavoratori a termine è abbastanza elevata ma coerente con la media europea, il fattore più rilevante è l’elevatissima quantità di assunzioni a tempo determinato (effettuate anche in relazione al medesimo lavoratore) rispetto a quelle stabili. E poiché è assai difficile poter ritenere che dati così elevati siano collegati ad effettive esigenze di lavoro temporaneo, vi è la dimostrazione evidente della utilizzazione impropria del contratto a termine. Esso è usato come tipologia contrattuale di ingresso nel mondo del lavoro e anche per soddisfare ragioni stabili di lavoro, con la distorsione funzionale di cui ho già parlato in precedenza.
Inoltre, come rileva la Banca d’Italia nella Relazione annuale del 2023 (p. 109), “nonostante l’incidenza del lavoro a termine sia scesa nel corso dell’ultimo quadriennio, principalmente nella fascia di età tra 15 e 34 anni, essa resta comunque molto più alta rispetto all’inizio degli anni duemila. Circa l’80 per cento dei lavoratori con un contratto a tempo determinato non viene stabilizzato entro due anni dall’assunzione: il 30 per cento rimane occupato con un altro contratto a termine e il restante 50 non risulta più impiegato alle dipendenze. Secondo nostre analisi ciò è dovuto al fatto che un numero significativo di imprese, anziché stabilizzare il personale già assunto con contratti di tipo temporaneo, preferisce assumere nuovi lavoratori a termine. Il fenomeno si concentra in alcune aziende che utilizzano sistematicamente contratti di breve durata, in particolare nei comparti delle costruzioni, dell’alloggio e ristorazione e delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, in larga misura indipendentemente dalla stagionalità dell’attività”.
Dunque, la riforma del 2015 (insieme a quelle immediatamente precedenti) ha sicuramente inciso sull’incremento complessivo dei contratti a tempo determinato rispetto all’inizio del secolo e ha favorito quella che ho definito la “trappola della precarietà”, oltre a concorrere alla utilizzazione di contratti di breve durata come strumento ordinario per soddisfare le proprie esigenze lavorative, come si è già detto.
Quest’ultimo profilo è messo in evidenza dalla analisi di alcuni dati. A seguito della emanazione del Decreto Dignità del 2018, che ha certamente ristretto la possibile utilizzazione del contratto a termine dopo i 12 mesi, secondo le rilevazioni del Ministero del lavoro, nei 10 mesi successivi (luglio 2018 – aprile 2019) vi è stato un consistente aumento dei rapporti a t. indeterminato (+ 11,8%) e la riduzione di quelli a termine (- 4,2%) e di quelli in somministrazione (- 26,2%, anch’essi riformati dal Decreto. Questi dati mettono in rilievo l’uso distorto del contratto a t. determinato a cui ho fatto riferimento in precedenza. Le imprese assumevano a termine pur a fronte di esigenze stabili di lavoro. Quando la legge non ha più consentito, dopo i 12 mesi, questa possibilità, esse hanno aumentato in modo molto accentuato le trasformazioni in rapporti a t. indeterminato, perché avevano sperimentato i lavoratori e ne avevano bisogno per soddisfare le necessità di lavoro stabile esistenti sin dall’origine.
In una valutazione di sintesi si può osservare che la disciplina del rapporto a termine, sia quella che ne liberalizza l’uso o che ne restringe il campo di applicazione, incide sulla ripartizione delle occasioni di lavoro tra quello stabile e quello a t. determinato, senza che influenzi il livello complessivo di crescita dell’occupazione o di riduzione della disoccupazione. Inoltre, la mancanza di causali che specifichino quando è possibile ricorrere a questa tipologia contrattuale favorisce un uso opportunistico del contratto a termine, utilizzato anche per soddisfare esigenze permanenti di lavoro, aumentando il livello di instabilità dei rapporti di lavoro e contraddicendo l’obiettivo del tempo indeterminato come “forma comune” del lavoro.
V. A. Poso Qual è il Vostro giudizio complessivo sulla disciplina normativa dei contratti a termine dopo l’intervento del legislatore del Jobs Act ?
V. Speziale. La valutazione complessiva sulla riforma introdotta dagli articoli 19 e seguenti del d.lgs. n. 81 del 2015 deve prendere in considerazione i diversi contenuti della disciplina, che, dopo l'intervento iniziale, è stata modificata più volte. Questi cambiamenti, come ho già detto, rispecchiano il ruolo attribuito al contratto a termine quale strumento di lavoro flessibile o di accesso all’occupazione. Le innovazioni introdotte dopo il 2015 sono state numerose, ma esaminerò solo quelle più importanti.
La formulazione originaria introdotta nel 2015, con un contratto a termine “acausale” e con il limite complessivo dei 36 mesi, ha concluso un processo di liberalizzazione della materia che, cominciato nel 2012, è poi proseguito nel 2014. Ho già espresso le mie considerazioni negative su tale riforma, che ha certamente contribuito ad una diffusione rilevante del numero dei rapporti a termine e a quella distorsione funzionale di questo modello contrattuale che ho già analizzato.
Nel 2018, il c.d. Decreto Dignità ha introdotto modifiche ispirate ad un netto restringimento della possibile utilizzazione del contratto a termine, con la riduzione del tetto massimo da 36 a 24 mesi, il mantenimento della acausalità del contratto nei primi 12 e la previsione di specifiche ragioni tecniche ed organizzative molto restrittive necessarie per stipulare il contratto dopo i 12 mesi e nel limite massimo di due anni. Il netto sfavore per il contratto a tempo determinato è dimostrato dal fatto che le causali necessarie per i contratti di durata superiore a 12 mesi erano talmente limitative da scoraggiare qualsiasi assunzione a termine. Si tratta di un'impostazione eccessivamente rigida da un lato e inidonea ad incidere su una reale riduzione dei contratti a termine dall’altro. La volontà di reintrodurre le causali era a mio giudizio positiva, ma era necessario non utilizzare ragioni così circoscritte, perché era sufficiente ribadire il carattere temporaneo delle ipotesi normative, in coerenza con le esigenze scaturenti dal mondo della produzione di beni e servizi. Inoltre, l’assenza di qualunque spazio alla contrattazione collettiva nella introduzione di ipotesi tecniche ed organizzative per la stipula del contratto inibiva la tecnica della “flessibilità contrattata” che aveva dato una buona prova in passato nella sua capacità di adattare la disciplina legale ai diversi contesti settoriali dell’economia. La riforma, inoltre, anche se è riuscita, in fase transitoria, a incrementare in misura consistente i rapporti di lavoro stabile (ne ho già parlato in precedenza), nel lungo periodo non era in grado di ottenere i risultati sperati. I dati del Ministero del lavoro del 2018 (riferiti al 2017) mettevano in evidenza che, nelle nuove assunzioni, vi era un’attivazione di contratti termine pari al 70% e che, tra questi, solo il 16,8% aveva una durata superiore ad un anno. Dunque, lasciare la acausalità del contratto sino a 12 mesi, significava, per il futuro, incidere solo su una quota minoritaria di rapporti a t. determinato, mantenendo praticamente immutata la situazione del mercato del lavoro. La disciplina, quindi, si poneva in contraddizione con l’intento di ridurre l’uso di questa tipologia contrattuale.
La normativa attuale ha in parte ridotto le rigidità della riforma del 2018. È stata confermata la acausalità del contratto per i primi 12 mesi e il tetto massimo di 24 mesi. Si è ridato spazio alla contrattazione collettiva (art. 19, c. 1, lett. a) e b), ma anche alla autonomia individuale in generale e in via transitoria (sino al 31 dicembre 2025) o in relazione a causali specifiche (la sostituzione di altri lavoratori). La nuova disciplina, molto enfatizzata dal Governo sotto il profilo mediatico per la sua capacità di nuova regolazione della materia, in